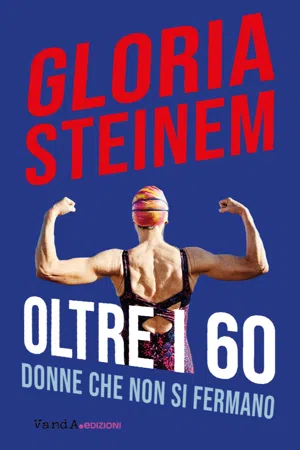![]()
Fare sessant’anni
Appartengo a una generazione di donne mai esistite. Mai nella storia… donne al di fuori della famiglia, che la società vorrebbe silenziare… È ora di alzare la testa e guardare il panorama dalla sommità della collina, una visione di tutta la scena mai avuta finora.
Barbara Macdonald (1913-2000)2
Si suppone che l’età porti con sé maggiore serenità, calma e distacco dal mondo, no? Bene, io credo sia vero l’esatto opposto. Più invecchio, più si fanno intensi i miei sentimenti per il mondo che mi circonda. Mi sento sempre più connessa alla natura, malgrado un tempo preferissi la creatività umana; mi commuovono sempre di più non solo le persone molto anziane, ma anche i bambini; aumenta la probabilità che io mi arrabbi quando le persone vengono invisibilizzate e tendo sempre più a reclamare il posto che mi spetta; sono più propensa ad arrischiare un “no”, anche quando dire “sì” significa incassare l’approvazione altrui. Soprattutto, sono più capace di usare la mia voce, di capire quello che sento e di dire quello che penso. In breve, finalmente riesco a esprimermi senza dovere anche persuadere gli altri.
Una parte di questo percorso è soltanto mia e trovo entusiasmante la sensazione solitaria, da confini del mondo, di avventurarmi in un territorio sconosciuto con il vento che mi fischia nelle orecchie. Chi avrebbe mai immaginato che proprio io, un tempo la persona più estroversa del mondo, potessi pensare alla meditazione come a uno strumento rivoluzionario (nel senso che, senza un’autorità interiore, non possiamo reggere il confronto con un’autorità esterna)? O considerare l’esplorazione dello spazio interiore più importante di quella dello spazio esterno? O scandalizzare persino alcune femministe sostenendo che alcune barriere sono anche interne? O dare voce a pensieri opposti, come: “L’unica forma durevole di controllo delle armi è il modo in cui alleviamo i nostri figli”?
Per altro verso, so che si tratta di una fase comune a molte persone. Sto esplorando l’altra metà del cerchio – una cosa particolarmente difficile da fare all’interno di questa cultura binaria che tenta di ridurci a un’unica funzione per tutta la vita e tratta il cambiamento come se fosse un ripudio del passato. Tuttavia, vedo sempre più persone dirette verso un futuro che si costruisce sulla base del passato, pur essendo molto diverso da esso. Vedo molte donne che hanno dedicato gli anni centrali della loro vita a un lavoro creativo solitario o alla cura dei mariti e dei figli – e anche alcuni uomini indotti, dal proprio lavoro o dal proprio carattere, a centrarsi su se stessi – scoprire il mondo esterno dell’attivismo, della politica e delle cause tangibili con lo stesso entusiasmo che provo io quando mi avvicino alla comprensione di cause meno tangibili. Vedo molti uomini che hanno trascorso la maggior parte della vita a lavorare per ottenere riconoscimenti esterni, spesso a spese della propria crescita o di quella dei loro figli, che ora si occupano di seconde famiglie e della propria vita interiore – e alcune donne che stanno facendo la stessa cosa, perché avevano bisogno di fare l’inatteso prima di sentirsi meno intrappolate dalle aspettative sociali.
Sto scoprendo anche una nuova prospettiva dovuta all’allontanamento dagli anni centrali della vita e riesco a comprendere più chiaramente il potere tirannico delle aspettative sociali che mi sono lasciata alle spalle. Noi donne in particolar modo – ma anche gli uomini, se sono stati limitati dagli stereotipi – abbiamo superato quella fase dell’esistenza in cui la società si interessa moltissimo a ciò che facciamo. Gran parte del nostro valore sociale si è spento intorno ai cinquant’anni, quando le forze giovanili legate alla sessualità, alla cura dei figli e al duro lavoro si sono esaurite, per lo meno in base ai parametri di una cultura che assegna questi ruoli. E, ad ogni buon conto, le poche posizioni di rilievo riservate agli anziani e ai saggi raramente spettano a noi. Per quanto all’inizio questo disinteresse e questa invisibilità possano scioccarci, addolorarci e darci l’impressione di un «periodo in caduta libera», per usare l’espressione di Germaine Greer, questa condizione crea anche una nuova libertà di essere noi stesse – senza dover dare delle spiegazioni. Come osserva Greer al termine di La seconda metà della vita, il suo libro sulle donne e l’invecchiamento, «il climaterio segna la fine delle scuse. La crisalide del condizionamento deve rompersi una volta per tutte e la donna finalmente ne emergerà».3
Da questa nuova prospettiva mi rendo conto che la mia idea secondo cui l’età porta con sé il distacco probabilmente altro non era che uno dei tanti pregiudizi concepiti per marginalizzare i gruppi più anziani. Si tratta di un pregiudizio forse anche più autodistruttivo degli altri – e su una scala molto più ampia – perché, presto o tardi, raggiungerà tutte noi. Abbiamo permesso a una cultura centrata sulla giovinezza di estraniarci dai nostri sé futuri al punto che, se interrogate sugli anni che seguono i cinquanta, i sessanta o i settanta – una parte integrante dell’arco della vita umana, se riusciamo a sfuggire alla fame, alla violenza e ad altre epidemie –, molte persone riescono a vedere soltanto uno schermo vuoto o, al limite, uno schermo su cui proiettano uno stato di malattia e di dipendenza. L’incompletezza di questa mappa sociale rende l’ultimo terzo della vita un paese sconosciuto: lascia gli uomini in panne non appena si conclude la loro vita lavorativa e, ancora prima, colpisce le donne. Soltanto un gruppo di femministe rumorose ci ha restituito la consapevolezza dei limiti di tale prospettiva, prendendo pubblicamente la parola per fare spazio a esperienze che un tempo rimanevano fuori dai suoi confini: esperienze che vanno da quello che Margaret Mead definiva l’“entusiasmo post-menopausa” alla scoperta che le accresciute aspettative di vita e il declino dei tassi di natalità stanno rendendo le persone anziane, e in particolare le donne anziane, una percentuale più elevata della popolazione in molti paesi, dall’Europa al Giappone, in una misura sconosciuta a epoche storiche precedenti. Spero di vivere fino al 2030 per vedere come saranno gli Stati Uniti quando una donna su quattro avrà sessantacinque anni o più, ovvero quando le donne anziane costituiranno un quinto della popolazione. Forse diventeremo come quelle robuste piante perenni che si “rinvasano” e fioriscono più volte.4
Sempre di più inizio a rendermi conto che la vita dopo i cinquanta o i sessant’anni è un altro paese, diverso come lo è l’adolescenza rispetto all’infanzia, o l’età adulta rispetto all’adolescenza – e altrettanto avventuroso. Per lo meno potrebbe esserlo, se non fosse un luogo di povertà per tante persone, in particolare per le donne oltre i sessantacinque anni, e di abbandono per i più. Affinché la terza età diventi un luogo di dignità e potere servirà un movimento imponente al pari di qualsiasi altro, come ci hanno spiegato già molto tempo fa alcune pioniere. Nel 1970, all’età di sessantaquattro anni, Maggie Kuhn fondò le Pantere Grigie e si rese conto che i giovani potevano essere alleati delle persone molto anziane più affidabili degli adulti, che in genere si arrogano il diritto di decidere sia per i propri figli che per i propri genitori. L’attivista e scrittrice Barbara Macdonald si è servita della sua posizione di lesbica estranea al recinto patriarcale per avvertirci che il femminismo non è riuscito a riconoscere le donne anziane come un centro vitale dell’attivismo e della teoria femminista.5 Intere generazioni di quella che Alice Walker ha definito la “tradizione Big Mama” nella comunità nera ci hanno fornito modelli di donne anziane energiche, vigorose e politicamente attive. Alcuni studi pioneristici ci hanno suggerito di affrontare la paura d’invecchiare considerando più attentamente questa nuova fase della vita. Vent’anni fa, per esempio, il Carnegie Corporation’s Aging Society Project formulò la seguente previsione: «L’aumento di circa trentacinque anni dell’aspettativa di vita nel XX secolo è talmente significativo da far quasi pensare a una mutazione della specie».6
Forse non disponiamo ancora di una cartografia di questo paese sconosciuto, ma altri movimenti possono fornirci una bussola. In ogni campo il progresso sembra consistere di tappe simili: anzitutto, uscire dall’invisibilità dichiarando l’esistenza di un gruppo che condivide una serie di esperienze; quindi rivendicare per sé il potere di nominare e definire quel gruppo; poi un lungo processo di coming out da parte di individui che si identificano con esso; poi inventare nuove parole per descrivere esperienze che prima non avevano un nome (per esempio, l’ageismo); poi fare uscire dalla marginalità questa nuova visione e renderla popolare con una serie di mezzi che vanno dalla promulgazione di nuove leggi alla costruzione di una base politica simile a un paese nel paese; infine, fare in modo che il movimento resti sia un baluardo di speranza per immaginare il futuro di un mondo inclusivo, sia una fonte collettiva di autostima, conoscenza condivisa e sostegno reciproco.
Pensate alla pressione che ci induce a “passare” mentendo sulla nostra età, per esempio. Si tratta della tentazione diffusa di falsificare la propria condizione di nascita o la propria identità fingendo di appartenere a un gruppo più avvantaggiato. I neri di pelle chiara hanno inventato il termine passing, gli ebrei in fuga dall’antisemitismo hanno perfezionato quest’arte e il segreto sull’orientamento sessuale prolunga il supplizio. Simulare un’età inferiore a quella reale è probabilmente la forma di passing più incoraggiata, considerando che praticamente non esiste una forma di sostegno organizzato per la rivelazione della propria vera identità generazionale. Ho ceduto anch’io a questa tentazione autodistruttiva intorno ai trent’anni, prima d’incontrare il femminismo, quando ho finto di essere più giovane per ottenere un incarico e scrivere un reportage su quello che all’epoca veniva presentato come un lavoro prestigioso, la coniglietta di Playboy, in realtà un lavoro sottopagato da cameriera che per di più prevedeva l’obbligo di indossare un costume che era una tortura.7 Nella confusione che ne derivò circa la mia età, l’uomo con cui vivevo ci mise tutta la buona volontà per tenere in piedi la finzione (era stato sposato con un’attrice da cui aveva imparato che è una follia, per una donna, dichiarare la propria vera età). Lo stesso fecero alcuni dei figli di mia sorella, convinti che la loro madre e io fossimo più giovani di due anni. Io stessa ho continuato ad attribuirmi due anni di meno per un paio di miserabili anni. Ho capito che falsificare questo aspetto della mia vita mi faceva sentire ipocrita, ridicola, complice e, quel che è peggio, partecipe di un vero e proprio auto-sabotaggio. Aveva tutto a che fare con lo scopo dell’impostura, naturalmente, perché mentire per ottenere l’incarico e scrivere il reportage era stato lo stesso tipo di impresa spudorata in cui mi ero imbarcata da ragazza, quando fingevo di essere molto più grande per avere un lavoro come commessa in un negozio di abbigliamento dopo la scuola o come ballerina da operetta. Falsificare la propria identità a causa dell’insicurezza e del bisogno di conformarsi non significa affatto sconfiggere i pregiudizi ageisti della società: significa, invece, permettere a quei pregiudizi di avere la meglio su di noi.
Ecco perché, quando ho compiuto quarant’anni, ho festeggiato pubblicamente, dando enorme risalto all’evento. Quando un giornalista mi disse gentilmente che non dimostravo i miei quarant’anni (un commento benintenzionato, ma ageista a pensarci bene), replicai con le prime parole che mi vennero in mente: «Questo è l’aspetto di una quarantenne. Abbiamo mentito tanto a lungo, chi può saperlo?». Quell’osservazione provocò talmente tante espressioni di sollievo da parte delle donne che iniziai a percepire la profondità e l’estensione dell’oppressione ageista, oltre alla forza persistente del doppio standard quando si tratta di età. Da allora ho imparato da molte donne che dissimulare e vivere costantemente con l’ansia di essere scoperte ha lo stesso effetto debilitante di un mal di denti – dal momento che si deve nascondere il dolore, cosa forse ancora più dannosa.
Ho incontrato donne che hanno infranto la legge falsificando il passaporto; che hanno limitato le proprie vite rifiutandosi di viaggiare, in modo da non doverne avere uno; che sono arrivate a dire agli uomini che avevano sposato, o con cui vivevano, di avere fino a dieci anni di meno; che hanno ingannato i figli che hanno allevato; o che hanno avuto madri la cui età si è scoperta soltanto al momento della morte. Ho ascoltato donne che lavoravano senza assicurazione sanitaria o piano pensionistico perché...