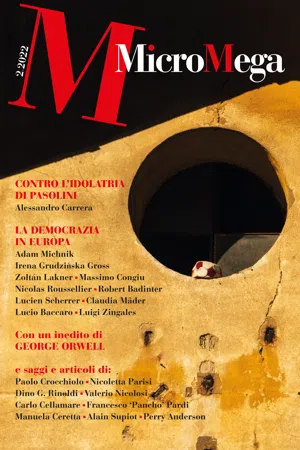![]()
saggio 1
IL NEOLIBERISMO DAVANTI AL TRIBUNALE DELL’EVOLUZIONISMO
Se considerato da un punto di vista strettamente evoluzionistico, il sistema economico neoliberista è profondamente irrazionale e contrario agli interessi della nostra specie. Esso impone infatti un prezzo molto alto da pagare – in termini biologici di sofferenza, non solo per la negazione dei diritti corrispondenti ai bisogni, ma anche per la devastazione ecologica che s’intreccia con il danno sociale – per mantenere a tutti i costi un’economia che ruota attorno ai privilegi di una minoranza.
PAOLO CROCCHIOLO
I. ECONOMIA DELL’EVOLUZIONE
Lo Stato del Queensland, nell’Australia nord-orientale, è sede di due delle maggiori meraviglie naturalistiche del globo: la Grande barriera corallina, che si estende per 2.300 km al largo delle sue coste sul Pacifico, e la grandiosa, lussureggiante foresta pluviale di Daintree, nelle immediate vicinanze della città di Cairns, sulla terraferma. Se si sale sulla piattaforma panoramica costruita all’interno della foresta, è possibile notare che le cime dei giganteschi alberi di Agathis robusta, una conifera alta come un grattacielo, raggiungono, tutte, quasi esattamente la stessa altezza.
Si tratta di una delle infinite dimostrazioni di come il principio economico del rapporto costi/benefici stia alla base dell’evoluzione. Concretamente, qualunque tratto, o insieme coordinato di tratti, geneticamente trasmissibile che dia come risultato finale un maggior numero di discendenti della sua portatrice o del suo portatore, viene per ciò stesso selezionato, mentre si estinguono più o meno rapidamente quei caratteri che si traducono in un numero di discendenti, rispettivamente, nullo o minore. L’unico parametro di riferimento su cui misurare la positività o negatività di un tratto o di un insieme di tratti si potrebbe quindi definire come il tasso differenziale di riproduzione da esso generato.
Far risalire l’acqua dalle radici attraverso il tronco fino a 50 metri d’altezza comporta un enorme dispendio di energia, ma è il prezzo da pagare per esporre le foglie a una quantità di raggi solari sufficienti a garantire un volume di fotosintesi clorofilliana adeguato alle necessità di quegli alberi. Ecco perché nei millenni si sono gradualmente selezionate quelle piante che raggiungevano la stessa altezza delle vicine, andando invece incontro all’estinzione sia le più basse, per insufficiente apporto di luce, sia le più alte, perché sfavorite nella competizione con quelle energeticamente più efficienti. Il punto d’equilibrio ha finito così per stabilizzarsi attorno all’altezza risultante dal minimo costo in termini energetici necessario per ottenere il massimo beneficio in termini d’insolazione.
La vita sulla Terra si era sviluppata in assenza di ossigeno nei primi tre dei quattro miliardi di anni dalla sua comparsa e pertanto nessun microrganismo era geneticamente attrezzato per resistere all’ossidazione. Ma una volta che l’atmosfera si riempì di tale gas, inizialmente a opera dei cianobatteri e poi delle piante, il mutato ambiente selezionò organismi, dapprima ossigeno-tolleranti e poi addirittura ossigeno-dipendenti, tra cui noi stessi. Parallelamente, i microrganismi sensibili all’ossigeno diminuirono sino a ridursi oggi, prevalentemente, ai batteri anaerobi obbligati o aerofobi, produttori di spore, tra cui principalmente i clostridi (agenti di tetano, botulismo e talune gravi forme di colite). Ma anche in questo caso l’adattamento al gas ossigeno, frutto di compromesso evolutivo, non fu indolore: benché prevalgano i benefici, in primo luogo l’energia che esso fornisce per tutte le funzioni vitali a partire dal movimento, notevolissimi sono anche i costi, rappresentati dalla formazione dei radicali liberi in seguito al progressivo logorio ossidativo dei tessuti. Si potrebbe affermare che l’ossigeno è quell’elemento che ci fa vivere e al tempo stesso, lentamente, ci fa morire.
La grande diffusione del diabete nel mondo è dovuta anch’essa a un bilanciamento “al ribasso” tra le opposte esigenze di dover resistere, mediante l’iperglicemia persistente da esso indotta, a lunghi periodi di digiuno senza morire di coma ipoglicemico acuto, rispetto al rischio di soccombere alle inevitabili complicanze croniche della malattia prima dell’età della riproduzione. Allorché c’è la possibilità di un’alimentazione regolare, la situazione ovviamente si capovolge, in quanto viene a mancare il fattore selettivo del digiuno per cui i non diabetici, vivendo in media più a lungo, hanno maggiori probabilità statistiche di prolificare, trasmettendo ai figli i geni deputati alla produzione e secrezione dell’insulina.
Richard Dawkins, nel suo libro Il più grande spettacolo della Terra1, presenta, a illustrazione di questo stesso meccanismo, la dinamica che s’instaura fra due popolazioni, l’una di potenziali prede erbivore come le gazzelle e l’altra di predatori carnivori come i leoni. Nel volgere di poche generazioni, a seconda del fattore selettivo costituito dalla maggiore o minore presenza di leoni nei paraggi, prevalgono rispettivamente le gazzelle dotate di zampe più sottili e fragili, ma che permettono una maggiore velocità, oppure quelle con le zampe più robuste e stabili, ma meno veloci. Sta di fatto che anche in questo caso, come in quello dell’altezza degli alberi della foresta pluviale, si stabilisce una competizione (del tutto involontaria, ovviamente), invece che fra i geni omologhi degli uni e degli altri alberi, fra i geni dei predatori e quelli delle prede, che portano nel corso delle generazioni a una stabilizzazione attorno a una velocità massima molto simile raggiungibile da entrambe le specie, ma a costo di andare incontro a inconvenienti non secondari, quali ad esempio la maggiore probabilità di fratture di zampe per le gazzelle rese in tal modo più fragili. Il fattore selettivo in questo caso è costituito dalla densità dei predatori che rende meno probabile, nelle prede dalle gambe sottili, la morte per cattura rispetto alla possibilità, altrettanto fatale, di spezzarsi una zampa prima dell’età della riproduzione, proprio come nel diabete il digiuno rappresenta il fattore selettivo che nei diabetici rende meno probabile la morte per coma ipoglicemico rispetto alla morte per complicanze della malattia prima dell’età della riproduzione.
Gli istinti
Anche lo sviluppo e le manifestazioni del sistema neuro-ormonale, negli animali che ne sono provvisti, rientrano nella logica evoluzionistica dei costi/benefici che sta alla base del processo della selezione naturale.
A questo proposito è necessario aprire una parentesi per descrivere i meccanismi che hanno portato alla formazione dell’emotività e, più in particolare, dei riflessi e degli istinti.
Nella dinamica del vivente, il dato di partenza che condiziona tutto il resto è la propagazione del DNA e dei suoi segmenti funzionalmente attivi, i geni. Questi, per sopravvivere e riprodursi, hanno bisogno di costruire attorno a sé macchine viventi capaci di trasferirli ad altre macchine altrettanto efficienti. Ma per riprodursi, ogni essere vivente deve prima di tutto sopravvivere abbastanza a lungo per raggiungere lo stadio di crescita che ne permette la riproduzione. A sua volta, per raggiungere tale stadio, è necessario che il corpo, portatore degli stessi geni che lo fabbricano, sia in grado di sopravvivere nell’ambiente esterno e, soprattutto, di mantenere al suo interno un equilibrio omeostatico capace di evitarne la dissoluzione. Già i viventi costituiti da una sola cellula hanno potuto e possono sopravvivere e riprodursi solo a condizione di resistere all’ambiente esterno facendo ricorso a una parete batterica (nei procarioti) o a una membrana cellulare (negli eucarioti), ma ancor più stabilizzando (nel caso di questi ultimi) il milieu intérieur del citoplasma mediante sottili regolazioni biochimiche del pH, della pressione osmotica, della temperatura, della composizione dei fattori nutritizi da integrare e dei rifiuti da espellere eccetera. Questi stessi meccanismi diventano man mano più complessi negli organismi multicellulari, ma il principio di fondo rimane lo stesso: la potenziale sopravvivenza, almeno fino al momento della riproduzione, dell’involucro fenotipico che i geni costruiscono attorno a sé stessi.
Ora, come tutti gli altri organi e apparati corporei, anche il cervello, anzi il sistema neuro-ormonale degli animali che ne sono dotati, nasce e si evolve in questo contesto e in funzione di tali esigenze. Infatti, tale sistema non rappresenta che l’ultima tappa di un lunghissimo percorso evolutivo che parte dalla membrana cellulare dei protozoi, antenati comuni a tutti gli organismi attualmente viventi, dopo aver enormemente affinato le capacità motorie, sensoriali e reattive di quest’ultima, ma mantenendo essenzialmente le stesse funzioni d’interfaccia col mondo esterno da un lato, e di regolazione del milieu intérieur dall’altro.
Il cervello dunque, secondo Antonio Damasio2, dal punto di vista evoluzionistico non sarebbe che uno strumento man mano sempre più perfezionato, funzionale al mantenimento in vita e alla potenziale capacità riproduttiva del corpo d’appartenenza. Attraverso i sensori propriocettivi diffusi a tutto l’organismo, esso sottopone a un incessante monitoraggio tutti i parametri vitali di organi, apparati e sistemi operanti nella macchina vivente (pH, temperatura, imbibizione dei tessuti, glicemia, concentrazioni di calcio, potassio eccetera), traducendone i vari livelli in sensazioni che vanno, passando attraverso tutte le gradazioni intermedie, dall’estremo benessere al più profondo malessere quanto più tali livelli si collocano, rispettivamente, all’interno di quelli che garantiscono l’integrità della macchina corporea o, viceversa, si avvicinano a quelli incompatibili con la vita. Secondo Damasio3, vi è anzi una sorta di corrispondenza biunivoca tra stato di benessere percepito ed equilibrio omeostatico dei parametri vitali, nel senso che l’alterazione di uno o più parametri omeostatici si tradurrebbe in uno stato di malessere, più o meno inconsciamente percepito dal sistema della gratificazione posto all’interno delle aree cerebrali evolutivamente più antiche del sistema limbico, mentre uno stato di malessere per cause esterne si tradurrebbe nell’alterazione di uno o più parametri omeostatici dell’organismo corporeo. D’altra parte, la “coloritura emotiva” è così profondamente radicata nel sistema neuro-ormonale selezionato nel corso dell’evoluzione da permeare, nel caso del cervello umano, persino i discorsi apparentemente più aridi e astratti4. Per citare ancora Damasio, noi «non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano»5.
In questo contesto si collocano i riflessi e gli istinti, i quali possono essere definiti come associazioni geneticamente trasmissibili di «tonalità edonistiche»6 positive o negative (ovvero sensazioni piacevoli o dolorose) con percezioni e azioni risultate in passato, rispettivamente, favorevoli o sfavorevoli alla sopravvivenza e alla riproduzione. Un tipico esempio di istinto è quello dell’allattamento nei mammiferi, per cui solo i neonati che associavano a esso una sensazione di piacere hanno potuto trasmetterne i relativi geni perché solo essi erano in grado di crescere e raggiungere l’età della riproduzione a differenza di quelli che l’associavano a una sensazione sgradevole o dolorosa. Lo stesso si può affermare rispetto all’associazione della tonalità edonistica del piacere con l’atto sessuale. Persino l’altruismo può risultare gratificante, soprattutto considerando la comunanza di geni dell’individuo o degli individui che ne sono oggetto con quelli di chi lo esercita.
Il sesso che ci fa tanto feroci
Vi è oggi ampio consenso tra gli scienziati sul fatto che, centinaia di milioni di anni fa, la riproduzione sessuata nei pluricellulari s’impose su quella asessuata, cioè per divisione binaria, grazie al decisivo vantaggio rappresentato dal rimescolamento dei geni, e quindi dalla continua generazione di varianti che ne consegue, vantaggio prodotto dalla prima e non dalla seconda. Infatti, essendo il tasso di mutazioni dovute ai raggi cosmici uguale per tutti gli organismi, esso risulta sufficiente per creare biodiversità nei monocellulari, procarioti o eucarioti che siano, in virtù del loro numero e della loro velocità di riproduzione nell’unità di tempo, entrambi di un ordine di grandezza esponenzialmente superiore rispetto ai pluricellulari, in cui invece le mutazioni risulterebbero insufficienti se fossero l’unico fattore generatore di biodiversità. E ciò, nonostante il meccanismo della meiosi, alla base della riproduzione sessuata, sia molto più complicato della mitosi che realizza quella asessuata; senza contare la difficoltà di far incontrare due gameti generati da due organismi fisicamente separati (negli animali ciò avviene per incontro diretto e presuppone il movimento ma anche l’attrazione, che a sua volta implica per corollario quel sottoinsieme della selezione naturale che è la selezione sessuale; mentre nelle piante che sono legate al terreno, provvedono il vento o gli insetti vettori. Per inciso, per i vegetali l’immobilità è il “prezzo da pagare” per poter accedere direttamente all’energia mediante la fotosintesi clorofilliana, mentre per gli animali la perpetua, affannosa ricerca del cibo è il prezzo da pagare per la mobilità. E, per ulteriore inciso, procurarsi l’energia necessaria a sopravvivenza, crescita e riproduzione non è che il presupposto e, al contempo, l’essenza stessa dell’economia della vita).
Detto questo, che legame c’è fra le dimensioni dei gameti e le guerre di religione? Posta così, la domanda sembra assurda; invece, una serie di fattori concatenati l’uno all’altro nel corso dell’evoluzione possono spiegarcene le ragioni. Originariamente, come sostiene Giorgio Vallortigara7, le cellule germinali, portatrici ciascuna del 50% dei geni presenti nel genoma di una data specie, avevano eguali dimensioni, erano cioè isogameti. Successivamente, in seguito a quella sorta di clinamen per cui uno dei due isogameti cominciò a trattenere una maggior quantità di citoplasma e di organelli citoplasmatici, l’altro dovette evolutivamente compensare quello svantaggio con una riduzione delle dimensioni che però comportava una maggiore mobilità. Il distacco si allargò fino a giungere, a un’estremità dello spettro, a una cellula uovo immobile e di enormi dimensioni (un uovo di struzzo è costituito da una sola cellula!) e, dall’altra, a un’infinità di spermatozoi mobilissimi e ridotti al volume minimo indispensabile, ossia a poco più del semplice DNA da essi veicolato. Una volta imbrigliati in questa sorta di percorso obbligato da essi stessi messo a punto, i geni, per propagarsi, dovevano salire a bordo dei loro gameti-navette (non essendoci altro modo per essere trasmessi alla generazione successiva) e al tempo stesso erano costretti a costruire attorno a sé organismi-portatori, non solo in funzione della semplice sopravvivenza propedeutica alla riproduzione, ma anche in funzione delle esigenze dei loro gameti. Nell’economia della riproduzione, infatti, il principio del rasoio di Occam regna sovrano: si seleziona esattamente ciò che serve, senza inutili sprechi. I geni che finiscono per essere selezionati sono quelli che seguono la via più diretta e col minimo dispendio di energia, instillando semplicemente nelle macchine riproduttrici, loro strumento di propagazione, l’istinto all’accoppiamento; tanto che la nascita di qualunque animale sessuato potrebbe essere definita come un possibile effetto collaterale del piacere. Istinto all’accoppiamento, infatti, non significa istinto alla riproduzione (che di per sé non esiste anche perché non ce n’è alcun bisogno una volta che è presente il primo): nessun altro animale, del resto, è consapevole del collegamento fra accoppiamento e riproduzione.
Tutti i tratti somatici, ma anche quelli istintivi, che distinguono i due sessi nelle specie a riproduzione sessuata sembrano dunque originare da fattori quantitativi quali le dimensioni, il numero e la mobilità dei rispettivi gameti, attorno alle cui esigenze essi sono stati selezionati. I geni degli individui maschili emersi dalla selezione sono quelli che instillano nei loro portatori istinti atti ad assicurare la loro stessa propagazione in competizione con gli altri maschi e spargendo ad ampio raggio enormi quantità di spermatozoi, mentre quelli femminili suggeriscono alle loro portatrici l’intelligenza di scegliere partner che valorizzino il più possibile il prezioso investimento genetico da esse custodito e nutrito (l’uovo e, nei mammiferi, anche il prodotto del concepimento). Nell’essere umano, la rivalità fra maschi e soprattutto la tendenza a garantire che i figli siano i propri, segregando le femmine o comunque impedendo con ogni mezzo che vengano inseminate da altri (giungendo fino all’orrenda sevizia dell’infibulazione), è stata trasfusa ai costumi sessuali e da questi a rigide norme ideologiche o religiose, finendo per rappresentare quelle che Wilson chiama «iperestensioni culturali»8. Un tipico esempio d’iperestensione culturale è la creazione...