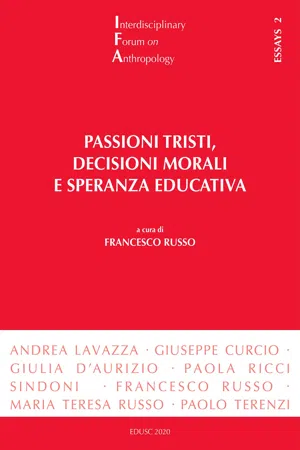
- 120 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Passioni tristi, decisioni morali e speranza educativa
Informazioni su questo libro
Una via di uscita dalla palude dello sconforto. Questo è l'obiettivo indicato dagli autori del presente libro, come spiega bene Andrea Lavazza nella sua Presentazione. Le "passioni tristi", diagnosticate da M. Benasayag, sono qui analizzate nella loro forma di crisi nella trasmissione generazionale, di antiautoritarismo istintivo, di eccessive pretese funzionalistiche dinanzi a un futuro percepito come minaccioso e di commercializzazione della cultura. Gli autori, però, puntano soprattutto al superamento di tale situazione e si avvalgono delle proprie competenze di psicologia, etica, antropologia e sociologia: prospettano, quindi, le pratiche gioiose che, in una visione antropologica integrale, possono condurre oltre la delusione e l'abbandono. Vi sono contenuti saggi di A. Lavazza, G. Curcio, G. D'Aurizio, P. Ricci Sindoni, F. Russo, M.T. Russo e P. Terenzi.
Francesco Russo è Professore Ordinario di Antropologia della cultura e della società nella Facoltà di Filosofia della Pontificia Università della Santa Croce. È il coordinatore dell'Interdisciplinary Forum on Anthropology (Ifa).
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Passioni tristi, decisioni morali e speranza educativa di Francesco Russo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Antropologia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Scienze socialiCategoria
AntropologiaIl ruolo dell’esemplarità nell’educazione morale: pratiche gioiose contro le “passioni tristi”
Maria Teresa Russo
Università Roma Tre
Dipartimento di Scienze della Formazione
1. L’educatore di fronte alle nuove sfide culturali
Le metafore tradizionalmente utilizzate per suggerire il compito educativo – da quella agricola a quella idraulica, da quella ortopedica a quella informatica – oggi risultano insufficienti, sia per le caratteristiche delle giovani generazioni che per l’attuale clima culturale, o forse non sono mai state pienamente adeguate. Coltivare interessi, innescare processi, correggere deviazioni, introdurre conoscenze, sono tutte azioni sicuramente pertinenti al lavoro educativo, ma non ne costituiscono più la sostanza né sono oggi sempre praticabili. Edgar Morin, nell’ultimo saggio della sua trilogia dedicata all’educazione72, associa significativamente la domanda ben nota posta da Jonas – “Quale pianeta lasceremo ai nostri figli?” – riguardante la responsabilità ecologica nei confronti delle generazioni future, a un interrogativo che ricorda l’altrettanto essenziale responsabilità educativa degli adulti verso i giovani: “A quali figli lasceremo il mondo?”.
Già alcuni decenni fa Aviram73 aveva messo in luce come il relativismo, l’orizzontalismo e il pluralismo, caratteristici del clima culturale contemporaneo, avessero incrinato i pilastri dei sistemi educativi tradizionali. Ve ne sono alcune evidenti manifestazioni: il declino del riferimento alla trascendenza dei valori di fronte alla loro privatizzazione; l’attenuarsi della distinzione tra giovani e adulti; la perdita di prestigio dell’istruzione come trasmissione di conoscenze oggettive di fronte al sapere tecnocratico e agli scopi pragmatici; la crisi della struttura gerarchica delle istituzioni educative; la funzione sempre meno importante del libro e della lezione, di fronte alla multifunzionalità della comunicazione e del sapere digitale74.
D’altra parte, non vanno trascurati elementi positivi, come ad esempio la caduta dell’antica barriera fra cultura umanistica e saperi tecno-scientifici, giacché si avverte con maggiore urgenza la necessità di una comprensione globale della realtà e della vita stessa. Si è infatti sempre più consapevoli che mentre agli esordi dell’era della comunicazione la minaccia era costituita dall’incomunicabilità, oggi lo è l’incomprensione non soltanto fra stranieri, ma anche tra membri di una stessa società e di una stessa famiglia.
Il compito dell’educazione pertanto non è semplicemente quello di offrire una spiegazione del mondo e di sé in termini concettuali e oggettivi, ma di favorire una comprensione umana, che esige attenzione ai nessi e ai significati ed è sempre anche intersoggettiva, in quanto richiede l’apertura verso l’altro75. Vanno pertanto respinte concezioni e pratiche educative che favoriscono quella parcellizzazione del sapere priva di un principio di selezione e di organizzazione che gli dia senso, ossia il pensiero frammentato e frammentante, «l’intelligenza che sa solo separare spezza il complesso del mondo in frammenti disgiunti, fraziona i problemi, unidimensionalizza il multidimensionale»76. Se non si fanno emergere le domande sull’umano, i risvolti sono gravi non soltanto dal punto di vista cognitivo ma anche dal punto di vista etico, in quanto «un’intelligenza incapace di considerare il contesto e il complesso planetario rende ciechi, incoscienti e irresponsabili»77. La perdita dello sguardo sull’insieme comporta l’affievolirsi del senso di responsabilità; la tendenza alla riduzione produce incomprensione.
La questione fondamentale con la quale l’impresa educativa è chiamata a confrontarsi non è soltanto la generale mancanza di un senso unificante della vita e della realtà, ma lo svuotamento stesso della domanda di senso. In altri termini, questa domanda rischia di diventare superflua e insignificante, a causa del relativismo e del nichilismo. Allan Bloom lo rilevava già alcuni decenni fa, in un fortunato e profetico saggio, a torto tacciato di conservatorismo: «C’è una sola cosa di cui un professore può essere assolutamente certo: quasi tutti gli studenti che entrano nell’università credono, o dicono di credere, che la verità è relativa. Se si mette alla prova questa convinzione, si può essere certi della loro reazione: non capiranno. Li stupisce che qualcuno non consideri assiomatica questa affermazione, come se mettesse in dubbio che due più due fa quattro... Sono unificati solo dal loro relativismo e dalla loro fedeltà all’uguaglianza. E questi due elementi sono uniti in un’intenzione morale. La relatività della verità non è una percezione teorica, ma un postulato morale, la condizione di una società libera, o almeno così essi ritengono... Il relativismo è necessario per l’apertura mentale; e questa è la virtù, l’unica virtù che l’istruzione primaria per più di cinquant’anni si è impegnata a conculcare»78.
Del resto, già mezzo secolo fa i Minima moralia di Adorno si aprivano con l’ammissione di una sorta di fallimento, dovuto proprio alla rinuncia da parte della filosofia di avanzare una proposta etica valida. Da qui la sua trasformazione in “triste scienza”: «La triste scienza, di cui presento alcune briciole all’amico, si riferisce ad un campo che passò per tempo immemorabile come il campo proprio della filosofia, ma che, dopo la trasformazione dei metodi di quest’ultima, è caduto in preda al disprezzo intellettuale, all’arbitrio sentenzioso, e infine all’oblio: la dottrina della retta via» 79.
2. Oltre le “passioni tristi” degli educatori
La questione della verità dunque si presenta oggi come prioritaria, condizione necessaria di un lavoro educativo che non sia dominato né dalla “triste scienza” né dalle “passioni tristi”. Secondo l’efficace espressione di Benasayag e Schmit80, queste ultime sono rappresentate dal «cambiamento di segno del futuro»81, che a causa delle promesse non mantenute dalla modernità, da futuro-promessa si è trasformato in futuro-minaccia. Ne consegue una sensazione di impotenza e di fatalismo, che è incompatibile con la fiducia e la speranza, elementi irrinunciabili del lavoro educativo.
La vicenda raccontata nel romanzo di Antonio Scurati, Il sopravvissuto, premio Campiello 2005, ci offre un esempio narrativo efficace di come il disincanto dell’educatore conduca inesorabilmente alla perdita di credibilità del suo stesso compito. La scena si apre in un’aula del liceo scientifico Sarpi di Casalegno, paese immaginario dell’h...
Indice dei contenuti
- Presentazione. Un filo nel vortice contemporaneo
- Decisioni morali e formazione accademica. Un primo studio empirico su una popolazione di studenti universitari italiani
- Delusione e abbandono. Note antropologiche ed etiche
- Speranza, felicità, verità .Per un’antropologia dell’autotrascendenza
- Il ruolo dell’esemplarità nell’educazione morale: pratiche gioiose contro le “passioni tristi”
- Benasayag e la critica al modello funzionalista di educazione