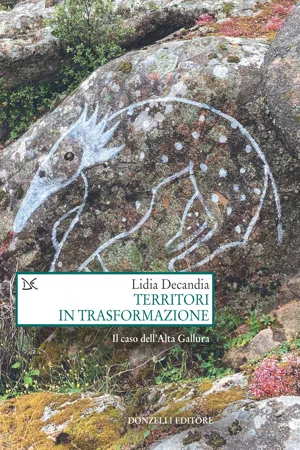
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Il libro, a partire dalla consapevolezza che le statistiche con cui siamo abituati a interpretare i territori non bastano perché non ci aiutano a cogliere i momenti di passaggio, ci invita a praticare un altro sguardo. Uno sguardo attento agli scintillii, agli stadi iniziali delle trasformazioni, su cui occorrerebbe soffermarsi per comprendere il divenire. Lo fa attraverso lo studio di una particolare area interna della Sardegna: l'Alta Gallura. Un contesto ultra periferico, secondo le categorie della Strategia nazionale per le aree interne; una delle aree meno illuminate del contesto nazionale, che si distende alle spalle del mondo delle luci della città costiera. L'autrice, facendosi guidare dagli indizi, dalle storie minime, dai dettagli, scopre che quel territorio buio è una realtà brulicante, in cui sottotraccia spingono sopravvivenze, forze ed energie che lavorano per produrre cambiamento. Raccoglie storie, progetti, osserva luoghi, forme di produzione, rileva il riemergere di sommovimenti provenienti dal sottosuolo della storia, e prova a far venire fuori l'immagine inespressa che queste linee di tendenza sembrano suggerire, mettendo in guardia sui pericoli che si annidano alla superficie del presente. Dal buio affiora una costellazione lampeggiante: una figura territoriale inedita, fragile, di cui invita a prendersi cura. Una ossimorica «città-natura» in cui il già stato si unisce con l'adesso e in cui si intrecciano città e campagna, natura e cultura.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Territori in trasformazione di Lidia Decandia in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Geografia umana. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Scienze socialiCategoria
Geografia umanaParte seconda
Una storia in divenire. Verso una riscoperta delle aree interne della Gallura alla ricerca di nuovi modi di abitare tra la campagna e il mondo
I. La prima riscoperta del mondo degli stazzi: sull’onda della contestazione alla ricerca di altre modalità di esistenza
A cinque tese sott’acqua
Tuo padre giace.
Già corallo
Son le sue ossa
Ed i suoi occhi
Perle.
Tutto ciò che di lui
Deve perire
Subisce una metamorfosi marina
In qualche cosa
Di ricco e di strano
William Shakespeare
Nella storia nulla di ciò che è avvenuto deve essere dato per perso.
Certo solo a una umanità redenta tocca in eredità il suo pieno passato.
Walter Benjamin
La discesa verso le coste, lo spopolamento dei centri dell’interno e l’abbandono delle campagne che in questi ultimi cinquant’anni sembrano caratterizzare il territorio gallurese, entrato ormai a far parte di quel mondo urbano che abbraccia l’intero universo, pur costituendo i fenomeni emergenti non rappresentano tuttavia le uniche dinamiche in atto presenti in questa peculiare regione storica della Sardegna. Mentre infatti le luci dello spettacolo sembrano sempre di più illuminare le aree più prossime al mare, se si affina lo sguardo ci si accorge che flebili bagliori aprono delle radure di luce nei territori bui e silenti delle aree interne: alcuni piccoli indizi rivelano movimenti nuovi che raccontano di un territorio ancora in divenire non riducibile a quell’immagine statica a cui i numeri delle statistiche vorrebbero abituarci. Mentre i centri dell’entroterra continuano a spopolarsi e le coste ad attrarre popolazione, si comincia a delineare, già da alcuni decenni e in forme poco appariscenti, ma per questo non meno significanti, un fenomeno nuovo tutto ancora da comprendere e decodificare che sembra ancora una volta rimettere in moto una stagione nuova per le aree interne del territorio gallurese.
Uno sciame di persone, talvolta in fuga da realtà metropolitane, alla ricerca di nuove modalità di vivere e abitare sta riscoprendo, infatti, in maniera inedita proprio quei buchi «densi di natura e di storia» (Maciocco 2011, p. 11) che lo spostamento della popolazione nei territori costieri aveva prodotto.
È soprattutto l’antico mondo degli stazzi diffusi nella campagna a essere il protagonista di una nuova forma di riappropriazione che delinea una interessante «controgeografia urbana» (Decandia, Cannaos, Lutzoni 2017, p. 165).
Sono proprio uomini urbani ammalati di velocità, spinti da un bisogno profondo di natura e di silenzio e da un desiderio di ristabilire rapporti più autentici con l’alterità ad arrivare in questi territori e a sperimentare modalità di abitare inedite in cui la scala locale e la scala globale sembrano interagire in forme originali, e in cui l’arcaico e il contemporaneo sembrano darsi un appuntamento segreto. Come i salmoni, risalgono controcorrente dalla costa verso l’interno, per riappropriarsi proprio di quelle «perle territoriali» che credevamo dimenticate. L’antica forma di abitare diffuso e dilatato sul territorio, messo a punto in Gallura sin dall’epoca nuragica e ribadito dalla diffusione degli stazzi, viene riscoperta da una popolazione nuova fatta di soggetti che arrivano non più da contesti locali, ma spesso internazionali.
Certo non possiamo parlare di grandi numeri, che abbiano il peso di una statistica, ma piuttosto di piccole storie che si stanno sempre più infittendo e che purtuttavia costituiscono «l’innesco minimo di un cambiamento» (Jullien 2010, p. 119), e che annunciano in filigrana una tendenza nuova. Potremmo parlare di flebili bagliori che lampeggiano, che si accendono e si spengono in questi territori popolati dal buio, dal vuoto e dal silenzio e che niente hanno a che vedere con le luci accecanti dello spettacolo che illuminano la città costiera. Tuttavia questi segnali minuti, che si insinuano nelle crepe messe in atto da quel complesso e contraddittorio processo di urbanizzazione che ha investito il territorio della Gallura, costituiscono, se saputi ascoltare, dei segnali rivelatori, degli indizi importanti, capaci di aiutarci a nutrire il nostro presente e a immaginare un futuro non scontato per questi territori.
1. Storie: i pionieri.
Questo fenomeno di nuovo ripopolamento delle campagne non nasce, come potremmo credere solo oggi, ma ha radici lontane. Radici che paradossalmente affondano proprio nel momento in cui gli effetti prodotti dall’invenzione della Costa Smeralda, nell’ambito dei processi più generali in atto a livello nazionale e internazionale di riorganizzazione del capitalismo mondiale, stavano svuotando la campagna e portando la civiltà dello stazzo a volgere al suo declino.
È proprio in quegli stessi anni, infatti, che alcuni segnali minimi, innesco di quel generale mutamento che forse solo oggi siamo in grado di percepire, cominciavano, a saperli guardare, a delineare un fenomeno inverso: una particolare riscoperta urbana della campagna.
Se è vero, infatti, che tra la seconda metà degli anni settanta e gli anni ottanta tutti gli indicatori ci parlano di un decisivo abbandono dell’attività agraria e del crollo della civiltà pastorale-contadina dell’antico mondo degli stazzi, alcune piccole storie ci raccontano di particolari e nuovi rarefatti arrivi in queste terre: pochi ma significativi. «Microforme nel vuoto» (Deleuze - Guattari 1987, p. 247). Si tratta di donne e uomini, che giungono da lontano, nella maggior parte dei casi da città cosmopolite italiane ed europee. Giovani, di media e alta borghesia, provenienti quasi tutti dai movimenti di contestazione sviluppatisi sull’onda del sessantotto che arrivano in queste terre mossi da una ricerca politico esistenziale, da un desiderio di ritrovare forme di rapporto nuovo con l’insieme dei viventi. Sono questi gli anni in cui comincia ad affermarsi un’etica ecologica volta a ricercare nuove forme di relazione fra uomo e ambiente (Moore 2015; Lanternari 2003; Latouche 2011; Shiva 2015). Un’etica che li porta a volersi svincolare dai legami con un sistema economico dominante e a ricercare proprio in queste aree più isolate – rimaste ai margini dello sviluppo, in gran parte abbandonate e proprio per questo «non dominanti ma neppure dominate, sottratte all’ambito della dominazione» (Castelli Gattinara 2017, p. 132) e in quanto tali libere – una possibilità di rigenerazione personale e sociale, un orizzonte esistenziale alternativo al modo di vita capitalistico e a quei modelli offerti dalla società dei consumi. Come ci insegnerebbero gli studiosi della microstoria1, proprio in quell’epoca caratterizzata dall’affermarsi del modello quasi totalizzante importato con l’invenzione della Costa Smeralda, scopriamo l’arrivo di alcune presenze dissonanti, storie individuali che testimoniano una varietà di posizioni non omologabili che preannunciano, in qualche modo, delle possibili linee di fuga che aprono altri orizzonti possibili per queste terre abbandonate.
Jurghen e gli altri
Subito dopo il Sessantotto arriva per esempio Jurghen da Heidelberg, come ci racconta Maria Viola che ha convissuto, dieci anni dopo, con lui in uno stazzo dell’Aglientu. Era scappato da quella città dove l’aria, dopo la contestazione di quegli anni si era fatta pesante con la diffusione delle droghe, con la volontà «di allontanarsi da quei giri» e ritrovare un rapporto più autentico con la natura. Arriva in Sardegna a febbraio «in pantaloni e maglietta, convinto che la Sardegna fosse un posto dove c’è sempre caldo» e si stanzia nelle campagne di Bassacutena. È forse uno dei primi. Nella seconda metà degli anni settanta arriva Camillo un ragazzo spagnolo. Da Madrid decide di trasferirsi all’Albidda, una frazione di Bortigiadas prima abitata, ma già in questi anni spopolata e in fase di abbandono. Arriva insieme a Emma (una ragazza romana con origini sarde) «per fare una vita diversa». Lui, proveniente da una famiglia spagnola molto benestante che aveva ricchi possedimenti in Galizia, scappa proprio per tagliare con la vita borghese familiare e per cercare una via diversa, svincolata dai ritmi imposti dalla civiltà dell’industria e del consumo, e un rapporto più intimo con la natura.
Anche Rainer, di famiglia austriaca – il padre era un industriale che possedeva fabbriche in Libia – scappa dalla sua terra per non fare il militare e arriva sempre nelle campagne di Bortigiadas insieme a Eva, la sua compagna «alla ricerca di una vita alternativa» e compra addirittura una casa, dove lo raggiungono anche un fratello e una sorella. «Sotto di loro abitava Georg, un ragazzo tedesco, a cui avevano dato un asinello, che – ricorda Maria Viola – mangiava tutte le cose crude che trovava: erbe, funghi, piante di tutti i tipi e qualità».
Tutti vivevano in simbiosi con la campagna e si nutrivano dei frutti della natura: «la stagione dei funghi, la stagione degli asparagi, conoscevano tutte le erbe»; realizzavano piccoli lavori artigiani, e partecipavano per mantenersi alle fiere e ai mercati estivi. «Camillo lavorava la pelle […] loro facevano i mercatini lavoravano l’ottone: facevano cinture, specchi che vendevano d’estate. Rainer faceva stufe con mattoni refrattari. Avevano tante idee anche dal punto di vista artistico. Rainer sapeva fare lavori in legno. Tutti in paese abbiamo fatto fare da loro un mobile o una cucina» (Maria Viola).
L’arrivo di questi giovani stranieri, e un generale passaparola, incuriosisce: fa sì che le campagne di Bortigiadas vengano scoperte anche «dagli alternativi di Sassari. Qualcuno compra addirittura una casa». Alcuni si trasferiscono qui, altri arrivano per i fine settimana. «Anche loro volevano in qualche modo sfuggire dalla borghesia da cui provenivano. Erano i Pinna, quelli delle farmacie, i Bagella, quelli del negozio di abbigliamento e poi altri di cui non ricordo il nome» (Maria Viola).
Per chi cercava uno stile di vita diverso, la Gallura, con i suoi ampi spazi, i suoi stazzi in parte abbandonati, testimonianza di una civiltà e di una economia autarchica, di cui per certi aspetti era ancora possibile cogliere le sopravvivenze culturali di un mondo che stava volgendo alla fine, rappresentava un territorio ideale. Anche perché lo spopolamento e la svalutazione simbolica del lavoro contadino avevano fatto sì che fosse possibile affittare e acquistare case e terreni a cifre ancora molto accessibili.
Alberto
Di questo territorio, caratterizzato da questa particolare civiltà, aveva sentito parlare anche Alberto che arriva invece nelle campagne di Tempio più tardi, nel 1981 con Carlotta, la sua compagna. Figlio di un imprenditore che realizzava mobili metallici, e «un po’ ribelle» come dice lui stesso, dopo il liceo scappa da Milano alla ricerca di una vita diversa. Fa una prima esperienza di «ritorno alla terra» in una comune umbra dove era arrivato quasi per caso (era andato a trovare degli amici e aveva deciso di fermarsi). Lì impara, insieme a Carlotta, a lavorare con gli animali, c’erano greggi di pecore e di capre, a fare il formaggio e a venderlo. Da questa prima esperienza – il suo master, come lo definisce lui stesso – durata quattro anni, intuisce di essere sulla strada giusta. Lo attraeva l’idea «di andare in campagna» di fare un lavoro autonomo, che lo rendesse autosufficiente. Gli piaceva «crearsi il cibo con il proprio lavoro e le proprie mani». Quando qualcuno gli parla dello stazzo gallurese, capisce che quello poteva essere il posto perfetto perché come lui stesso racconta:
Lo stazzo era proprio questo: una famiglia che viveva in campagna allevando i figli e producendo il proprio fabbisogno. Di soldi in quel mondo non se ne trattava molto. Non c’era in fondo bisogno: con i soldi ti potevi comprare gli attrezzi da lavoro, lo zucchero e il caffè da offrire agli ospiti, ma poi il resto veniva prodotto. Tutti avevano le api allevate in un modo molto primitivo che producevano gli zuccheri, tutti piantavano il grano, tenendolo ben separato dalle capre, dalle pecore, dalle vacche. Quello che allora mi aveva affascinato – continua a raccontare – era lo stazzo in toto, dove c’erano appunto tutte le strutture anche se molto piccole e primitive: c’era il posto dove tenevano i maiali, il recinto per le capre, quello per i capretti separati dalle mamme e poi c’era una particolare cultura espressa dalle peculiarità della lingua gallurese. È così che siamo arrivati in Gallura alla ricerca di un luogo in cui stanziarci. Le famiglie, forse non pensando che volessimo fare proprio sul serio, ci hanno aiutato a comprare un pezzo di terra con uno stazzo nelle campagne tempiesi. All’inizio è stata un’avventura. Per diversi anni non c’era neppure la luce. La prima cosa che feci fu comprare un gregge di pecore. Quando hai la terra è la terra che ti indica la strada: l’allevamento, l’orto e poi migliorare lo stazzo […]. Sono passati tanti anni, trentasei, e sono ancora qui.
Quel mondo degli stazzi che in quegli stessi anni veniva abbandonato dalla popolazione locale e svalutato anche simbolicamente dalla stessa società dei consumi viene paradossalmente riscoperto da un giovane che giunge da Milano alla ricerca di vie alternative possibili ai modelli veicolati in quegli anni: una scelta che apre un orizzonte inatteso per queste sopravvivenze del passato.
Alla ricerca della natura, del silenzio e di valori perduti
In quegli anni non arrivano nell’Alta Gallura solo giovani con l’intento di uscire dai circuiti dell’economia capitalista, ma uomini e donne alla ricerca, magari dopo una crisi personale o familiare, di modi di vita più autentici attraverso cui rigenerare sé stessi. Decidono di trasferirsi in Gallura perché attratti dalle caratteristiche ambientali di questo territorio, dal suo isolamento, dalle sue asperità, dal buio e dal silenzio, ma anche dalle culture profonde che caratterizzavano queste terre. Sono proprio questi giovani a cogliere per primi l’importanza e il valore delle sopravvivenze che rimandavano a quella cultura che in quel momento i media veicolavano come arretrata e passatista.
Adelaide
Adelaide, nata a Strasburgo e residente tra Friburgo e Bonn, biologa, con dottorato in zoologia, era arrivata per la prima volta in Sardegna nella metà degli anni sessanta con una borsa di studio e qualche anno più tardi, già innamorata di questa terra, decide di fare la sua tesi in Gallura. Il suo professore le affida l’incarico di verificare l’esistenza ed eventualmente di studiare uno dei mammiferi più piccoli del mondo lo Zuncus Etruscus. È così che arriva nelle campagne di Luogosanto dove insieme al marito compra un pezzo di terreno e costruisce una casa. Prima veniva solo per le vacanze, poi arriva un momento in cui, dopo una crisi familiare, decide nel 1979 di trasferirsi qui da sola, stabilmente. «Sono arrivata in un momento felice della Sardegna. Erano gli anni 1979-1980. Arrivavano già le comodità della modernità, cioè le lavatrici, le case erano più comode. Però vivevano ancora le vecchie tradizioni». Era stata attratta dalla profondità di questa cultura, dal valore dato ai legami, alle relazioni, ai momenti comunitari, alla ricchezza della vita sociale:
Mi ha colpito soprattutto il rapporto con la morte perché in Germania si usava quasi quasi ignorarla. Si c’era la morte e il funerale però questo star vicino era sconosciuto. Io, per esempio, ho visto morire Cannas e la moglie (i vicini di stazzo, che le avevano venduto il terreno). Li ho visti morire tutti e due. Ho assistito al momento della morte. Cioè eravamo legati in questa maniera che in Germania sarebbe impensabile, con uno che ti ha venduto un terreno. Questa esperienza mi ha fatto capire che qua la vita era diversa e aveva dei valori che noi non avevamo più. In questa terra la morte era parte della vita ed era per me una esperienza assolutamente nuova.
Non è solo il modo di vivere la morte, ma anche l’esperienza del mangiare insieme in maniera conviviale, magari in occasione delle feste nelle vecchie chiese campestri, che colpisce Adelaide:
C’era per esempio il Primo maggio la festa di Santu Micali […] io davo un contributo, andavo lì con una bandiera a cavallo. Giravano con due o tre cavalli attorno alla chiesa con le bandiere. Si partecipava in qualche modo e certamente alla fine c’era il pranzo. Il pranzo era una cosa fondamentale, assolutamente. Quattro agnelli arrosto. Cose bellissime naturalmente. Per noi questa cosa delle feste campestri era assolutamente spettacolare: sì, quel peso che si dava al pasto insieme. È davvero una cosa bella.
Apprezzava anche i modi in cui in quelle campagne si era soliti creare momenti di intensa socialità. «Ballavano negli stazzi… a Tralana per esempio: andavano lì a trascorrere le sere ballando».
Questo mondo la attrae a tal punto che Adelaide costruisce nel 1984 una nuova casa: un neo-stazzo dove ancora oggi vive, coltivando la passione per le piante: qui realizza un brulicante giardino, inserendo nuove specie vegetali. Si circonda di animali: cani, cavalli. Impara ad allevare le api. Va a caccia e fa equitazione. Per anni pendola tra la campagna di Luogosanto e Sassari, dove trova nel frattempo, un posto da lettrice all’Università. Poi quando va in pensione decide di restare definitivamente in campagna e continua a dedicarsi, insieme a un altro vicino di stazzo, alla produzione del miele che aveva cominciato a praticare sin dagli anni ottanta.
Fabrizio
Tra i nuovi arrivati in questi anni, di cui abbiamo raccontato solo alcune storie, c’è anche un nome importante: quello di Fabrizio De André. De André giunge nelle campagne di Tempio anche lui nella seconda metà degli anni settanta. In quegli anni, come riporta Gentile: «L’artista […] credeva di aver esaurito la vena creativa […] di non aver più nulla da dire, di aver sostanzialmente chiuso la sua missione musicale […]. Non gli piacevano l’ambiente della musica e dei professionisti, gli addetti ai lavori che vi si annidavano, i discografici, i giornalisti, l’ambiente televisivo […] gli piaceva la solitudine, stare lontano, a distanza di sicurezza dal circo» (2019, pp. 16-8).
Aveva deciso di lasciare la città. «Aveva le batterie scariche» (Gelsomino 2016). Come dice in uno d...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- Introduzione. Guardare il buio per cogliere gli embrioni di mutamento: premesse teoriche e metodologiche
- Parte prima. Il territorio: un serbatoio a multistrati intessuto di diverse temporalità
- Parte seconda. Una storia in divenire. Verso una riscoperta delle aree interne della Gallura alla ricerca di nuovi modi di abitare tra la campagna e il mondo
- Parte terza. Il futuro anteriore della terra: natura e nuove forme di produzione
- Parte quarta. I luoghi della memoria e della storia: tra museificazione e germinazione di novità
- Parte quinta. Lampi del contemporaneo: eventi arte, natura e territorio
- Parte sesta. Immergersi, accogliere e raccontare
- Conclusione. Verso la città-natura
- Riferimenti bibliografici