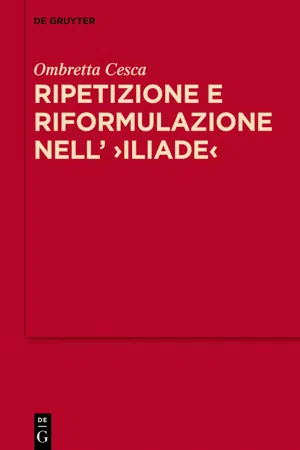Un dato fondamentale dovrà essere assunto come punto di partenza di questa ricerca: il greco omerico ἄγγελος e l’italiano ‘messaggero’ non si corrispondono perfettamente. Come si illustrerà, ἄγγελος si applica anche a figure diverse da quelle che in italiano definiremmo ‘messaggeri’1, come ad esempio gli ‘ambasciatori’ (vocabolo, questo, che va impiegato con grande cautela, e vedremo perché). L’etimologia fornisce un primo indizio di questa non perfetta corrispondenza. In italiano, come in tutte le altre lingue romanze, è l’agente a prendere il nome dal contenuto della comunicazione, per mezzo di un suffisso: ‘messaggero’ deriva evidentemente da ‘messaggio’ e non viceversa2. In greco, invece, il rapporto etimologico è invertito: è ἄγγελος a essere all’origine di una grande quantità di derivati, tra cui ἀγγελίη (traducibile, a seconda dei contesti, con ‘messaggio’, ‘notizia’, ‘annuncio’)3, ossia ogni informazione trasmessa da un ἄγγελος. Diversa è la situazione del latino classico, in cui il sostantivo nuntius può designare sia la persona che trasmette un messaggio, sia il messaggio stesso4.
D’altra parte, come potrebbero ‘messaggero’ e ἄγγελος essere perfettamente coincidenti, se profondamente diversi sono i contesti storici e culturali in cui queste figure agiscono? Tra il mondo occidentale contemporaneo e quello in cui si è sviluppato il racconto della guerra di Troia, né le pratiche comunicative, né i presupposti culturali che a esse soggiacciono sono sovrapponibili. Oggi la comunicazione è questione di frazioni di secondo, di dispositivi elettronici e di tracce scritte. Quello della Grecia arcaica era invece un mondo in cui l’informazione circolava con dispendio di tempo e di energie umane, e che aveva nella memoria e nella capacità discorsiva dei suoi intermediari i suoi strumenti più performanti5. A ragione Costanza Fratini scrive che, in un tale contesto, “il messaggio orale non ha alcuna valenza concreta se non in rapporto alla persona che lo memorizza e lo trasmette inalterato”6. Non ci dobbiamo dunque stupire se il lessico a nostra disposizione risulta nella maggior parte dei casi inadeguato: attribuire etichette alle dinamiche comunicative iliadiche e agli attori che vi prendono parte (‘messaggero’, ‘araldo’, ‘ambasciatore’, ‘messaggio’, ‘notizia’ …) è spesso un gioco di corrispondenze imperfette. Tutt’altro che banale è, inoltre, circoscrivere il corpus di indagine. Nell’Iliade, infatti, i modi della comunicazione verbale via ἄγγελος si intersecano con altri tipi di comunicazione, prevalentemente non verbale, che con essa condividono apparato lessicale e rappresentazione narrativa. Si pensi ai sogni e ai presagi, forme diverse di una comunicazione che si instaura tra il mondo divino e quello umano. In Iliade II (8–71) l’intervento di Ὄνειρος, il Sogno, che ripete parola per parola un messaggio impartito da Zeus, segue gli schemi della comunicazione via ἄγγελος; nel libro XXIV (291 e 310) un omen, l’aquila che rassicura Priamo con la sua parabola di volo, è ταχὺν ἄγγελον, “rapido messaggero” di Zeus, come il Sogno stesso, come la dea Iride, Teti, Ὄσσα (la Voce) e gli araldi achei e troiani. Per tutte queste ragioni riteniamo che sia più prudente e più proficuo per la nostra ricerca sviluppare le nostre riflessioni a partire dai vocaboli greci e dall’analisi delle loro occorrenze, a cominciare, naturalmente, da ἄγγελος e dai suoi derivati.
1 Occorrenze iliadiche di ἄγγελος: una panoramica
Il sostantivo ἄγγελος è attestato, prima che nei poemi omerici, nelle tavolette micenee, nella forma a-ke-ro7. La sua origine è, tuttavia, incerta. L’ipotesi di un legame etimologico con il sanscrito áṅgiras, che nel Rig-Veda è attributo della divinità Agni e di un gruppo sacerdotale a essa legato, ha in passato dato adito a suggestive ricostruzioni, ma è respinta dagli studi più recenti8. Sussiste, invece, la possibilità di un prestito dall’Oriente: ἄγγελος potrebbe essere legato al vocabolo dell’antico persiano che ha prodotto il greco ἄγγαρος, ‘corriere’9. Infine, è stato recentemente proposto che non si tratti di un prestito, ma di una creazione greca, già presente in miceneo nella forma a-ke-ro, o, in alterntiva, di un’eredità indoeuropea sopravvissuta esclusivamente nel greco10.
Nell’Iliade, le occorrenze di ἄγγελος sono venticinque. In due casi questo sostantivo denota un generico messaggero, che non ha nel testo un referente preciso: nel libro XII Polidamante sottopone a Ettore i possibili catastrofici risvolti di un contrattacco nemico, prevedendo che nemmeno un messaggero (ἄγγελος) sarebbe in grado di tornare vivo in città11; in XXII 438 Ettore è già caduto per mano di Achille, quando il narratore afferma che nessun veridico messaggero (ἐτήτυμος ἄγγελος) aveva avvertito Andromaca che lo sposo si stava battendo in duello con il più terribile degli Achei12. Quando ἄγγελος ha un referente preciso, la gamma delle figure che può identificare è ampia: dèi, dee, mortali, eroi, araldi, persino animali. Il personaggio che si vede attribuire con maggior frequenza il qualificativo di ἄγγελος è Iride, dea messaggera alata e rapida come il vento, trait d’union tra mondo divino e mondo umano come il fenomeno atmosferico con cui condivide il nome: l’arcobaleno (ἶρις)13. Iride è definita ἄγγελος in otto occasioni: sei nella narrazione14, una in un discorso della dea a Priamo (“Ti sono messaggera di Zeus”, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι, XXIV 173), e una in una presa di parola di Poseidone che tesse le lodi del messaggero sapiente: “è buona cosa quando il messaggero conosce saggi pensieri”15, alludendo, appunto, a Iride. Ancora riferiti a Iride sono i composti di ἄγγελος presenti nell’Iliade: ψευδάγγελος di Il. XV 159, su cui avremo occasione di tornare e ragionare, e μετάγγελος di XV 144 (θεοῖσι μετάγγελος ἀθανάτοισι, “messaggera per gli dèi immortali”) e XXIII 199 (μετάγγελος ἦλθ’ ἀνέμοισιν, “andò messaggera ai Venti”). L’effettiva presenza di questo ultimo composto nei passi iliadici menzionati è, tuttavia, oggetto di dibattito filologico16.
Come già accennato, anche Ὄνειρος, il Sogno inviato da Zeus ad Agamennone nel libro II, si definisce “messaggero di Zeus”17. Analogamente Teti, nel libro XXIV (133), inviata da Zeus per convincere Achille a cessare l’accanimento sul cadavere di Ettore, dichiara di fronte al figlio: “Ma ora ascoltami subito: ti sono messaggera di Zeus” (ἀλλ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦκα, Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι)18. Qualche verso più tardi (XXIV 561–562), inoltre, Achille racconta a Priamo: “Venne a me messaggera di Zeus la madre” (Διόθεν δέ μοι ἄγγελος ἦλθε / μήτηρ). Altri messaggeri di Zeus sono Ὄσσα, la Voce, definita tale in Il. II 94, e, come già menzionato, l’aquila che Zeus invia a Priamo come benevolo presagio e garanzia del suo accordo alla spedizione che permetterà di riscattare il corpo di Ettore19. Nel lungo discorso di Nestore contenuto nel libro XI, poi, l’eroe racconta l’assedio di Triessa, affermando: “Atena giunse a noi messaggera di corsa (ἄγγελος ἦλθε θέουσ[α]) dall’Olimpo, di notte, a farci prendere le armi”20.
Anche tra i mortali ci sono personaggi che si vedono attribuire l’appellativo di ἄγγελος. Innanzitutto gli araldi (κήρυκες), detti due volte “messaggeri di Zeus e degli uomini” (Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν, I 334 e VII 274). Sull’identità, funzione e caratterizzazione di queste figure ci soffermeremo nei capitoli 2 e 4. Sono, inoltre, referenti di ἄγγελος due eroi greci: Patroclo e Antiloco. Nel libro XI Patroclo, inviato da Achille alla tenda di Nestore per informarsi sull’identità di un eroe ferito – che si rivelerà essere Macaone – dichiara: “E ora torno come messaggero a dire parola ad Achille” (νῦν δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος εἶμ᾽ Ἀχιλῆϊ, ΧΙ 652). Anche Antiloco, nel libro XVIII, incaricato di portare ad Achille la terribile notizia della morte di Patroclo, è detto ἄγγελος21.
Fin qui, la traduzione ‘messaggero’ sembra adatta a tutti i contesti in cui ἄγγελος fa la sua comparsa. Tuttavia, due occorrenze che figurano nel racconto di una missione affidata a Tideo mostrano che il campo semantico coperto dal greco omerico ἄγγελος è più ampio. La missione in questione è richiamata tre volte nell’Iliade, con formulazioni simili ma non iden...