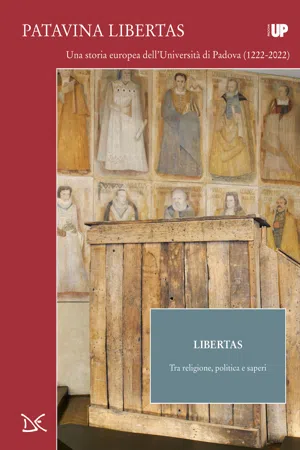
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Universa universis Patavina libertas: così recita il celebre motto dell'Università di Padova, una delle più antiche e prestigiose d'Europa, di cui nel 2022 ricorrono gli 800 anni della sua fondazione. Nessun altro aspetto ha caratterizzato più a fondo e più a lungo l'istituzione accademica padovana rispetto alla sua celebre libertas. Dalla fondazione nel 1222 alle dispute accademiche sulla mortalità dell'anima, dagli anni in cui in cattedra sedeva Galileo Galilei – al cui insegnamento nel vol¬me è riservato ampio spazio – ai moti del 1848 sino alla Resistenza, la libertas padovana ha rappresentato un riferimento costante per chiunque abbia corso il pericolo di essere limitato nel corpo quanto nel proprio intelletto. La libertas è tuttavia un termine ambiguo, impiegato in questi otto secoli per indicare fenomeni e concetti diversi, talvolta quasi opposti. Il volume mira quindi a ricostruire la sua lunga storia, prestando attenzione alle istituzioni, agli spazi, alle pratiche e ai conflitti che più hanno costellato questa lunga evoluzione. I saggi raccolti nell'opera dimostrano da punti di vista diversi ma costantemente intrecciati come la Patavina libertas sia stata fondamentale per l'affermarsi di alcune delle libertà individuali che oggi sono considerate inalienabili. La libertà religiosa, la libertà politica e il diritto a una libera speculazione scientifica ebbero nella città di Padova e nel suo antico Studio una fase di profonda maturazione, i cui benefici non smettono di influire sulle nostre vite al principiare di questo nono secolo.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Libertas di Aa.VV.,AA.VV. in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia mondiale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia mondialeSpazi e pratiche della libertas
I. Fuori dalle aule: circoli e accademie
di Antonella Barzazi
Nei secoli dell’età moderna la storia dell’Università di Padova si è intrecciata a lungo con quella delle varie forme di aggregazione che si sono avvicendate nello spazio urbano. La presenza accanto allo Studio di circoli, accademie e altri ritrovi si può considerare come uno degli esiti di un modello universitario connotato da un forte pluralismo istituzionale – tra nationes studentesche, corporazioni degli scolari artisti e giuristi, collegi dei dottori – e da un’elevata dispersione delle sedi d’insegnamento che, anche dopo il passaggio nel Palazzo del Bo, spingeva i docenti a riunire allievi e uditori intorno a sé nelle proprie abitazioni e moltiplicava le occasioni di contatto e di scambio tra la comunità dello Studio e la società cittadina. I sodalizi privati, variamente strutturati, accompagnarono così l’attività svolta dalle cattedre ritmando la vita culturale padovana, orientando scelte e atteggiamenti intellettuali di professori e studenti, contribuendo alla costruzione di reti di relazioni. Nelle pagine che seguono cercheremo di affacciarci a questi ambienti, di coglierne la fisionomia, le funzioni, i mutevoli rapporti instaurati con lo Studio e con la città. Soprattutto nel Cinquecento, sullo sfondo di profondi cambiamenti politico-religiosi e culturali, circoli e accademie assunsero ruoli di rilievo, proponendosi di volta in volta come luoghi di critica o di integrazione alla didattica universitaria, come zone franche dai controlli ecclesiastici, come strumenti di inquadramento di una vita intellettuale molto ricca, alimentata dalla presenza di docenti di spicco e di scolari stranieri, ma rappresentando anche spazi di riaffermazione di status sociali e di conflitto politico.
È dalla Padova della seconda metà del Quattrocento che la nostra rassegna dovrà partire: vengono infatti poste allora le premesse di pratiche di socialità umanistica incoraggiate dall’attrattiva crescente che gli studi universitari esercitano sul ceto patrizio della capitale. Non molti, in quel periodo, i nobili veneziani che frequentano lo Studio, per lo più senza conseguire una laurea, non richiesta per l’accesso alle magistrature statali. Questi costituiscono però una minoranza «molto qualificata ed influente», in grado di richiamare intorno a sé uomini di cultura, di animare incontri e conversazioni. Spicca in questo orizzonte un protagonista dell’umanesimo veneto quale il futuro patriarca di Aquileia Ermolao Barbaro. Il padre e il nonno avevano fatto dello studio delle lettere greche e latine, coniugato con l’impegno politico, un tratto fondamentale della propria immagine di governanti. Ermolao, laureato tanto in filosofia che in utroque iure, si lega strettamente a Padova. E quando, negli anni settanta e ottanta, si cimenta in letture e corsi privati sul testo greco dell’Etica e della Retorica aristoteliche, su Demostene e Teocrito, propone un modello autorevolissimo di comunicazione colta che marca un netto distacco dalla tradizione averroistica dominante e una «sfida ai professionisti padovani di Aristotele». Il suo progetto culturale avrebbe presto trovato sbocco nelle iniziative editoriali di Aldo Manuzio, rafforzando i rapporti tra l’ambiente universitario e la capitale.
L’affermarsi di nuove consuetudini dovette fare i conti, negli anni a cavallo tra Quattro e Cinquecento, con i problemi di un periodo di passaggio per lo Studio. La regolamentazione da parte della Repubblica dei privilegi degli studenti e il contenimento delle pretese dell’élite nobiliare padovana, aspirante a inserirsi in forze nei ranghi dei docenti, alimentavano una latente conflittualità. L’Università inoltre, l’unica dello Stato veneziano, subiva gli effetti della concorrenza di altri Studi italiani, ai quali i rispettivi governanti avevano riservato analoghe politiche protezionistiche, con un impatto sui costi e sulle stesse possibilità di reclutamento dei professori. Su questo quadro si sarebbe innestato il trauma della guerra di Cambrai, con l’occupazione di Padova, nel 1509, da parte delle truppe imperiali, cui la nobiltà padovana aveva aperto le porte. La riduzione dell’attività delle cattedre universitarie era stata drastica. La cosiddetta restaurazione dello Studio, reclamata a gran voce dall’élite cittadina, fu un processo graduale, accompagnato dai primi passi di una magistratura, i Riformatori dello Studio di Padova che, nata con competenze limitate e straordinarie, avrebbe nel tempo allargato il proprio campo ai più vari aspetti della politica culturale veneziana, segnando un passo ulteriore verso il controllo statale sullo Studio.
All’inizio degli anni venti il flusso degli studenti transalpini era comunque ripreso e ricomparivano pratiche che si erano affacciate sullo scorcio del secolo precedente. Un esempio ci è offerto dal caso dell’umanista bavarese Friedrich Grau, detto Nausea, futuro vescovo di Vienna. Giunto in quel periodo a Padova per studiare giurisprudenza, aveva messo a frutto i propri studi precedenti tenendo dei corsi privati di grammatica, poetica e retorica, nei quali utilizzava gli scritti grammaticali e linguistici di Erasmo da Rotterdam. L’interesse per lo studio filologico delle lingue classiche era ormai penetrato ampiamente nell’Ateneo e lo studente-maestro tedesco si era inserito in un gruppo di estimatori dell’umanista olandese che contava tra i propri membri professori, studenti, nobili padovani, oltre a due ecclesiastici che sarebbero in seguito passati alla Riforma, Lucio Paolo Rosello e Pier Paolo Vergerio. La sua presenza aveva permesso di instaurare una collaborazione con il tipografo veneziano Gregorio de Gregoriis al quale Friedrich Nausea forniva libri di Erasmo, procurati dalla Germania, da stampare. Un circolo composito, ma strettamente legato allo Studio, aveva fatto dunque di Padova un anello nella catena di diffusione di testi erasmiani creatasi in Italia nel primo Cinquecento.
L’esperienza di questo ambiente si collocava in un panorama in movimento. Difficile sopravvalutare il significato della presenza di Pietro Bembo, che negli stessi anni aveva scelto di risiedere stabilmente tra Padova e la villa di famiglia nella campagna vicina. Patrizio veneziano, Pietro – a differenza del padre Bernardo – non si era laureato e la sua formazione era avvenuta lontano dall’università, al seguito delle missioni diplomatiche del padre e presso i più reputati maestri di greco affluiti in Italia, quindi attraverso una lunga pratica delle corti della penisola e della Roma rinascimentale. Compiuti i cinquant’anni, Bembo aveva fatto però di Padova la base della propria attività e della sua estesa rete di contatti. Qui giungeva in porto – con la pubblicazione delle Prose della volgar lingua – il suo progetto di rinnovamento della cultura italiana all’insegna dell’elevazione del volgare al rango delle lingue classiche. Nelle sue abitazioni – ultima quella sull’attuale via Altinate, allestita a dimora-museo con libri, oggetti d’arte e antichità – si avvicendarono al suo fianco, oltre a numerosi amici veneziani, figure di spicco di una generazione più giovane: tra questi Bernardo Tasso, padre del celebre poeta, Giovanni Della Casa, Reginald Pole, futuro legato apostolico al Concilio di Trento, giunto a Padova nel 1521 per seguire i corsi dello Studio insieme ad altri suoi connazionali. Sottrattosi alle incombenze della vita politica cui era destinato dal suo status sociale, Bembo aveva portato con sé il modello della conversazione colta sperimentato tra Roma, Urbino e altri ambienti di corte. Ma si sbaglierebbe a considerare la sua cerchia come un luogo esclusivo di rarefatte discussioni letterarie e linguistiche. Vi si avverte bene, ad esempio, il fervore delle officine tipografiche veneziane, con le quali fa da raccordo costante un amico di vecchia data di Bembo, Giovanni Battista Ramusio, segretario della Cancelleria veneziana nonché editore della celebre raccolta Navigazioni e viaggi. Ramusio fu coinvolto nella stampa delle Prose della volgar lingua, uscite nel 1525 dai torchi di Giovanni Tacuino; insieme a Bembo curerà poi per la stampa presso gli eredi di Aldo il Cortegiano di Baldassarre Castiglione che morirà in Spagna nel 1529. Le lettere che Bembo e Ramusio si scambiano assiduamente fanno balenare nel ritiro bembiano i nuovi orizzonti della politica europea: dalla metà degli anni venti Ramusio risulta impegnato nella ricerca, tramite i canali diplomatici veneziani, di quei materiali naturalistici e geografici sul nuovo mondo americano che comincerà a pubblicare singolarmente nel decennio successivo. Nel 1537-38 Ramusio invierà a Bembo – ormai prossimo alla nomina cardinalizia e al trasferimento a Roma – informazioni sui movimenti dei turchi in corso nello Ionio.
Lasciamoci ora alle spalle la residenza del cardinale veneziano e raggiungiamo, nei pressi della Basilica del Santo, un’altra dimora classicheggiante aperta al mondo cittadino: l’abitazione di Alvise Cornaro, scrittore d’idraulica e d’architettura, promotore di bonifiche nelle sue terre sul limitare tra il Padovano e la laguna veneta, detto «Vita sobria» per il suo attaccamento a un regime alimentare austero, ritenuto in grado di allungare oltre ogni limite l’esistenza umana. Veneziano, ma non patrizio – un suo tentativo di avere riconosciuta la nobiltà fu respinto –, si era stabilito a Padova: qui aveva intrapreso e poi abbandonato gli studi di diritto, coltivato nuovi interessi scientifici, consolidato la sua situazione economica grazie a un buon matrimonio e alla cospicua eredità fondiaria di uno zio. Una tappa importante in questo processo d’ascesa sociale era stata la costruzione, sul retro della sua casa, verso il giardino, di una loggia con odeo d’ispirazione romana, affidata all’architetto e pittore veronese Giovanni Maria Falconetto. Su quello spazio scenico, ultimato a metà anni venti, si sarebbe in seguito più volte esibito Ruzante, che nella residenza del Cornaro avrebbe anche vissuto a lungo, incrociandone gli altri numerosi ospiti: artisti e decoratori, soprattutto, ma anche letterati impegnati nel dibattito sulle lingue come il bellunese Pierio Valeriano, o frati dotti come il predicatore francescano Cornelio Musso, per un periodo soggiornante nel vicino convento del Santo. Un milieu più variegato, dunque, quello gravitante intorno al Cornaro, sensibile a filoni culturali estranei all’orizzonte dello Studio, ambito di un attivo patronage artistico che, secondo alcuni studiosi, poté colorarsi di una nota politica antiveneziana.
Tanto il cenacolo del Cornaro che l’elitario ambiente riunito intorno a Bembo intersecavano un’altra cerchia, destinata a costituire un riferimento duraturo in città: quella che faceva capo a Bernardino Scardeone, erudito parroco padovano, con al suo attivo studi di diritto canonico e di dialettica, premiato in età avanzata dalla nomina a canonico della cattedrale. Dalla casa paterna a San Leonardo, nell’attuale via Savonarola, Scardeone si collocò per decenni al centro di un fitto reticolo di contatti. Se i suoi amici più stretti furono alcuni sacerdoti e religiosi padovani, si legò anche a Francesco Bonafede, fautore dell’insegnamento dei «semplici» e primo promotore dell’Orto botanico, e a Battista Egnazio (Giovanni Battista Cipelli), consulente di Aldo Manuzio e dei suoi successori, parte di un gruppo di filologi e cultori di studi classici profondamente inseriti nel mondo della stampa. Ma fu anche in rapporto con esponenti di primo piano del dissenso religioso veneto e nelle vicende di alcuni si trovò coinvolto, senza che la sua reputazione ne venisse scalfita. Riflette il raggio delle sue frequentazioni l’opera De antiquitate urbis Patavii et claris civibus Patavinis – stampata in un prestigioso in folio a Basilea nel 1560 – che, a dispetto del titolo, poneva in primo piano un ritratto collettivo della società colta padovana a lui contemporanea. Qui lo Studio e i suoi professori venivano assunti all’interno di un’illustre tradizione municipale, insieme a una schiera di ecclesiastici, di grammatici, di rhetores, di italicae linguae scriptores, che non tralasciava quanti negli anni quaranta erano stati colpiti dall’Inquisizione. L’affresco faceva trasparire una rivendicazione di autonomia per la sua città e un sentimento d’ostilità nei confronti di Venezia che Scardeone non avrebbe esitato a far valere, quando – ormai ultraottantenne – si opporrà con tenacia, in qualità di canonico, all’elezione a primicerio del capitolo di un patrizio della capitale.
Nel quadro di una socialità informale diversificata, specchio di aperture culturali e di latenti tensioni, si era inserita nel 1540 l’Accademia degli Infiammati. Con la fondazione di quest’ultima anche Padova veniva raggiunta da un fenomeno tipicamente italiano: l’ondata cinquecentesca di nuovi modelli di aggregazione urbana – le accademie – che sotto un nome evocativo e un’immagine-simbolo (l’impresa) si organizzavano intorno a un sistema di cariche e ruoli, convocandosi periodicamente per illustrare – in discorsi, orazioni e altre forme retoriche strutturate e solenni – temi attinenti a varie discipline.
Il sodalizio padovano era nato per iniziativa di due illustri allievi dello Studio: il patrizio veneziano Daniele Barbaro e Leone Orsini, appartenente a uno dei rami della famiglia nobile romana. Il primo, traduttore in italiano del De architectura di Vitruvio, nominato patriarca di Aquileia, ma morto prima di entrare in carica, era allora a Padova per seguire i corsi universitari di filosofia, matematica e medicina; il secondo, che dell’accademia sarebbe stato il primo «principe», era studente di diritto e sarebbe diventato vescovo della diocesi francese di Fréjus.
Gli Infiammati si erano dati un piano di lavoro volto a promuovere l’uso del volgare italiano, a dimostrarne l’efficacia in ogni ambito della comunicazione, la capacità di adattarsi a differenti discipline e contenuti non inferiore a quella delle lingue classiche. Sostenevano la necessità che gli autori si cimentassero nella stesura di opere in italiano, in scritti d’impegno non solo in versi, ma soprattutto in prosa, producendo trattati filosofici e scientifici, lavori storici, traduzioni e compendi dei classici greci e latini. «Felicissima e fioritissima», autentica capostipite tra istituzioni sorelle dedite alla lingua volgare: così avrebbe definito l’accademia padovana Benedetto Varchi, che – giunto a Padova nel 1537, esule dalla Firenze medicea – partecipò attivamente alle sue sessioni, per diventare in seguito, rientrato in patria, anima dell’accademia fiorentina. Un altro toscano, Alessandro Piccolomini, già membro a Siena dell’Accademia degli intronati, portò tra gli Infiammati la propria esperienza di divulgatore scientifico in italiano e la sua visione del problema della lingua come strettamente collegato alla ricerca di un metodo degli studi adeguato ai tempi, in grado di limitare l’impegno richiesto dall’apprendimento delle lingue classiche e di avvicinare più agevolmente i giovani ai contenuti dei testi. La rivendicazione della piena dignità espressiva del volgare schiudeva qui prospettive culturali innovative e aperte, proiettate al di là del livello sociale assai elevato dell’ambiente da cui promanavano.
Dietro le discussioni dell’accademia c’erano l’influenza viva di Bembo e la linea che dalle Prose della ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- Premessa di Daniela Mapelli e Annalisa Oboe
- Introduzione di Andrea Caracausi, Paola Molino, Dennj Solera
- Parte prima. Sapere e libertas
- Parte seconda. Politica e istituzioni
- Parte terza. Spazi e pratiche della libertas
- Parte quarta. Conflitti e tensioni
- Bibliografia ragionata
- Elenco delle illustrazioni
- Gli autori