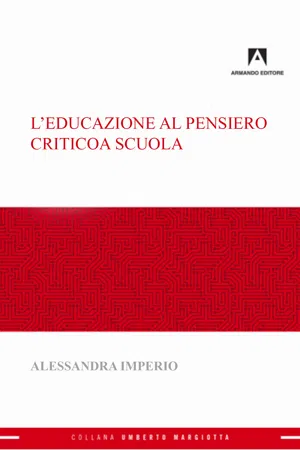
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
L'educazione al pensiero critico a scuola
Informazioni su questo libro
Il volume tratta una tematica di grande attualità e di fondamentale importanza in questo secolo: l'educazione al pensiero critico. Il filo conduttore è la descrizione di un progetto di ricerca svolto con la scuola e per la scuola, dall'inquadramento epistemologico e teorico a quello metodologico, dall'analisi dei dati raccolti alla discussione dei risultati conseguiti.
Sebbene lo studio abbia coinvolto alcune classi di scuola primaria, diversi contenuti del manoscritto sono fruibili in tutti gli ordini e gradi scolastici, a cominciare dalla revisione della letteratura internazionale sul pensiero critico, in termini di definizione, insegnamento e valutazione. Viene inoltre presentato un approccio didattico innovativo, ancora per lo più sconosciuto in Italia, applicabile e promettente in diversi contesti formativi e per tutte le fasce d'età. Infine, il testo offre alcuni spunti di riflessione su alcuni aspetti del nostro sistema scolastico.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a L'educazione al pensiero critico a scuola di Alessandra Imperio in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Editore
Armando EditoreAnno
2022eBook ISBN
9791259842268Capitolo 1 Contestualizzazione dello studio
[…] il pensiero è oggi più che mai
il capitale più prezioso per
l’individuo e per la società.
(Morin, 2000, p. 11)
Il capitolo descrive i confini entro i quali lo studio si sviluppa, in termini di principi fondanti, significati e origine delle azioni e delle riflessioni pedagogiche che prendono forma. Rappresenta, dunque, un momento di autoriflessione per comprendere appieno le scelte che sono state percorse.
1.1 Premesse di una ricerca per la scuola
La scelta di approfondire come promuovere lo sviluppo del pensiero critico nasce dai bisogni e dalle esperienze descritti nella parte introduttiva.
Da un lato, la necessità di educare cittadini attivi, liberi, autonomi, capaci di pensare con la propria testa e di affrontare le sfide della vita, senza che qualcuno lo faccia per loro. Si consideri che la facoltà del pensare è importante non solo nel contesto lavorativo e scolastico, ma anche nell’ambito delle relazioni di vita personale e comunitaria poiché contribuisce alla costruzione di credenze e valori personali e condivisi (Moseley et al., 2005).
Dall’altro, come rendere possibile questo attraverso una didattica meno enciclopedica e più orientata allo studente e alla maturazione delle competenze, nel nostro contesto nazionale.
Non possiamo aspettarci che le persone che sono state passive e assimilative fino al raggiungimento dell’età del voto subiscano una improvvisa e inspiegabile metamorfosi che consenta loro di essere politicamente attive e produttive una volta diventate adulte. Né possiamo continuare a muoverci nella direzione della democrazia fintanto che siamo incatenati in paradigmi educativi che sono appropriati solo a sistemi non democratici (Lipman, 1995, p. 70).
Anche se questi bisogni e queste possibili soluzioni non sembrano rappresentare qualcosa di particolarmente nuovo nel panorama della ricerca educativa e delle politiche scolastiche, tuttavia sono necessari ancora molti studi sugli aspetti importanti dell’insegnamento del pensiero critico come, ad esempio, quali esperienze educative siano più produttive in questa direzione (Halpern, 2001).
Inoltre, e comunque, le pratiche educative suggeriscono che ancora molto lavoro deve essere condotto per ribaltare alcuni dei paradigmi irrinunciabili del nostro sistema scolastico (cfr. terzo capitolo). Purtroppo, non è sufficiente calare dall’alto principi e teorie che indirizzino al cambiamento, ma un lungo lavoro di buone pratiche deve partire dal basso per poi allargarsi a macchia d’olio. Questo studio, pur avendo dei chiari obiettivi da perseguire (cfr. terzo capitolo), ne sottende uno preciso: promuovere il cambiamento dal basso. In questo senso, vuole essere una ricerca sui generis, che non lavora sulla scuola, ma con e soprattutto per la scuola. Pertanto, questa ricerca coinvolge e si rivolge, in primis, a bambini e insegnanti. Da questa idea di condurre uno studio che avesse una valenza trasformativa, dunque, inizia a delinearsi il disegno del progetto vero e proprio, così come descritto nel terzo capitolo.
Ma quali sono le caratteristiche di una ricerca sì fatta, che sia in grado di offrire esperienze formative di qualità ai soggetti coinvolti, restituendo loro un potenziale educativo, e contemporaneamente di rispondere ai quesiti dello studio stesso?
Innanzitutto, come sostenuto da Mortari (2009), bisogna essere consapevoli del fatto che «è impossibile accostarsi agli altri senza comunicare qualcosa e senza che questo qualcosa lasci un segno nell’esperienza dell’altro» (p. 3).
Ecco perché è indispensabile che la relazione, che si viene ad instaurare tra il ricercatore e i partecipanti allo studio, sia più positiva e produttiva possibile per entrambi.
In questo studio, affinché fosse possibile realizzare tutto ciò, si è tenuto conto di alcuni aspetti e riflessioni, che sono stati illustrati e approfonditi da Mortari (2009), e che sinteticamente vengono discussi nel testo che segue.
Forse, l’unico modo per offrire, contemporaneamente, a bambini, insegnanti e ricercatori la possibilità di apprendere da un’esperienza di ricerca è quello di costruire una comunità di ricerca nel territorio, dove tutti i partecipanti, se pur in forme diverse, rivestono un ruolo attivo nello studio stesso.
È vero che il ruolo dei bambini assume spesso una connotazione eticamente più delicata rispetto a quella degli adulti1. Tuttavia, se si considera di sviluppare la ricerca negli ambienti reali di vita dei bambini, permettendo ai bambini di fare i bambini, utilizzando delle tecniche d’indagine che permettano loro di essere a proprio agio, e spiegando loro esattamente qual è il ruolo del ricercatore e quali sono i motivi della sua presenza in classe, allora non si va a snaturare il normale corso degli eventi su cui si fonda la ricerca stessa, né c’è il pericolo di instaurare relazioni che siano poco spontanee o non autentiche. La scuola è già di per sé un ambiente dove si sperimentano nuove strategie e si accolgono esperti, quindi, non vi è alcun motivo di percepire il ricercatore come un intruso2.
L’importante, come sempre, è riuscire a costruire un buon clima in classe e ad utilizzare strumenti di ricerca piacevoli e adeguati all’età.
L’approccio che consente di realizzare una ricerca così strutturata, meno invasiva e più coinvolgente e utile possibile per i bambini, è preferibilmente quello di tipo qualitativo (Mortari, 2009). Tuttavia, in questo studio, per la sua specificità, è stato possibile utilizzare un approccio misto, qualitativo e quantitativo insieme, consentendo alla ricerca di restare centrata su bambini e insegnanti, ma anche di essere funzionale, affidabile e, volendo, replicabile in altre realtà. Il progetto, infatti, ha delle caratteristiche che lo rendono facilmente rimodulabile in diversi contesti, anche destinandolo a studenti di altri ordini e gradi scolastici.
Senza ora entrare nella specificità del disegno della ricerca, descritto nei prossimi capitoli, l’approccio quasi-sperimentale del progetto prevede il coinvolgimento sia di classi sperimentali che di classi di controllo, garantendo ad entrambe le tipologie di gruppi di beneficiare dei medesimi interventi dell’esperta/ricercatrice e di una analoga formazione dedicata agli insegnanti, se pure in tempi diversi. La ricercatrice entra in entrambe le tipologie di classi, per lo stesso numero di ore e per condurre le stesse identiche attività, orchestrando lo svolgimento dei compiti e, solo in parte, delle discussioni, ma anche osservando in modo partecipativo. Gli strumenti di raccolta dei dati sono multipli (registrazioni audio, schede didattiche e griglie di osservazione, diari di bordo e schede di progettazione) e creano il minimo disturbo possibile.
Gli insegnanti delle classi sperimentali, individuati su candidatura volontaria per interesse e motivazione personali, beneficiano di una formazione a loro dedicata sul tema della ricerca e su un possibile ambiente di apprendimento che favorisce lo sviluppo del pensiero critico negli studenti. Attivamente, poi, partecipano alla ricerca implementando nelle classi quanto appreso. In questo percorso di implementazione, come in una comunità di ricerca di buone pratiche, la ricercatrice affianca costantemente gli insegnanti nella progettazione e, insieme, provano a trovare soluzioni efficaci per le criticità che emergono. Tutto questo nel pieno e costante rispetto dell’autonomia d’insegnamento di ciascun docente e nei tempi e...
Indice dei contenuti
- Frontespizio
- Dedica
- Ringraziamenti
- Prefazione
- Introduzione
- Capitolo 1 Contestualizzazione dello studio
- Capitolo 2 Pensiero critico, suo insegnamento e valutazione
- Capitolo 3 Struttura del progetto
- Capitolo 4 Il questionario esplorativo
- Capitolo 5 La valutazione del pensiero critico nei bambini
- Capitolo 6 Implementazione di TASC e aderenza alla sperimentazione
- Capitolo 7 Discussione generale
- Conclusioni
- Riferimenti bibliografici
- Appendix
- Diritti