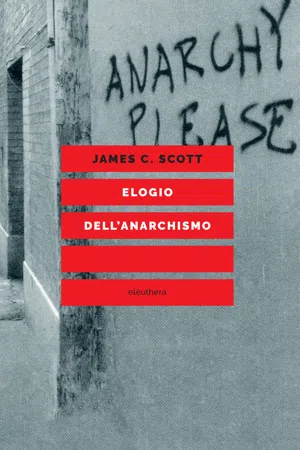![]()
capitolo quinto
In difesa della politica
Louisa era stata sorpresa un giorno a esordire, in una conversazione con il fratello, con queste parole: «Tom, a volte immagino...», al che Gradgrind – era lui che l’aveva colta a esprimersi in tal modo – si era fatto avanti e aveva ammonito: «Louisa, non immaginare mai!». Ecco la molla che azionava il misterioso congegno meccanico capace di educare la ragione, senza piegarsi a coltivare sentimenti e affetti. Non usare mai l’immaginazione! Sistemare tutto, in qualche modo, servendosi di addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, e non usare mai l’immaginazione.
Charles Dickens, Tempi difficili
La forza dell’impresa privata sta nella sua terrificante semplicità […] che si adatta perfettamente alla tendenza moderna verso la totale quantificazione a spese del riconoscimento delle differenze qualitative: perché l’impresa privata non si preoccupa di cosa produce, ma di cosa guadagna con quella produzione.
Ernst F. Schumacher, Piccolo è bello
Frammento ventidue. Contro la misurazione quantitativa della qualità
Mia Kang fissa il foglio con il test che giace sul suo banco. È una procedura semplice. Gli insegnanti lo definiscono un «test di prova» per farsi un’idea di come se la possono cavare gli studenti quando dovranno affrontare il test attitudinale richiesto dallo Stato del Texas. Ma invece di riempire gli spazi bianchi con le risposte e fare felice il suo insegnante, Mia, che si è appena iscritta alla MacArthur High School, utilizza quel foglio per scrivere un saggio che mette in discussione la standardizzazione implicita nei test e il ricorso ai punteggi per giudicare gli allievi e le stesse scuole. «Ho scritto che i test standardizzati sono nocivi e non aiutano le scuole né tanto meno i ragazzi», ha poi detto Mia, che sembra più grande dei suoi quattordici anni. «Non potevo compiere un atto verso il quale sono decisamente contraria». «Questi test non misurano quello che i ragazzi devono sapere, misurano solo ciò che è semplice da misurare», ha aggiunto. «Dovremmo apprendere concetti e capacità, non solo memorizzarli. È una cosa avvilente per i ragazzi ed è avvilente anche per gli insegnanti».
Quando le ricadute concrete, in termini di insegnamento e valutazione, del nuovo regolamento scolastico chiamato No Child Left Behind Act, emanato nel 2001, sono infine approdate nelle aule scolastiche, hanno incontrato una folata di resistenza studentesca, di cui la coraggiosa opposizione di Mia Kang è solo un piccolo esempio. Cinquantotto studenti della Danvers High School del Massachusetts hanno firmato una petizione contro l’obbligo di partecipare a un test di valutazione statale, il mcas, e quelli che si sono effettivamente rifiutati di partecipare al test sono stati sospesi dalla scuola. Gli studenti di altre scuole superiori del Massachusetts si sono uniti a loro. Questi «atti di rifiuto» – potremmo chiamarli così – si sono moltiplicati in tutto il paese: molti studenti del Michigan hanno deciso di non sottoporsi al Michigan Educational Assessment Test, mentre l’esame finale istituito nel Wisconsin per conseguire il diploma è stato accantonato a causa della massiccia resistenza di studenti e genitori. In un caso, alcuni professori, insofferenti verso le esercitazioni preparatorie ai test diventate ormai obbligatorie, hanno protestato rinunciando collettivamente ai bonus abbinati al conseguimento di performance alte. Manifestazioni di protesta contro i test richiesti ai bambini delle elementari sono state organizzate per conto dei piccoli studenti dai loro genitori. Pur comprendendo la necessità di dare ai loro figli competenze scolastiche nella lettura e nel calcolo fin dalla più tenera età, i genitori (e i loro figli) rifiutavano l’atmosfera da «impara o muori» che regnava in classe.
Molta della resistenza messa in campo (anche se non tutta) era alimentata dagli studenti che trovavano particolarmente odiose le esercitazioni di preparazione ai test, un metodo che faceva crescere in maniera esponenziale la noia in classe. Questa preparazione ai test non solo era una fatica alienante sia per gli insegnanti che per gli studenti, ma oltretutto prosciugava gran parte del tempo disponibile per altre attività: arte, teatro, storia, sport, lingue straniere, scrittura creativa, poesia, escursioni. E con loro scomparivano anche talune finalità che invece dovrebbero animare l’educazione: l’apprendimento cooperativo, gli studi multiculturali, la promozione di forme multiple di intelligenza, una mentalità scientifica orientata alla scoperta e alla soluzione dei problemi.
La scuola correva il rischio di essere trasformata in una fabbrica in grado di produrre un unico prodotto, ovvero quel tipo di studente capace di passare test standardizzati pensati per misurare una gamma ristretta di conoscenze e competenze. Vale la pena ricordare, ancora una volta, che la moderna istituzione scolastica è stata inventata quasi nello stesso periodo dell’industria tessile. Entrambe hanno concentrato la forza lavoro sotto un solo tetto; entrambe hanno elaborato una tempistica disciplinata e una specializzazione dei compiti tali da facilitare il controllo e la valutazione; entrambe hanno mirato a realizzare un prodotto standardizzato e affidabile. D’altronde, l’attuale tendenza a elaborare test standardizzati rimanda a un modello di management aziendale che poggia su criteri quantitativi, criteri che permettono un confronto tra insegnanti, tra scuole e tra studenti in modo da ricompensarli sulla base di performance misurabili.
La questione della validità dei test, ovvero se servono davvero a misurare ciò che si prefiggono di misurare, è molto controversa. Il fatto stesso che gli studenti possano essere addestrati a superare i test grazie a esercitazioni o a improbabili recuperi dell’ultima ora rende ancora meno evidente quale forma di sapere e di competenza intendano misurare. È già stato dimostrato che non risultano affatto predittivi delle successive performance di donne, afroamericani e studenti la cui prima lingua non sia l’inglese. Ma ancora più importante è che l’alienazione cui spinge un’istruzione basata sui test e sulla massima resa minaccia di rendere milioni di giovani impermeabili all’apprendimento scolastico per tutta la vita.
Sembra che i più accesi fautori dei test standardizzati come strumento di management e misura comparativa della produttività siano proprio quelli più distanti dall’aula scolastica: dirigenti scolastici, funzionari ministeriali, governatori e assessori all’Istruzione. I test forniscono a tutti loro un indice (in realtà non valido) della produttività comparativa e un potente sistema di incentivi con cui imporre i loro piani pedagogici. È curioso che gli Stati Uniti abbiano deciso di omogeneizzare il loro sistema educativo quando il resto del pianeta va in direzione opposta. La Finlandia, ad esempio, non ha test esterni o graduatorie e tuttavia si piazza molto bene nelle classifiche internazionali in materia di istruzione. Molte università hanno smesso di chiedere (o anche solo di suggerire) agli studenti di partecipare ai test nazionali che misurano il rendimento scolastico (quelli che un tempo erano chiamati test attitudinali). I paesi che storicamente si sono affidati a un singolo esame nazionale per assegnare i posti disponibili nelle università si sono affrettati a eliminare i test o a ridurne l’importanza in modo da promuovere la «creatività» (spesso convinti di imitare, così facendo, il sistema americano!).
Ben consci che il loro destino, come peraltro quello delle loro scuole, dipende dai punteggi accumulati ogni anno, molti insegnanti non solo spronano senza pietà i propri studenti a fare continue esercitazioni, ma talvolta manipolano i risultati per raggiungere i necessari livelli. In tutti gli Stati Uniti è esplosa un’epidemia il cui sintomo è stata la falsificazione dei risultati. Un caso recente è venuto alla luce ad Atlanta, in Georgia, dove quarantaquattro scuole su cinquantasei incluse in un’indagine hanno sistematicamente contraffatto le risposte degli studenti, cancellando le risposte sbagliate e inserendo quelle corrette1. È venuto fuori che la dirigente scolastica eletta «miglior dirigente scolastica per l’anno 2009», grazie agli straordinari risultati ottenuti nell’incremento dei punteggi, aveva creato un clima di paura concedendo agli insegnanti un tempo limite di tre anni, finiti i quali o raggiungevano l’obiettivo (ovvero un innalzamento dei punteggi degli studenti), o venivano licenziati. Si è scoperto che più di centottanta insegnanti avevano di conseguenza manipolato i risultati dei test. Proprio come i «brillanti cervelli» della Enron, che riuscivano sempre a raggiungere i loro obiettivi quadrimestrali così da incassare i relativi bonus, anche gli insegnanti di Atlanta hanno trovato un modo per raggiungere i loro obiettivi: i bonus erano decisamente più bassi, ma i danni collaterali sarebbero stati altrettanto devastanti e la logica di «fregare il sistema» era sostanzialmente la stessa.
Frammento ventitré. E se… una breve fantasia sul calcolo quantitativo
Accompagnatemi in questa piccola simulazione. Siamo nel 2020. Richard Levin, rettore della Yale University, è appena andato in pensione dopo una lunga e brillante carriera e ha dichiarato il 2020 «l’anno della visione perfetta». I vecchi edifici sono stati tutti restaurati e ora sono splendenti, gli studenti sono sempre più precoci, competenti e partecipi di quanto già non lo fossero nel 2010. Le riviste «us News & World Report» e «Consumer Report» (adesso riunite in un’unica testata) hanno piazzato la Yale University in cima alle varie classifiche, lì dove ci sono gli hotel a cinque stelle, le auto di lusso e le migliori falciatrici per il prato all’inglese. Beh, a dire il vero, in cima a quasi tutte le classifiche. Sembra infatti che la qualità dell’università abbia ceduto di qualche punto in alcune di queste. I concorrenti della Yale annuiscono vigorosamente pregustando il declino. E chi riesce a leggere tra le righe di queste valutazioni della «Yale Corporation», ancora apparentemente tranquillizzanti, si accorge di un panico crescente, seppure ancora dignitoso.
Un elemento di preoccupazione può essere individuato nella scelta del successore del rettore Levin: l’ex segretario di Stato Condoleezza Rice, che ha di recente realizzato una messa a punto in senso aziendale della Fondazione Ford, spurgandola di alcune incongruenze. Sì, è la prima donna di colore ad assumere la dirigenza di Yale, mentre altre quattro prestigiose università americane sono già state dirette da donne di colore. Ma la cosa non deve sorprendere, dato che Yale si è sempre adeguata al vecchio adagio contadino del New England: «Non essere mai il primo a provare qualcosa di nuovo, e neppure l’ultimo».
D’altro canto, il rettore Rice non è stata scelta per una questione simbolica, ma per la promessa che rappresenta: quella di condurre una ristrutturazione profonda dell’università usando le tecniche più avanzate del management qualitativo. Tecniche che sono state migliorate dopo un esordio ancora grezzo nelle Grandes Écoles di Parigi alla fine del xix secolo; che sono state poi efficacemente incarnate sia da Robert McNamara, con la rivoluzione da lui operata alla Ford e in seguito con il suo lavoro al ministero della Difesa negli anni Sessanta dello scorso secolo, sia da Margaret Thatcher, con la sua rivoluzione manageriale che ha riconfigurato la politica britannica in materia di istruzione e welfare negli anni Ottanta; che sono state successivamente affinate grazie allo sviluppo nel management industriale della misurazione quantitativa della produttività di individui e unità, misurazione adottata e ulteriormente sviluppata dalla Banca Mondiale; che sono state infine portate alla quasi perfezione, almeno per quanto riguarda l’istruzione superiore, dalle principali università americane, fino alla Ivy League.
Sappiamo, da fonti confidenziali interne alla Yale Corporation, quanto la professoressa Rice li abbia affascinati durante il suo colloquio di lavoro. Ha detto di ammirare quel saggio mix di feudalesimo (politico) e capitalismo (nella gestione finanziaria) che Yale è riuscita a salvaguardare e che si adatta perfettamente alle riforme da lei immaginate. Così come ammira un’altra lunga tradizione di Yale: la celebre «autocrazia partecipatoria» applicata alla governance interna. Ma è stato il suo articolato piano di riqualificazione universitaria – o, per essere più precisi, il suo piano per migliorare la posizione di Yale nelle classifiche universitarie – a convincere la Yale Corporation che la Rice fosse la risposta alle loro preghiere.
Il suo primo intervento è stato quello di scrostare via le antiquate pratiche usate da Yale per assumere, promuovere e garantire il corpo docente. Come ha chiarito, queste erano soggettive, medievali, non sistematiche...