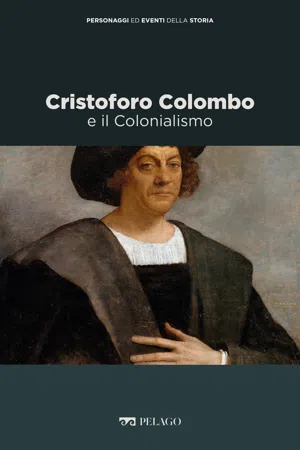
eBook - ePub
Cristoforo Colombo e il Colonialismo
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Cristoforo Colombo e il Colonialismo
Informazioni su questo libro
La scoperta dell'America e, poco più tardi, quella della rotta marina verso l'Asia con la circumnavigazione dell'Africa, trasformarono completamente il panorama geopolitico dell'Occidente. Il nuovo scenario di potere, ricchezze e commerci passò dalla terraferma agli oceani, il Mediterraneo perse il suo ruolo di epicentro economico, le monarchie europee, con la Spagna in testa, avviarono la colonizzazione di altri continenti. Ma l'Europa dovette misurarsi con nuovi problemi: la schiavitù e il relativo diritto ad assoggettare i popoli "barbari", l'umanitarismo cristiano e il razionalismo laico nei loro confronti, la legittimazione giuridica e teologica dell'esercizio della forza da parte dei colonizzatori. Sullo sfondo, nella visione eurocentrica, le popolazioni "primitive" del Nuovo Mondo e dell'Africa, debellate e decimate da conquiste brutali e dalle "nuove" malattie portate dagli europei, e viste in alcuni casi come "dono divino".
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Cristoforo Colombo e il Colonialismo di Vittorio H. Beonio-Brocchieri, AA.VV.,AA.VV., Vittorio H. Beonio-Brocchieri in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Didattica generale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Didattica generaleGLI EVENTI
IL MONDO PRIMA DI COLOMBO: CONNESSIONI “LENTE” MA IMPORTANTI
Nelle sue Osservazioni sulla storia, Voltaire afferma che «uno studio serio» della Storia poteva tranquillamente cominciare dalla fine del XV secolo:
“GRAZIE ALL’AUSILIO DELLA BUSSOLA SI CIRCUMNAVIGA L’AFRICA E IL COMMERCIO CON LA CINA DIVENTA PIÙ AGEVOLE DI QUELLO TRA PARIGI E MADRID. L’AMERICA È SCOPERTA; SI CONQUISTA UN NUOVO MONDO E IL NOSTRO È INTERAMENTE TRASFORMATO […].”
Possiamo senz’altro essere d’accordo sul significato epocale di quella che siamo soliti chiamare “l’Età delle scoperte geografiche” ma proprio per comprendere meglio la sua portata, è opportuno inserire questa stagione in un quadro più ampio. Se infatti i viaggi di Colombo, di Da Gama, di Magellano e di tanti altri sono stati il punto di partenza di una storia totalmente nuova, essi sono anche il punto di arrivo di processi in atto da tempo. Non possono essere considerati solo l’espressione dell’audacia, del genio o, in qualche caso, della temerarietà, di individui straordinari. Questi protagonisti, alcuni effettivamente dotati di capacità eccezionali, altri forse soprattutto fortunati, sono coloro che hanno tenuto a battesimo il Mondo Moderno, ma erano loro stessi uomini del Vecchio Mondo, del “Medioevo” per semplificare un po’. Le motivazioni che hanno spinto costoro ad avventurarsi sull’Oceano – e i loro finanziatori, pubblici e privati, a sostenere e a promuovere le loro imprese – sono comprensibili solo se guardiamo oltre le loro vicende e caratteristiche individuali. E anche oltre l’Europa. Molto oltre. Cominciamo quindi con un giro d’orizzonte sul Vecchio Mondo, prima delle grandi scoperte.
All’interno del Vecchio Mondo – ovvero l’Eurasia e l’Africa – i contatti e gli scambi fra popoli e culture hanno da sempre avuto un ruolo fondamentale. Tutte le civiltà sono il prodotto di contaminazioni e meticciati, anche se in molti casi civiltà geograficamente lontane si sono influenzate senza conoscersi o quasi, come nel caso dell’Impero romano e di quello cinese. Insomma l’Eurasia, anche prima di Colombo o meglio, in questo caso, prima di Vasco da Gama, era già un intreccio di storie connesse. Si trattava tuttavia di “connessioni lente”, discontinue, perennemente minacciate da cambiamenti climatici, catastrofi naturali, irruzioni di popolazioni ostili, rivoluzioni religiose, epidemie e altri disastri.
Più che di un sistema-mondo unitario e integrato si può parlare di una molteplicità di circuiti che si intersecano e i cui confini sono stati soggetti a continue ridefinizioni. Gli storici hanno proposto varie versioni, per le diverse epoche, di questa “rete di reti” che si estendeva dalla penisola iberica e dal Maghreb fino al Giappone. Quello che conta, ai fini del nostro tema, è che le migrazioni degli uomini, i movimenti di merci e la circolazione di idee non erano mai venuti meno. In certe fasi storiche, per esempio quelle successive alle conquiste di Alessandro Magno, nel IV secolo a.C., o dei mongoli, nel XIII secolo d.C., questi flussi sono stati più intensi. In altre, come durante e dopo la crisi dell’Impero romano e della dinastia cinese degli Han, i contatti erano stati più sporadici. Non si erano mai, però, interrotti del tutto.
Le cosiddette “Via della Seta” (attraverso l’Asia Centrale) e “Via delle Spezie” (lungo le coste dell’Oceano Indiano), non sono altro che due etichette di comodo – e un po’ fuorvianti – per indicare i legami che quasi da sempre hanno unito fra loro le civiltà. Anche l’Africa subsahariana partecipava a pieno titolo a questo sistema di scambi. Ai due assi di comunicazione più noti, sarebbe quindi bene aggiungerne un terzo, una “Via dell’Oro” (ma anche degli schiavi e dell’avorio) che univa le coste del golfo di Guinea alle città del Maghreb e all’Egitto, attraverso il deserto del Sahara. È a questa Via dell’Oro che devono la loro fortuna città come Sijilmasa o Timbuctu e regni potenti come quello del Mali, del Ghana o di Songhai. Quando, nel 1324, il mansa (re) Musa dell’Impero del Mali, musulmano, soggiornò qualche tempo in Egitto, sulla via del pellegrinaggio alla Mecca, l’immensa quantità di oro, che lui e il suo seguito riversarono nell’economia egiziana, provocò una svalutazione del metallo giallo del 10-20%.
Nell’immaginazione romantica (ed eurocentrica) questi grandi assi di collegamento li vediamo percorsi da grandi carovane o gigantesche navi che trasportavano le ricchezze dell’Oriente destinate ai ricchi consumatori dell’Occidente. La realtà era però più complessa. La maggior parte degli scambi avveniva a breve e a medio raggio. Poche decine o tutt’al più poche centinaia di chilometri. Solo le merci più preziose, con un valore molto elevato rispetto al peso, sopportavano costi di trasporto molto alti e potevano viaggiare su lunghe o lunghissime distanze: appunto oro (e argento), spezie e seta, dalle quali le nostre due (o tre) vie hanno preso la loro denominazione.
Non dobbiamo poi dimenticare che queste rotte e questi itinerari non erano percorsi solo da mercanti con le loro mercanzie. Queste vie sono almeno altrettanto importanti per la storia religiosa, culturale, tecnica e politica quanto per quella economica.
È, per esempio, grazie alla Via della Seta che il cristianesimo, nella sua variante nestoriana [la dottrina del vescovo siriano Nestorio del IV secolo, che separava le due nature di Cristo – ndr] ha raggiunto, fin dalla tarda antichità, la Cina. Ed è ancora attraverso questa via che l’India ha “esportato” il buddismo in Tibet, Cina e Mongolia, mentre l’induismo ha raggiunto le isole dell’odierna Indonesia con le navi che percorrevano le rotte dell’Oceano Indiano. L’Islam, nella sua inarrestabile diffusione tra l’VIII e il XV secolo, ha utilizzato con grande successo tutti questi grandi itinerari: raggiungendo la Cina attraverso l’Asia Centrale, l’Insulindia e le Filippine attraverso l’Oceano Indiano e il Mar Cinese Meridionale, l’Africa subsahariana attraverso il deserto e la navigazione lungo le coste dell’Oceano Indiano.
E insieme alle fedi religiose, una componente decisiva anche se non unica dell’identità delle diverse civiltà, circolavano modelli artistici e soluzioni tecniche. Pensiamo all’influenza dell’arte greca su quella indiana, nei secoli successivi alle conquiste di Alessandro. Oppure alla staffa, alla polvere da sparo, alla bussola, alle tecniche di produzione della carta, di lavorazione della seta e del cotone, ai numeri cosiddetti arabi, in realtà indiani.
Insomma, Colombo e gli altri non hanno “sfidato l’ignoto” secondo quanto affermato da una formula convenzionale.
Sapevano, o almeno credevano di sapere, cosa li attendeva al di là del mare. La millenaria storia di un “mondo connesso” aveva sedimentato immagini, aspettative, bramosie. In molti casi si trattava di immagini distorte o anacronistiche e aspettative destinate a rivelarsi illusorie: Colombo, navigando verso Occidente sperava di raggiungere una Cina che era ancora il Kathay di Marco Polo, la Cina dei mongoli che non esisteva più da un secolo. Era insomma la luce di una stella estinta. Per non parlare delle isole leggendarie che punteggiavano l’Oceano: O’Brasil, Antilia, l’isola di San Brandano eccetera.
Ma anche in questi ultimi casi, non è facile separare la realtà dalla pura e semplice immaginazione. Tra le fonti d’ispirazione dei protagonisti delle scoperte non c’erano solo cosmografi antichi e moderni, più o meno attendibili, da Claudio Tolomeo (II sec. d.C.) al fiorentino Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482). Oppure gli scritti di viaggiatori reali, come Marco Polo, o immaginari come Giovanni di Mandeville. C’erano anche le chiacchere che la gente di mare si scambiava nei porti: il ricordo sfocato e deformato di peregrinazioni di eremiti irlandesi, di pescatori bretoni o di avventurieri norvegesi.
E poi c’erano le missive confidenziali dei mercanti, le informazioni riservate che ambasciatori, e spie inviavano ai loro sovrani. Di tutta questa circolazione di notizie informale e riservata possiamo intravedere qualcosa e fare delle supposizioni, destinate per lo più a rimanere tali. L’immagine che del mondo avevano i navigatori del XV e XVI secolo era certamente approssimativa e per molti versi ingannevole, ma era anche probabilmente più ricca e complessa di quello che crediamo.
Per gli europei del Tardo Medioevo, per esempio, il fatto che ad Occidente, oltre l’Oceano, esistessero altre terre e terre abitate era scontato. La storia degli insediamenti vichinghi in Groenlandia e oltre, si era conclusa solo da pochi decenni (alla Curia di Roma insistevano nel nominare vescovi per questa remota diocesi e ad aspettare il pagamento delle decime, in avorio di narvalo). Che poi si trattasse di un continente sconosciuto e non di un’estrema propaggine dell’Asia, era un’altra faccenda.
ZHENG HE, UN’OCCASIONE SPRECATA
La Groenlandia era del resto presente nella cartografia europea. Come nel famoso mappamondo, realizzato verso la metà del Quattrocento a Venezia dal monaco camaldolese Fra’ Mauro. Un vero compendio delle conoscenze geografiche dell’Europa del tempo, che presenta però particolarità curiose. Il Continente africano viene per esempio, raffigurato in modo abbastanza realistico e non come lo aveva concepito la massima autorità geografica dell’antichità, Tolomeo, secondo il quale sarebbe stato impossibile arrivare direttamente in India via mare circumnavigando l’Africa perché l’Oceano Indiano era immaginato come un mare chiuso.
Tra l’altro, proprio in prossimità delle coste dell’attuale Capo di Buona Speranza, vi sono un cartiglio e un disegno che fanno riferimento alla frequentazione di queste acque da parte di giunche cinesi. Se nel caso dell’Atlantico del Nord, abbiamo a che fare con circuiti d’informazione ufficiosi e di modesto livello, qui siamo invece di fronte ai vertici della cultura del tempo. Tra le fonti di Fra’ Mauro vi fu il veneziano Niccolò de’ Conti, le cui rocambolesche peregrinazioni in Asia furono poi raccolte dall’umanista Poggio Bracciolini. E le avventure di Niccolò coincidono cronologicamente con uno degli episodi più spettacolari e discussi della storia delle grandi navigazioni: le spedizioni guidate tra il 1405 e il 1433 dall’ammiraglio cinese Zheng He, dalle coste cinesi a quelle, appunto, dell’Africa Meridionale.
Le imprese di Zheng He e delle sue giunche dimostrano che almeno un’altra grande civiltà, quella cinese, aveva nel XV secolo sia i mezzi sia la volontà per portare a termine navigazioni oceaniche.
Anzi, dal punto di vista tecnico, le giunche cinesi facevano segnare vari punti a loro vantaggio. Le dimensioni innanzitutto. Il confronto impietoso fra le enormi giunche di Zheng He, lunghe oltre 120 metri, e le modeste caravelle di Colombo, che non superavano i 30, è diventato uno dei luoghi comuni del revisionismo storico sull’Età delle scoperte. Le giunche, inoltre, vantavano innovazioni che in Occidente si sarebbero diffuse molto più tardi, come i compartimenti stagni che assicuravano maggiori possibilità di sopravvivenza in caso di incidente. Oltretutto le caravelle, come ben noto, erano solo tre e le navi con le quali Vasco da Gama giunse a Calicut quattro. Le flotte cinesi, formate da oltre 300 imbarcazioni, erano vere e proprie città galleggianti con equipaggi, fra marinai e soldati, di oltre 30.000 uomini.
Nella seconda metà del Quattrocento, la Cina era probabilmente la civiltà tecnicamente più avanzata e forse la più ricca, certamente la più popolata. In sintesi quella che poteva sembrare nella posizione più favorevole per avviare il processo di mondializzazione.
Come sappiamo, tuttavia, la storia è andata diversamente. Le grandi spedizioni delle giunche terminarono bruscamente verso il 1430 per volontà del governo imperiale. Questo cambiamento di indirizzo politico è stato spesso interpretato come la conseguenza della natura irrimediabilmente conservatrice della civiltà cinese e del suo disinteresse, se non aperta ostilità, per ogni novità e per tutto ciò che era straniero. La realtà è però più complessa e le ragioni vanno cercate in un intreccio di motivazioni culturali, geopolitiche ed economiche. In fondo, nei secoli precedenti, sia la dinastia mongola degli Yuan sia quella autoctona dei Sung erano state molto attive sui mari. Il viaggiatore e giurista musulmano Ibn Battuta, che nel corso del Trecento percorse tutto il mondo musulmano, dal Marocco all’Insulindia, affermò che, almeno fino alle coste orientali dell’India, le giunche cinesi avevano il quasi-monopolio dei traffici commerciali.
Ciò che mancava ai cinesi non erano le capacità tecniche ma le motivazioni per spingersi al di là degli orizzonti conosciuti, cioè quelli dell’Oceano Indiano. Le motivazioni politiche innanzitutto, perché l’Impero, per quanto grande, non aveva una tradizione di espansionismo aggressivo e la sua classe politica era composta da letterati e burocrati e non da un’aristocrazia di origini guerriere come quella europea. Quelle religiose, perché il confucianesimo e le altre correnti filosofiche o religiose cinesi non avevano una vocazione al proselitismo. E motivazioni economiche, perché non erano molti i prodotti esotici per i quali vi fosse in Cina una domanda effettiva, e tutti provenivano dalle terre e dalle isole bagnate dal Mar Cinese Meridionale o dall’Oceano Indiano o dalle steppe confinanti. Dalle poco conosciute regioni poste più ad occidente, in sostanza dall’Europa, arriva poco o nulla.
Il compito principale delle flotte guidate da Zheng He era quello di ribadire, talvolta in modo piuttosto concreto, ma per lo più solo simbolicamente, la preminenza culturale del Celeste impero nell’ambito di quella che considerava la sua sfera di pertinenza, ossia l’intera Asia Orientale e Meridionale.
In sostanza si trattava di “mostrare la bandiera” e quelli che venivano scambiati con i potentati locali erano “tributi” – o almeno così amavano considerarli i cinesi – e doni. Il che non esclude che abbiano avuto importanti ripercussioni economiche, stimolando, per esempio, la produzione indiana di pepe o provocando un forte aumento del costo delle spezie anche nel Mediterraneo. Le grandi flotte di giunche, per quanto spettacolari, si muovevano quindi lungo itinerari ben conosciuti, non oltrepassando mai i rassicuranti confini della navigazione regolata dal regime dei monsoni. Anche perché, nonostante le loro caratteristiche avanzate per l’epoca, le giunche erano poco adatte alla navigazione controvento.
Le imponenti spedizioni di Zheng vanno anche collocate in una congiuntura interna e internazionale molto particolare. Zheng He era un eunuco musulmano, con ascendenze mongole e nato nello Yunnan, una regione che allora non faceva parte della Cina propriamente detta. Era quindi un outsider nella conservatrice società cinese, e le sue imprese erano state rese possibili da una situazione politica particolarmente favorevole. L’imperatore Yongle, un usurpatore, aveva bisogno di risultati di prestigio per legittimare la sua posizione e, inoltre, a corte si determinò la momentanea prevalenza di una coalizione di orientamenti e intere...
Indice dei contenuti
- Collana
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- «Indos veros homines esse»
- PANORAMA
- FOCUS a cura di Vittorio H. Beonio-Brocchieri
- APPROFONDIMENTI
- Piano dell’opera