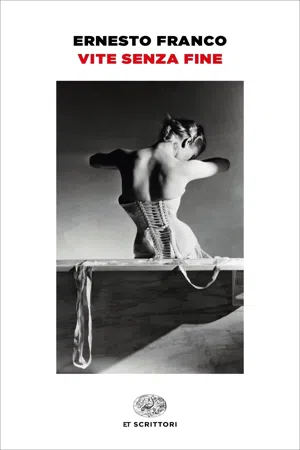Dopo aver venduto la rondella da quindici, il chiodo cavallottino storto e la spada di legno, Gio Magnasco sentí di averli perduti. Il nipote del contabile di quella che sarebbe stata la ditta «Gio Magnasco & Gigli» dice che il racconto faceva parte delle poche moralità che il nonno all’ultimo ripeteva anche a sproposito. Gio Magnasco – continua il racconto – provò allora la solitudine minore. Quella che dànno gli affari conclusi vendendo qualcosa che non si è mai comprato. È la solitudine dell’indipendenza, quella che provano gli uomini appena liberati.
Ora Gio Magnasco si compra un vestito scuro, di quelli che nella città ricurva si usano per entrare negli uffici degli altri, per presenziare ai matrimoni dei parenti e per prender parte al proprio funerale. Compra anche una cravatta bellissima ed enorme. Impeccabile, ma con un ingombrante groppo alla gola e sopra la gola, entra nell’ufficio personale dei cantieri Perrone. Dietro gli occhiali degli occhi della testa calva di chi gli guarda – con una certa ammirazione per il coraggio – il nodo della cravatta c’è una finestra, e dietro la finestra mille piccoli uomini si muovono con martelli, picchetti e traverse sotto una prua infinita che scompare sopra la testa calva sopra la finestra sopra la baracca e – c’è da immaginarsi – sopra la città ricurva.
– Da dove vieni?
– Torino.
– Non una grande città di mare.
– Una città.
– Anni?
– Venti.
– Bel nodo. Ne sai fare altri?
– Gassa d’amante. Piano. Bandiera. Savoia.
– E come mai?
– C’è un fiume.
– Ah. Quello della cravatta?
– No.
– No cosa?
– Non lo so fare.
– Quello dell’impiccato?
– Neppure.
– Meno male. Qui si fanno cose che galleggiano.
– Barche.
– Navi.
– Certo.
– Sai nuotare?
– Sí.
– Anche senza corrente?
– Sí.
– Tu che cosa mi dici di tuo?
– Mi piace mettere insieme le cose. E che ci restino.
– Dove?
– Insieme.
– La paga minima.
– Sí.
– Si lavora fino a quando c’è bisogno.
– Sí.
– A domani.
– A domani.
– Ah?
– Sí?
– Noi qui siamo gente che lavora.
– Sí.
Gio Magnasco divenne parte del cantiere un sabato, giorno di mezza paga e tre quarti di lavoro. Per piú di un’ora si aggira muto sotto un cielo di ferro che rimbomba di colpi. Nessuno gli dice che cosa fare, nessuno lo nota. Parlano le mani, le mazze, le immense ordinate d’acciaio che iniziano a trasformare quella materia in un nome, una carena. Da un grappolo di schiene curve parte di slancio una cosa simile a un dito di legno che finisce in un’unghia di ferro. Gio Magnasco è sulla traiettoria e si spegne come se qualcuno gli avesse soffiato sopra. Si sveglia dopo un tempo eterno senza istanti e senza sogni. Ha la faccia bagnata.
– Ti ho centrato in pieno.
– Ah, ecco.
– Fa male?
– Sí.
Gio Magnasco prova a muovere un braccio. Lo guarda come fosse una leva di morsa. Il braccio si muove un po’ disordinatamente.
– È che non dovevi essere lí. Anzi, non dovevi proprio essere in nessun posto. Non ci hanno detto niente. Stai in piedi?
– Ci provo.
– Attento. Vai fino a quella gomena. Ora torna indietro. Come va?
– Sí.
– Allora?
– Sono qui, scusate.
– Niente. Oggi abbiamo finito e si va a casa. Domani ritorni, ti fermi immobile al cancello e chiedi di me. Sono quello con il berretto blu. È facile.
– Domani è domenica.
– Vuoi andare a messa?
– No.
– A domani.
Gio Magnasco uscí dal porto. Procedeva ben dritto, ma camminava come un uomo di legno. I cardini delle giunture si erano risentiti per il colpo. Il movimento lo davano per intero, ma nel punto di massima estensione qualcosa si inceppava per un istante. Questione di millimetri, roba da niente se si potessero carteggiare rotule, gomiti e clavicole. Ma se non è possibile il ritmo del movimento resta inadeguato, non rende.
L’uomo di legno raggiunge i portici, passa sbandando davanti alle velerie, ai negozi di cordami, al magazzino delle vernici e centra il suo carruggio. Centra la pensione e la stanza dentro la pensione. Esce dopo un istante con il cartello che gli serví poi da prototipo per molti altri, «Gio Magnasco. Lavoratore navale. Bussare adagissimo». Lo appende alla porta della stanza con un cancano da undici. Il legno è morbido e basta la pressione del dito. La domenica alle sei suonano tutte le campane. Anche quella del porto. Con le orecchie piene di cotone, Gio Magnasco chiede all’entrata del cantiere, fermo immobile al cancello, dell’uomo con il berretto blu. Da lí lo vedeva. Era fermo a gambe larghe sotto la prua della nave. Due uomini gli stavano ai lati e lui poggiava le mani sulle loro spalle. Dalla prospettiva di Gio Magnasco il gruppo sembrava l’ultimo cavalletto di sostegno della grande chiglia che si spingeva verso il cielo ancora incompiuta. Qualcuno andò ad avvisare l’uomo con il berretto blu, ma il dialogo concitato fra i due operai su cui lui appoggiava le mani continuò come se nulla fosse. All’improvviso scattano l’uno contro l’altro, e restano impigliati a distanza nella morsa di Facundo, che non flette neppure le braccia. I due agitano in aria pugni che restano lontani dal bersaglio. Ora Facundo deve parlare perché muove un poco la testa con il berretto blu a sinistra e a destra. Poi allarga le braccia di scatto, con un gesto grande. I due si voltano le spalle e tornano al lavoro.
– Mi chiamo Facundo.
– Lo so.
– Come fai a saperlo?
– Me l’hanno detto qui.
– Bene, ora te lo ridico io, cosí lo sai. Mi chiamo Facundo.
– Sí.
– Non sono spagnolo e chiacchiero poco. Solo che i miei lontani sono stati giú, come quasi tutti qui nel levante. E un nonno nato là si è chiamato Facundo, e cosí io. Ieri hai disturbato il cantiere. Non va. La nave vuole tempo che non c’è. Qui il dritto di prua va bene, ma guarda laggiú dove sembra tornare il sole, le ordinate dello scafo sono ancora nude al cielo. Bisogna che siamo una testa sola con mille mani. Come le formiche. E i nostri gesti devono diventare il ferro che prende forma per dare vita alla nave. Solo la vita riesce a stare sull’acqua. Tutto il resto va a fondo. Questo che vedi sopra la tua testa starà sotto i piedi del marinaio e si chiamerà, quando avremo finito il nostro lavoro, opera viva. Perciò non devi mai essere in nessun posto per caso. Ora va’, a quella mano manca un uomo. Ti stanno aspettando.
Per diciotto mesi Gio Magnasco spinse un carrello di metallo verso un gruppo di cinque uomini che ne estraeva pezzi di lamiera per l’opera viva.
Era il Principessa Mafalda, un transatlantico di novemiladuecentodieci tonnellate di stazza, centotrentasette metri di lunghezza e sessanta di larghezza. Nonostante l’impiego ventiquattr’ore su ventiquattro di novecentosettanta uomini, Facundo aveva capito già nove mesi prima della data di fine lavori che non l’avrebbero rispettata. Dovette fare le cose che odiava, rimproverare gli uomini per lentezze insuperabili, per incidenti inevitabili, per imprecisioni fatali. Toccò anche a Gio Magnasco, che si era attardato a riparare una ruota svirgola del suo carrello.
– Se costruissimo una rotaia a cerchio chiuso sotto la chiglia si andrebbe piú veloci e questi incidenti non ci sarebbero.
– Ci vuole troppo tempo.
– Ne guadagniamo di piú altrove.
– Ti do cinque mani e otto giorni.
La rotaia senza fine venne inaugurata dopo nove giorni. E funzionò cosí bene che fu raddoppiata in verticale per ogni ponte sovrapposto. Su ogni rotaia si muovevano simmetricamente cinquanta carrelli, a bordo di ognuno dei quali una coppia di operai eseguiva il proprio lavoro in un tempo calcolato e poi veniva trasferita automaticamente alla fase successiva. Per dare il tempo a tutto l’insieme, Gio Magnasco aveva studiato un sistema di trasmissione attivato da quindici squadre di venti ciclisti ciascuna che si alternavano ai pedali di biciclette inchiodate a terra e collegate con un complesso giro di catene alle ruote dei carrelli. Al traino della volata immobile di trecento ciclisti, la nave si armava. Il ferro, il legno, la forza, le assi diventavano la sentina, la stiva, la coperta, il timone. Gio Magnasco imparava quelle parole e intanto improvvisava la sintassi che le teneva unite.