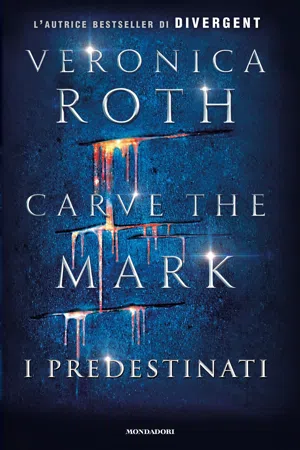I fiori del silenzio sbocciavano sempre nella notte più lunga. L’intera città celebrava il giorno in cui l’involto di petali si schiudeva in un tripudio di rosso, in parte perché i fiori del silenzio erano la linfa vitale della nazione e in parte, pensava Akos, per impedire che tutti impazzissero per il freddo.
Quel giorno, il giorno del rito della Fioritura, Akos sudava dentro il suo cappotto mentre aspettava che il resto della famiglia si preparasse. Uscì in cortile per rinfrescarsi. La casa dei Kereseth era un cerchio di mura intorno a una stufa e aveva tutte le pareti curve, sia quelle esterne che quelle interne. Quasi sicuramente perché era di buon augurio.
Akos aprì la porta e il freddo pungente gli ferì gli occhi. Si affrettò ad abbassare gli occhiali protettivi e il calore della pelle appannò le lenti all’istante. Afferrò maldestramente l’attizzatoio con la mano guantata e lo infilò sotto la cappa della stufa. Le pietrecarbone sembravano solo grumi neri prima di accendersi per effetto dell’attrito, ma poi sprigionavano scintille di colori diversi, a seconda della polvere di cui erano cosparse.
Quando Akos le smosse, si illuminarono di un rosso vivo, come di sangue. Non erano là fuori per fare luce o riscaldare: erano lì solo per richiamare il pensiero sulla corrente. Come se non bastasse il mormorio nel corpo di Akos a ricordargliela. La corrente fluiva attraverso tutti gli esseri viventi e si mostrava nel cielo in tutti i diversi colori. Come le pietrecarbone. Come le luci dei flottanti che sfrecciavano sopra la sua testa diretti in città. I fuorimondo che pensavano che il loro pianeta fosse bianco di neve in realtà non ci avevano mai messo piede.
Il fratello maggiore di Akos, Eijeh, sporse fuori la testa. «Tanta voglia di congelare, eh? Su, la mamma è quasi pronta.»
Quando andavano al tempio sua madre ci metteva sempre un po’ più del solito a prepararsi. Dopotutto, era l’oracolo. Avrebbe avuto addosso gli sguardi di tutti.
Akos posò l’attizzatoio e rientrò, strappandosi via gli occhiali e calandosi fino alla gola la visiera di protezione.
Suo padre e sua sorella maggiore, Cisi, aspettavano accanto alla porta, infagottati nei loro cappotti più caldi, tutti col cappuccio e tutti di pelliccia di kutyah, un materiale che non assorbiva le tinte e che quindi aveva sempre un colore grigio biancastro.
«Tutti pronti allora, Akos? Bene.» La mamma si stava chiudendo il suo. Gli occhi le caddero sui vecchi stivali del marito. «Da qualche parte là fuori, le ceneri di tuo padre stanno rabbrividendo per quanto sono sporchi i tuoi stivali, Aoseh.»
«Lo so, è il motivo per cui mi sono tanto dato da fare per sporcarli» rispose l’uomo sorridendo.
«Bene» disse, o meglio cinguettò, lei. «A me piacciono così.»
«A te piace qualunque cosa non piacesse a mio padre.»
«Questo perché a lui non piaceva niente.»
«Possiamo salire sul flottante finché è ancora caldo?» disse Eijeh, con un tono lamentoso nella voce. «Ori ci aspetta al memoriale.»
Sua madre finì di allacciarsi il cappotto e indossò la visiera. Percorsero goffamente il vialetto di casa, intabarrati nelle loro pellicce, muffole e occhiali protettivi. Una nave bassa e rotonda li attendeva sospesa ad altezza ginocchio, appena sopra la neve ammonticchiata. Lo sportello si aprì al tocco della donna e tutti si accalcarono dentro. Cisi e Eijeh dovettero tirare su Akos per le braccia perché era troppo piccolo per salire da solo. Nessuno si preoccupò delle cinture di sicurezza.
«Al tempio!» gridò il padre, sollevando il pugno nell’aria. Lo diceva sempre quando ci andavano. Era un po’ come esultare per una conferenza noiosa o per la lunga coda il giorno delle elezioni.
«Se solo potessimo imbottigliare questa eccitazione e venderla a tutti i thuvhesiti. Molti li vedo solo una volta a stagione e anche allora solo perché li attendono cibo e bevande» disse la donna strascicando le parole, con un debole sorriso sul volto.
«Allora, ecco la soluzione» disse Eijeh. «Attirali con il cibo per tutta la stagione.»
«La saggezza dei bambini» rispose sua madre, premendo il pollice sul pulsante dell’avviamento.
Il flottante si mosse bruscamente verso l’alto e in avanti, facendoli cadere tutti l’uno sull’altro. Eijeh spinse via Akos, ridendo.
In lontananza brillavano le luci di Hessa. La città si avvolgeva intorno a una collina: la base militare in basso, il tempio in cima e tutti gli altri edifici nel mezzo. Il tempio, a cui erano diretti, era una grossa struttura di pietra con al centro una cupola composta da centinaia di pannelli di vetro colorato. La sommità della collina si illuminava di un colore rosso arancione quando vi batteva il sole. Il che significava che non accadeva quasi mai.
Il flottante risalì il pendio, sorvolando dolcemente la città rocciosa, antica quanto il loro pianeta-nazione: Thuvhe, come lo chiamavano tutti tranne i loro nemici, una parola dal suono così scivoloso che i fuorimondo si imbrogliavano nel pronunciarla. Metà delle strette case era sepolta sotto cumuli di neve. Erano quasi tutte vuote. Chiunque contasse qualcosa stava andando al tempio quella sera.
«Visto niente di interessante oggi?» chiese il padre alla moglie. Deviò il flottante per evitare un anemometro particolarmente alto che si allungava verso il cielo, girando su se stesso.
Akos capì dal tono che il padre stava chiedendo alla madre delle sue visioni. Ogni pianeta della galassia aveva tre oracoli: uno in ascesa; uno in carica, come sua madre; e uno in declino. Akos non capiva fino in fondo che cosa significasse, se non che la corrente sussurrava il futuro alle orecchie di sua madre e che in tanti, incontrandoli, la guardavano con reverenza.
«Forse ho visto tua sorella l’altro giorno…» cominciò a dire lei. «Ma dubito che vorrebbe saperlo.»
«Lei pensa solo che bisognerebbe maneggiare il futuro con il dovuto riguardo, in considerazione del peso che ha.»
La donna fece scorrere lo sguardo sui tre figli.
«Questo è ciò che mi tocca per essermi imparentata con una famiglia di militari, immagino» aggiunse poi. «Voi vorreste che tutto fosse regolamentato, persino il mio donocorrente.»
«Noterai che ho mandato all’aria le aspettative della mia famiglia e scelto di essere un contadino, non un capitano dell’esercito» rispose il padre. «E mia sorella non intende insinuare niente di particolare, è solo una cosa che la rende nervosa, tutto qui.»
«Mmh» commentò la madre, come se non fosse tutto lì.
Cisi, che stava guardando fuori dal finestrino senza prestare attenzione al battibecco, cominciò a canticchiare a bocca chiusa una melodia che Akos aveva già sentito ma non ricordava dove. Pochi istanti dopo, la discussione tra i loro genitori si spense e rimase solo la sua voce sommessa nell’abitacolo. Cisi aveva un certo non so che, piaceva dire a suo padre. Una particolare serenità.
Il tempio era illuminato, dentro e fuori. File di lanterne non più grandi del pugno di Akos erano appese sopra l’ingresso ad arco. C’erano flottanti dappertutto, con strisce di luce colorata intorno alle pance rigonfie; alcuni parcheggiati in gruppi sul fianco della collina, altri che svolazzavano intorno al tetto a cupola in cerca di spazio per atterrare. Sua madre conosceva tutti i posti appartati intorno al tempio, per cui indicò al marito una nicchia nell’ombra accanto al refettorio, e poi li guidò di corsa verso una porta laterale che dovette aprire a forza con entrambe le mani.
Percorsero uno scuro corridoio di pietra, camminando su tappeti così logori da diventare quasi trasparenti e oltrepassando il basso memoriale dedicato ai thuvhesiti morti nell’invasione shotet, quando Akos non era ancora nato.
Akos rallentò per guardare la luce tremolante delle candele che illuminavano il monumento e Eijeh gli si avvicinò da dietro e lo prese per le spalle, facendolo saltare per lo spavento. Akos arrossì quando si rese conto di chi era e il fratello gli toccò la guancia con un dito, ridendo. «Si vede persino al buio quanto sei diventato rosso!»
«Smettila!» protestò Akos.
«Eijeh» lo rimproverò la madre. «Non prenderlo in giro.»
Doveva ripeterglielo in continuazione. Ad Akos sembrava di passare la vita ad arrossire per ogni minima cosa.
«Era solo uno scherzo…»
Riuscirono a raggiungere il centro dell’edificio. Davanti alla Sala delle Profezie si era già raccolta una folla. Tutti sbattevano i piedi sfilandosi i copristivali, si liberavano dei cappotti e si ravviavano i capelli appiattiti dai cappucci, soffiando sulle dita gelate per riscaldarle. I Kereseth ammassarono cappotti, occhiali, muffole, stivali e protezioni per il viso in una nicchia buia, appena sotto una finestra viola su cui era inciso il carattere thuvhesita che rappresentava la corrente. Mentre si voltavano per tornare alla Sala delle Profezie, Akos sentì una voce familiare.
«Eij!» Ori Rednalis, la migliore amica di Eijeh, stava arrivando di corsa dal corridoio. Era alta, secca e sgraziata, tutta ginocchia e gomiti e capelli fuori posto. Akos non l’aveva mai vista con un abito elegante, ma quella sera ne indossava uno di un pesante tessuto rosso violaceo, abbottonato sulla spalla come le divise militari da cerimonia.
Aveva le nocche rosse per il freddo. Si fermò davanti ad Eijeh con un salto. «Eccoti. Mi è già toccato sorbirmi due filippiche di mia zia sull’Assemblea e sto per esplodere.» Ad Akos era già capitato di sentire una delle invettive della zia di Ori contro l’Assemblea. Si trattava del corpo governante della galassia, accusato di considerare Thuvhe solo per la sua produzione di fiori del ghiaccio, mentre al contempo minimizzava gli attacchi degli shotet, definendoli “dispute interne”. Non aveva tutti i torti la zia di Ori, ma Akos si sentiva molto a disagio davanti a certi discorsi degli adulti. Non sapeva mai cosa dire.
Ori continuò. «Ciao. Aoseh, Sifa, Cisi, Akos. Felice Fioritura. Su, andiamo, Eij.» Pronunciò la frase senza quasi prendere fiato.
Eijeh guardò suo padre, che lo congedò con un gesto della mano. «Vai, allora. Ci vediamo dopo.»
«E se ti troviamo con una pipa in bocca, com’è successo la stagione scorsa» aggiunse sua madre «ti facciamo mangiare quello che c’è dentro.»
Eijeh sollevò le sopracciglia. Niente lo imbarazzava, non arrossiva mai. Nemmeno quando i compagni di scuola lo prendevano in giro per la sua voce, più acuta di quella degli altri ragazzi, o perché era ricco, cosa che a Hessa non attirava grandi simpatie. Non rispondeva neanche per le rime. Aveva la capacità di chiudere fuori il mondo e lasciarlo rientrare solo quando voleva lui.
Afferrò Akos per il gomito e se lo tirò dietro mentre seguiva Ori. Cisi rimase con i loro genitori, come sempre. Eijeh e Akos rincorsero l’amica per tutta la strada fino alla Sala delle Profezie.
A Ori sfuggì un’esclamazione soffocata quando vide l’interno della sala e, dietro di lei, Akos le fece eco. C’erano centinaia di lanterne, ricoperte di fiori del silenzio per farle apparire rosse, appese a fili che dalla sommità della cupola scendevano a raggiera fino alle pareti, formando un baldacchino di luce sospeso sopra le loro teste. Persino i denti di Eijeh sembravano rossi, quando sorrise ad Akos. Al centro della sala, di solito vuota, c’era un sottile letto di ghiaccio quasi largo quanto un uomo era alto. Dentro il ghiaccio crescevano centinaia di fiori del silenzio, ancora chiusi ma sul punto di sbocciare.
Altre lanterne a pietrecarbone, grandi più o meno quanto il pollice di Akos, erano allineate lungo i bordi del letto dove i fiori del silenzio aspettavano di aprirsi. Queste diffondevano una luce bianca, probabilmente per mettere in mostra il vero colore dei fiori, un rosso più intenso di quello delle lanterne. Intenso come quello del sangue, diceva qualcuno.
Nella sala c’era un viavai di persone con indosso i loro abiti più eleganti: lunghe vesti ampie che lasciavano scoperte solo le mani e la testa, chiuse da elaborati bottoni di vetro di varie tinte; panciotti lunghi fino al ginocchio bordati di morbida pelle di elte e sciarpe avvolte a doppio giro intorno al collo. Dominavano i toni scuri e intensi, in contrasto con il grigio e il bianco dei cappotti. Akos indossava una giacca smessa da Eijeh color verde scuro che gli andava ancora troppo grande di spalle, mentre quella del fratello era marrone.
Ori li guidò dritti verso il rinfresco. Vi trovarono ...