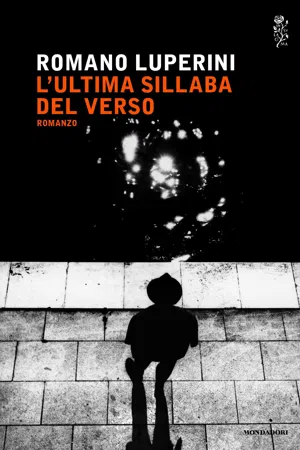![]()
![]()
![]()
![]()
Era novembre il mese della morte di mia madre, il novembre del 1992. Alle sette di sera la strada dell’università sprofondava già nel buio. Fuori dal portone il selciato si stendeva livido e umido, rischiarato a tratti da qualche lampione. La luce, calando in tralice dall’alto, striava le pozzanghere di riflessi violacei.
Piovigginava. La strada era deserta, poche ombre scantonavano nei vicoli e fra le pareti sbrecciate dei palazzi e degli antichi casamenti. Sono i primi giorni di novembre e sembra già inverno, ho pensato sulla soglia, mentre il custode cominciava a chiudere il portone. È la maledizione delle città di provincia, dopo le sette c’è il coprifuoco.
Come ogni lunedì ero l’ultimo a uscire. Non mi sono neppure accorto che qualcuno sulle scale della facoltà stava scendendo di corsa dietro di me.
Mentre m’incamminavo verso l’auto e il pensiero di mia madre mi spingeva ad accelerare il passo, ho sentito un rapido scalpiccio alle spalle. Volgendomi l’ho riconosciuta, era appena venuta al ricevimento, il primo dell’anno accademico appena iniziato. Era una ragazza in jeans, con un golfino grigio pallido da adolescente, la carnagione chiara e intorno al viso una massa di capelli neri. Avevamo parlato di una possibile tesi, poi, senza quasi accorgercene, per qualche minuto, di alcune letture da lei fatte e del tempo, della ossessione del tempo, del modo meticoloso con cui lei lo selezionava, distinguendolo in spazi discreti per incasellarci lo studio, la lettura, il lavoro di segretaria part time presso un avvocato, i preparativi per le nozze imminenti. «Anch’io ho sempre avuto questa ossessione del tempo, ma è una ossessione produttiva, spinge a lavorare di più, a non disperdersi» avevo commentato.
Lei mi ha raggiunto. Ansava dicendo: «Stavo per rimanere chiusa dentro». Sorrideva, offrendo di condividere l’ombrellino. Aveva lasciato l’auto anche lei poco distante, nella stessa direzione.
«Grazie. Ma la farò correre. Ho fretta. Sa, mia madre sta male e stanotte tocca a me vegliarla. Siamo tre fratelli…»
Perché questa confidenza?, mi sono chiesto un attimo dopo. Non c’ero abituato con gli studenti.
I nostri passi risuonavano nel silenzio e nel vuoto. La città sembrava abbandonata dagli abitanti, le finestre chiuse, i portoni sbarrati. Quel suono ripetuto ci avvolgeva, ci creava intorno una protezione di intimità, come se quella comune cadenza ci unisse col suo stesso ritmo. Sentivo il fianco di lei muoversi leggero accanto al mio, i gomiti che si sfioravano, quello di lei un poco sollevato per sorreggere l’ombrello.
Rapidamente siamo arrivati alle auto, parcheggiate lungo lo stesso marciapiede. Al di là di un muro si vedevano rami di alberi che si muovevano piano nell’oscurità. Mi sono fermato con le chiavi della macchina in mano. Mi sono distratto. Per un attimo ho perso il senso del tempo. Eravamo l’uno dinanzi all’altra. La pioggia scivolava giù dall’ombrellino, mi gocciolava sulle spalle.
«Mia madre» ho detto senza ragione «parla un bellissimo toscano, il pistoiese, senza le cadenze strascicate dei fiorentini o le forzature becere dei livornesi. Sa raccontare. Può parlare di una sedia, o di un gomitolo di lana, o di una persona, e ne fa la storia; ogni dettaglio per lei è importante, sembra che si perda dietro i dettagli, e invece no, ogni dettaglio ha la sua dignità, per questo non va perduto o dimenticato, ma poi i dettagli si compongono, si articolano, si snodano in una narrazione che potrebbe durare all’infinito. Mia madre racconta le cose ancora epicamente. Ogni dettaglio, ogni frammento, ha ancora un senso per lei…» Il suo, ho pensato, è un mondo che non esiste più.
Lei ha alzato gli occhi e mi ha guardato. Per un attimo, nell’incontro degli sguardi, è passata una rapida corrente di simpatia, come un’emozione.
«Mia madre» ha detto lei «spesso si lamenta, dice di sentirsi male.» Lo ha affermato come se in fondo ne dubitasse. «Io cerco i sintomi sull’Enciclopedia medica, mi convinco ogni volta che abbia una malattia mortale…»
Dimostra meno anni di quanti ne deve avere, ho pensato.
«Come ti chiami? Mi sono dimenticato il tuo nome» mi sono giustificato, dandole la mano per salutarla. Ero passato al tu, inavvertitamente. Mi succede spesso con gli studenti, è un’abitudine del Sessantotto.
«Claudia, ma mi chiamano Claudina, anzi Dina.»
«Sarebbe meglio Claudine» ho commentato, salendo in auto.
![]()
Dall’altra stanza mi giunge nel sonno il rantolo della madre. Nello stesso istante avverto un fastidio sul viso e sulle dita, come se qualcosa impiastricciasse le guance, le mani, il cuscino. Forse sogno ancora.
Mi scuoto, lotto per riprendere coscienza, per vincere la forza che preferisce l’inconsapevolezza.
È sangue. Una poltiglia rossastra sul guanciale, sulle lenzuola, sul pigiama. Ne sento il naso ostruito, grommoso. Questo sangue è uscito da lì, un fiume di sangue zampillato mentre dormivo.
Mi metto a sedere sul letto. La luce del mattino è già dentro la stanza. Mi tocco il viso. È incrostato, e i capelli sulla fronte impastati. Mi guardo le mani, le dita. Rosse di sangue, scuro, raggrumato. Tendo l’orecchio. Il rantolo continua, invade tutta la camera, è un affanno che si ripete, un fiato angoscioso che erompe a intervalli. Gli seguono pause di silenzio, ogni volta improvvise e paurose, e, a tratti, un lamento, come di bambina disperata. A fiotti la vita le sgorga fuori dal petto, come il sangue di notte da me.
Mi alzo dal letto, devo lavarmi la faccia, cambiare la federa, le lenzuola. Ma prima entro nella stanza di mia madre. Respira a fatica, appoggiata ai cuscini, la bocca semiaperta, gli occhi chiusi. Ha una camicia rosa, una mano si contrae sul lenzuolo e ripete di continuo il gesto convulso di tirarlo in alto, stirandolo proprio sopra l’addome. Mi accosto, mi siedo accanto a lei, ascolto da vicino quel rantolo.
Di colpo lei spalanca gli occhi, fa un movimento come per tirarsi su dal letto, con una mano mi afferra per un braccio. Gli occhi sbarrati, dilatati. «Scusami» dice, «scusami.» Mi stringe il braccio, lo stringe con una forza imprevista, eccessiva. Poi ricade giù, chiude di nuovo gli occhi, la mano si scioglie, lascia la presa.
Si scusa con me per questa agonia che non finisce, per i fastidi che morendo mi provoca? Non vuole essere di peso. Da venti anni, dopo la morte del babbo, pur essendo già molto anziana, abita da sola per non essere di peso ai figli.
Resto immobile, seduto sul letto, invaso dal terrore che possa morire proprio in questo momento e di ritrovarmi qui, solo, senza sapere che fare. Poco dopo sento girare la chiave nella serratura. È mia sorella.
Entra in camera. «Perché questo sangue sulla faccia?» chiede. «Devi misurarti la pressione» aggiunge. Non sembra stupita. Come al solito, sa cosa fare ed è piena di energia e di determinazione. Sistema meglio le coperte intorno al corpo disteso. Poi, «Faccio il caffè» dice e va in cucina, la sento armeggiare intorno al fornello.
Torno in camera, cambio federa e lenzuola. Il letto è lo stesso dove ho dormito per anni da ragazzo. In quella camera, d’inverno, la mattina alle sei la mamma mi svegliava, mi portava lo scaldino acceso da mettere fra i piedi mentre finivo i compiti, prima di andare a scuola. Poi mi apriva la porta, mi guardava scendere la prima rampa di scale, richiudeva solo quando ero già scomparso in basso. Quello sguardo mi ha protetto per tanti anni e ora sta per abbandonarmi. È il cordone ombelicale con la vita che viene tagliato una seconda volta, e per sempre.
Ci ritroviamo in cucina, davanti al caffè, con le orecchie tese a quel rantolo. Anche mia sorella ricorda, ma senza indulgere alla malinconia, con una sua propositiva durezza.
«A scuola mi chiedevano i nomi dei genitori, la firma del padre, e io non sapevo che dire. Io ero figlia di N.N… Figurati in una piccola città, negli anni della guerra e del fascismo… E la mamma, poi… Una ragazza madre, si direbbe oggi…»
«L’hai mai conosciuto, tu, tuo padre?» le chiedo allora. M’accorgo di avere abbassato la voce, senza rendermene conto. Chi sa perché non ne abbiamo mai parlato prima.
«È andato in America prima che io nascessi, e non s’è fatto più vivo. Mai visto e conosciuto. Meglio così… La mamma diceva che era stata lei a rifiutare un matrimonio di convenienza. Quando era rimasta incinta, lui le aveva detto all’improvviso che amava un’altra ma che sarebbe stato anche disposto a sposarla… per dovere, diceva. Meglio sola con una bimba piccola che con un tipo simile. Uno stronzo.» Già si alza, si è messa il grembiule della mamma, in piedi all’acquaio lava le tazze, le asciuga, ripete gli stessi gesti che tante volte ho visto fare a mia madre per anni, ritta in quello stesso punto della cucina.
Quando la mamma veniva a trovarmi a Lucerena, usciva col paniere al braccio, in primavera cercava le violette, le more in agosto, i ciclamini e le castagne in autunno. Metteva i fiori in vasetti trasparenti di vetro colorato, il cumulo nero delle more in una grande scodella di coccio bianco, le castagne in una cesta di vimini sotto la cappa del focolare. Poi si sedeva a fianco della finestra, in un cono di luce, davanti alle grandi rame del cedro del Libano che si muovevano al vento, cuciva, sferruzzava, d’inverno sbraciava lo scaldino con le forbici. Quando la luce si ritirava, s’alzava, cominciava a preparare la cena. A un certo momento, senza far rumore, s’affacciava alla porta dello studio. «Scusa se ti do noia, ma non ti cavare gli occhi» diceva accendendomi la luce, un gesto che per pigrizia mi ostinavo a rimandare. Sempre quella cadenza dei movimenti, quella misura puntuale. Con lei penetrava in casa la sicurezza della ripetizione.
La mamma la ripetizione non la temeva, anzi la riconosceva come una dimensione naturale che va accettata. Mio padre invece mi aveva insegnato a ribellarvisi, cercava l’interruzione, l’intensità, l’obiettivo, la direzione più spedita e rettilinea per raggiungerlo, e io lo imitavo. La vita per lei era molto diversa che per noi: non era fatta a salti, a vuoti di senso che occorre riempire, a momenti da strappare a durate di insensatezza, non era scandita da mete a cui bisognava arrivare per trovare una ragione all’esistenza. La vita per noi era un alternarsi fra molti vuoti e pochi pieni, un’altalena fra depressione ed eccitazione. Per lei era un tutto pieno, fatto di tanti piccoli tasselli, tutti necessari perché tutti collegati fra loro. Mi sono ricordato quanto avevo detto la sera prima a quella laureanda… Claudia, o Dina o Claudine… chi sa perché glielo avevo detto. Ma è vero, per la mamma era così. Il senso non andava cercato, stava lì, in ogni cosa, nelle minuzie della quotidianità, nella lentezza, nella ripetizione, dove io ho disimparato a cercarlo e dove ormai non posso trovarlo più.
![]()
Più tardi giunge anche Bruno, il fratello minore. Come sempre, è inquieto, agitato. Apre gli sportelli in cucina, cerca qualcosa da mangiare, li richiude sbattendoli, risponde al telefono a voce alta. «Ma il compagno Craxi l’ha detto in Parlamento, fanno tutti così» ripete a qualcuno.
Gli affari e la politica lo inseguono anche nella camera della madre. Ha uno studio da geometra e imprenditore edile in Versilia, costruisce, vende case, ed è segretario cittadino del PSI. Conosce tutti, il medico che viene a dare la morfina alla madre è suo amico. Lui non si è fatto illusioni, non ha creduto come me alle utopie, al Sessantotto e tanto meno ai gruppuscoli. Fantasie, dice, o, peggio, incoscienza, pressappochismo…
«La politica è concretezza» ripete in questo momento, «prima o poi lo capirà anche il PCI.» È una delle sue frasi preferite. A chi si rivolge?, mi domando. Ma di colpo cambia argomento, si è lasciato andare su una sedia, affranto, e ora si rivolge direttamente a me.
«Te lo ricordi quando si è alzata dal letto ed è venuta sin qui, in cucina? L’ultima volta che si è alzata… nemmeno dieci giorni fa. È comparsa d’improvviso, nessuno se l’aspettava. Si è seduta al tavolo, in camicia, al posto dove sei tu ora. Mi piacerebbe volare, andare in aereo almeno una volta prima di morire, ha detto. Perché non ci abbiamo pensato prima, perché? Ora è troppo tardi, è troppo tardi, cazzo!»
Veramente io ci avevo pensato. Senza dir nulla a nessuno durante le vacanze estive avevo cercato un posto per me e per lei sul volo Pisa-Olbia. Ma gli aerei erano al completo, mettersi in lista d’attesa non era il caso, e non ne avevo fatto nulla. E poi in quei giorni lei sembrava diventata un po’ opaca, quasi indifferente. A poco a poco si stava già allontanando. Si riparava dietro la sordità, si richiudeva nel silenzio, ostinata, quasi imbronciata. Ma chi poteva sospettare che la malattia già la scavasse dentro. Si incontrano di continuo per strada, in treno, negli uffici, decine di persone che si muovono soddisfatte, scherzano e sorridono con la saliva agli angoli della bocca, e hanno già annidato nelle cellule il male che le rode.
«Andiamo a tavola, mangiamo qualcosa, prima che passi il medico» dice Albertina.
Bruno divora con furia il cibo, trangugia con voracità, ingoiando quasi senza masticare. Ha già vuotato il piatto, quando suona il campanello. «Il medico» dice alzandosi di colpo da tavola, «vado io.» Li sentiamo parlottare, entrare nella camera della mamma. Dopo poco, scendono insieme le scale. Dalla finestra li vedo sul marciapiede di fronte a casa che fumano. Bruno parla e gesticola, deve commentare ancora l’ultima dichiarazione di Craxi. Poi risale le scale e si accascia di nuovo sulla sedia. «Non può durare ancora a lungo» dice. Restiamo in silenzio. «Quest’anno la mamma non farà i necci. Comincia ora la stagione» aggiunge.
Ogni anno a novembre la mamma faceva i necci. Tirava fuori i testi, due forme rotonde e annerite dal fuoco e dal fumo coi lunghi manici color ruggine. Su una delle due spalmava una noce di burro, poi le poneva a riscaldare sulla brace, mentre impastava sul tavolo la farina di castagne e preparava la ricotta. Quando aveva finito e il burro si era sciolto, stendeva l’impasto sulla forma imburrata, e le sovrapponeva l’altra. Bastavano pochi minuti e arrivava il momento di tirare indietro i manici togliendo dal fuoco le due forme accoppiate. A questo punto non restava che far scivolare in un piatto l’impasto rotondo, che era diventato intanto più spesso e duro, versarci sopra la ricotta, e arrotolarlo.
Al tempo delle castagne, mia madre veniva a trovarmi a Lucerena. Nel pomeriggio, dopo aver rigovernato, si metteva il canestro di vimini al braccio e proponeva: «Mi accompagni?». Salivamo su, verso il crinale battuto dal vento, nella selva di castagni dove andavo a raccogliere la legna secca per il camino. «Prendi le più grosse, sono marroni» diceva. Per sgusciarli, scalcagnava i ricci o li stringeva fra le punte delle scarpe, e ne faceva saltare fuori i frutti, così lisci e lucenti che sembravano brillare sul palmo della mano. Quando il canestro era pieno, tornavamo. Mi viene in mente una foto con la mamma in primo piano col canestro e, dietro, sul sentiero, io con un maglione marrone abbottonato sino al collo. Chi l’aveva scattata? Margareth?
«Ma no» dice Albertina, «prenderò io i testi, la mamma mi ha insegnato a fare i necci, e ogni anno in questa stagione vi inviterò a mangiarli tutti insieme. Sarà un modo per ricordarla» dichiara, sollevata.
Ecco, penso, forse saranno le donne a conservare il senso della ripetizione.
![]()
La mamma non era gelosa delle donne dei figli. Si legava alle fidanzate e alle nuore, le proteggeva, non voleva che diventassero vittime della prepoten...