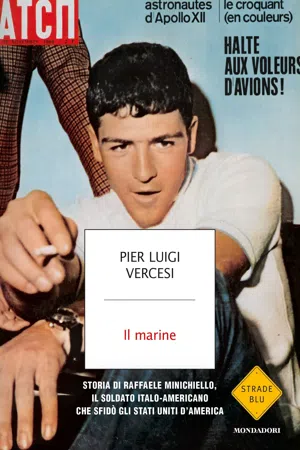Il 3 maggio 1967 un aereo a turboelica decolla da Seattle. Fa scalo a San Francisco. Salgono altre reclute. Nei pensieri di Raffaele scorrono medaglie e bandiere che sventolano in suo onore, il «Seattle Times» e il «Seattle Post» con la sua foto in prima pagina, in divisa, sorridente, da eroe.
Quattro ore di volo e atterrano all’aeroporto di San Diego. Appena scese, le reclute individuano, nell’aerostazione, sergenti con l’uniforme dei marine. Si avvicinano spavaldi: «Salve, siamo il gruppo che viene da Seattle e San Francisco».
«Finalmente siete arrivati, bastardi. In fila, rottinculo figli di puttana. La pacchia è finita. Faremo di voi dei veri uomini mentre qualcuno a casa si sbatte le vostre troiette.»
Li accompagnano all’esterno dell’aeroporto, già menando le mani e anche gli anfibi.
Saliti sul pullman, serrate le portiere, si scatena l’inferno. I sergenti ringhiano: «Seduti, zitti, non muovete un muscolo».
«Perché hai scosso la testa?», e giù insulti e ceffoni.
Le reclute sono terrorizzate. Raffaele scruta con gli occhi senza muovere la testa. Vorrebbe chiedere: «Perché?».
Lo avevano avvisato: «I marine sono dei duri, l’addestramento sarà massacrante».
Ma non dovevano servire la patria? Il presidente Kennedy aveva detto: «Chiedetevi cosa potete fare per il vostro Paese». Il tragitto dall’aeroporto al campo di addestramento è però un breve viaggio nell’inferno.
Arrivati, scendono, in fila, accompagnati da insulti, schiaffi, calci a casaccio, dove colpiscono colpiscono.
Il quartier generale del Marine Corps Recruit Depot di San Diego è un bel complesso di palazzine con portici. Sotto gli archi campeggia il motto: To be a marine you have to believe in yourself, your fellow marine, your corps, your country, your God. Semper fidelis (Per essere un marine devi credere in te stesso, nel tuo commilitone, nel tuo corpo, nel tuo Paese, nel tuo Dio. Sempre fedele).
Un sergente fa l’appello.
Si deve rispondere: «Yes, Sir». Voce forte e chiara.
«Non ti sento, femminuccia.»
Devi gridare il tuo nome almeno tre o quattro volte.
Sembrano tutte anime smarrite, le reclute: marciano in fila indiana poggiando le mani sulle spalle di chi li precede, gli occhi fissi alla nuca del camerata e la voce del sergente che rimbomba nelle orecchie.
Dal barbiere ci sono solo tre posti a sedere, ma il servizio è talmente rapido che non hai il tempo di fermarti. Ora la testa è perfettamente rasata. «Figli di puttana, in fila per quattro finché non siete tutti tosati.»
Dal piazzale di fronte al barbiere si corre verso una costruzione a due piani. Su per le scale di legno fino a uno stanzone con scaffali ad altezza d’uomo. Su ognuno è appoggiata una scatola dove riporre gli abiti da borghese.
«Toglietevi la vostra merda.» L’orologio, la catenina col crocifisso, il portafoglio regalato da mamma: chiusi in un pacco con sopra l’indirizzo di casa.
Di corsa alle docce. «Diventerete marine a costo di farvi vomitare sangue» ringhia il sergente mentre si insaponano, sciacquano e asciugano in tre minuti. Nudi, corrono verso un altro locale per ritirare la biancheria intima. Poi via, zampettando come uccelli impauriti.
«Giù gli asciugamani. Infilatevi le mutande.» Un ragazzo di colore, nella fretta, le infila all’incontrario. Parte una sventagliata di insulti su tendenze sessuali, genitori, fidanzate e quanto di più sacro vi sia.
Terrorizzato, Raffaele Minichiello si accorge di tremare, come tutti gli altri del resto. Non c’è il tempo di compatirsi, né riordinare le idee. Incalza un nuovo ordine da eseguire.
Escono rapidamente e si dispongono in formazione. Almeno ci provano. È ormai buio, il piazzale è rischiarato dalla luce dei lampioni. Mentre ricevono il successivo ordine, qualcuno disgraziatamente si muove. Il sergente diventa una belva: con un calcio lo scaraventa a terra e comincia a picchiarlo alla cieca.
«Vuoi arruolarti nei marine? Bravo figliolo» aveva detto lo sceriffo della contea che lo aveva messo, per la prima volta, su un cavallo. «Sono fiero di te; sarà dura, ma ce la farai.» Non immaginava fosse così dura. Nei documentari, gli addestramenti non erano un bagno di umiliazioni. Eppure i veterani sostengono che questa palestra d’insulti, botte e prevaricazioni salvi la vita di tanti ragazzi in Vietnam.
Marciano in cerchio fino a mezzanotte. Poi li portano a ritirare coperte e lenzuola. Sono stremati. Firmano una ricevuta.
Di nuovo in formazione, scherniti e maltrattati, fino alle baracche assegnate. Nella dotazione c’è un secchio lucido di lamiera zincata dove mettere il necessario per lavarsi, fare il bucato e ramazzare il pavimento quando si è di turno. Può servire anche da sgabello, se trovi il tempo per sederti.
La recluta Minichiello Raffaele è inquadrata nel 3° battaglione comandato dal tenente colonnello Terry, plotone 372, agli ordini del tenente Pinion, del sergente maggiore Phoenix, dei sergenti Bendgen, Ferris (il più piccolo e spietato, con gli occhiali), Sunn e Lackey.
Davanti alle baracche di lamiera, altro sermone: «Da puttanelle vi trasformeremo in marine. Se occorre spaccandovi la zucca».
Possono entrare nelle baracche con i letti a castello allineati su due schiere. Al centro, una stufa a kerosene e due file di cassapanche di legno, una per recluta.
Rifanno i letti, secondo gli ordini, da eseguire all’istante.
Raffaele è sfinito, non vede l’ora di dormire. Dopo aver serrato con il lucchetto a combinazione le sue poche cose nella cassapanca, aspetta l’ordine di infilarsi a letto. Invece li richiamano fuori, dove comunicano che quel giorno sono morti sedici marine «caduti per voi civili di merda. Dovete diventare uomini veri, per vendicare quei ragazzi ammazzati dai comunisti».
Ricomincia l’appello. Sono settantaquattro ragazzi dai diciassette anni e mezzo di Raffaele ai ventisei. Il più anziano nella vita civile faceva il contadino. Un bravo ragazzo: non tornerà dal Vietnam.
Alle 2.00 li fanno rientrare nella baracca. La sveglia è per le 5.30.
«Aaaaprire il letto.» Le lenzuola vengono sollevate tutte nello stesso istante.
«Tiiiirare su le coperte. Dormire.» Una lampadina sulla porta d’ingresso illumina fievolmente la stanza.
Alle 5.30 in punto la camerata è invasa da un terribile frastuono. Il sergente scaraventa a terra le reclute con gli occhi impastati dal sonno. Soprattutto quelle che dormono sui piani alti dei letti a castello. Urla e strepiti. In un attimo sono in piedi. Fuori è buio e fa freddo. È maggio ma in questa primavera del 1967 il tepore stenta ad arrivare.
Neanche un istante per realizzare dove si trovano. Vestiti, in fila indiana. Il rito della sveglia si ripeterà identico ogni mattina per i due mesi dell’addestramento base, che di norma si svolge in tre mesi. Ma non c’è tempo da perdere, serve carne fresca per il Vietnam.
Malauguratamente c’è sempre qualcuno che si attarda. Allora, dietro-front, di nuovo tutti nelle baracche. Secondo gli umori del sergente di turno, la giornata comincia con flessioni punitive o altri esercizi.
Dopo la sveglia, asciugamano, dentifricio, sapone vengono infilati nel secchio. Di corsa nella baracca dei servizi igienici per la pulizia personale. Si entra dieci alla volta. Pochi minuti, poi fuori, di nuovo in fila, ad aspettare gli altri.
È inevitabile che qualcosa disturbi il sergente. Flessioni per tutti. Per irritare il superiore basta una rasatura imperfetta o un piccolo taglio con la lametta: «Appartenete al governo degli Stati Uniti d’America per i prossimi quattro anni, ed è un reato danneggiarne la proprietà».
Quattro anni? E chi ci arriva al quarto. È chiaro che il sergente cerca ogni pretesto per punire e mettere gli uni contro gli altri. Per uno che sbaglia, tutti alla gogna. I ragazzi devono diventare macchine da guerra, disciplinate, determinate, spietate: dei demoni, secondo l’ammonizione del generale nordista William T. Sherman, il distruttore di Atlanta nella guerra di Secessione.
Dopo aver riportato i secchi nelle baracche, marciando per quattro si dirigono alla mensa, di fronte alla quale si dispongono su un’unica fila, sull’attenti.
Mentre aspettano di entrare per il turno della colazione, vengono impartite le lezioni basilari. Il sergente urla da farsi esplodere le arterie: «Chi è il presidente degli Stati Uniti d’America?».
«Sir, il presidente degli Stati Uniti d’America è Lyndon B. Johnson.»
«Chi è il comandante di questo campo?»
«Sir, il comandante di questo campo è il maggiore generale L.E. English.»
«Chi è il comandante del 3° battaglione, plotone 372?»
«Sir, il comandante del 3° battaglione, plotone 372 è il tenente colonnello J.M. Terry.»
Si deve gridare la risposta stando sull’attenti.
Finalmente si entra nella mensa. All’ingresso, a caratteri cubitali, campeggia il motto: Take all you want, but eat all you take (Prendi tutto quello che vuoi, ma mangia tutto quello che prendi).
Si mangia tre volte al giorno. La prima colazione è a base di uova, pancetta, frittelle con miele, frutta. Con i pasti, fiumi di latte, sia bianco sia al cioccolato, acqua, tè, caffè. A pranzo e cena, riso, spaghetti con carne macinata, bistecche, montagne di patate, verdure miste e dolci, soprattutto torte di mele.
Sempre marciando, si prende il vassoio metallico. Va portato al petto. Quindi ci si sposta a lato, davanti al banco dei pasti. Vietato proferire parola. Per chiedere agli inservienti una quantità maggiore di pietanze si deve rimanere con il vassoio proteso, se lo ritiri non ne puoi più avere.
Il sergente ordina di dirigersi verso le lunghe tavolate e, sull’attenti, si aspetta che arrivino gli altri mentre il cibo nel vassoio si fredda.
Solo allora il sergente intima: «Seduti».
Tutti nel medesimo istante, altrimenti si ricomincia: «In piedi».
«Seduti… In piedi. Seduti…», finché non si raggiunge una sincronia perfetta.
«Fermi maiali, aspettate…» Una preghiera, poi si mangia nel più assoluto silenzio e ingollando tutto in pochi istanti. Non una parola, né fra reclute, né con i superiori. Silenzio e ubbidienza assoluta.
A volte non si mangia. Il sergente, con un pretesto qualsiasi, al primo boccone ordina: «Tutti in piedi. Sull’attenti. Gettate il cibo nei bidoni». Nessuno fiata, ma vorrebbero fare a pezzi il sergente. E divorarselo.
Se il sergente non ha in programma questo scherzetto si mangia in abbondanza. Consumato il pasto, si riforma la fila per uscire. I rifiuti in un bidone, le posate in un altro, i vassoi sporchi in un altro ancora.
Adesso in fila per quattro, marciando verso le baracche e urlando a squarciagola cantilene come: «Ci sono tanti come lui, ma questo è il mio. Il mio fucile è il mio migliore amico. È la mia vita. Devo dominarlo come padroneggio la mia vita. Il mio fucile senza di me è inutile. Senza il mio fucile io sono inutile». Ma c’è sempre qualcosa che non va. Si ripete. Si ripete ancora. Punizioni, flessioni.
Ora in fila per i controlli medici e le vaccinazioni «sparate» sulle spalle con pistole ad aria compressa. E «da questo momento potete riprendere i contatti con la famiglia. Qui non vige la censura, ma vi consiglio di scrivere a casa che state meglio che alle Bahamas. Se scopro che raccontate balle me ne occupo io di persona».
Iniziano le prime lezioni. Le aule sono simili a quelle scolastiche. Un po’ di geografia, storia, teoria delle armi. Tenere gli occhi aperti in aula è uno sforzo sovrumano, con quell’arretrato di sonno. Per il resto, marce e flessioni, flessioni e marce, con il sole, con la luna, nel tempo libero. Marciano nella sabbia, marciano sull’asfalto. Centinaia di chilometri senza uscire dalla base. Guai a farsi venire calli o vesciche, tanto bisogna marciare lo stesso. Marciano con e senza equipaggiamento. Con il fucile M-14 calibro 7,62 Nato.
L’addestramento vero e proprio – finora dovrebbe essere stata una passeggiata – comincia dopo due settimane. Prima lezione: come pulire il fucile alla perfezione. Le parti metalliche vanno deterse con solventi e oli speciali, con uno spazzolino da denti e una stecca per la canna. Poi lucidate con pezze di cotone. Si versa l’olio in una mano e si strofina energicamente il calcio; quando è ben riscaldato dalla frizione, si passano gli straccetti in dotazione. Gli istruttori controllano in controluce la brillantezza delle armi, poi ordinano di marciare fino agli spiazzi coperti di sabbia destinati alle esercitazioni.
A destinazione, ordinano di sotterrare i fucili. «Disseppelliteli. Ora li vogliamo vedere davvero brillanti.» Tornano indietro e ricominciano daccapo.
Stesso giochetto con le scarpe: dopo averle lucidate con sputi, pasta nera e straccio per un’ora, li immergono nel fango, per poi ripetere la stessa operazione. Senza tregua. Vediamo a chi saltano i nervi.
Mentre strisciano come serpenti nella sabbia con i fucili finti da cinque chili, il sergente – che non smette di urlare – ringhia al ragazzo a fianco di Raffaele. Questi ha un’impercettibile reazione di disappunto. Il sergente gli balza sulla schiena come una tigre inferocita, lo gira e comincia a pestargli il viso con una ferocia tale da far temere il peggio. Nessuno si muove. Il ragazzo è a terra stordito e sanguinante. «Capito? Pezzi di merda.»
Li addestrano a soccorrere i feriti, a sopravvivere nella giungla. Questo frutto si può mangiare, quell’animale si può uccidere per nutrirsi. Fra una lezione e l’altra, il tormento delle punizioni, sempre più sofisticate: «Tuffati nella sabbia e nuota».
Durante...