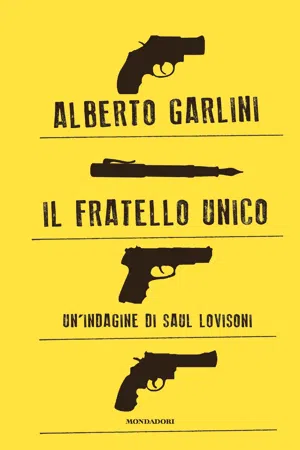Mi chiamo Margherita Pratts, ho ventisei anni e non ho combinato molto nella vita, almeno fino a oggi.
Vi chiederete perché scrivo queste pagine. Rispondo subito: per raccontare le indagini di un detective straordinario.
Si dice che quando ci si trova di fronte a un prodigio non ci siano parole per descriverlo. Questo libro nasce proprio per trovarle, le parole.
La prima volta che incontrai Saul Lovisoni fu nell’ottobre del 2014. Avevo un appuntamento e guidavo la mia Twingo vintage nella Bassa Parmigiana in mezzo al fango odoroso dei campi. I lampi rigavano le muraglie brune delle nuvole. La pianura, piatta come un tavolo da biliardo, costringeva però a curve tortuose che seguivano gli argini del Po. Umide balle di fieno sperdute nella campagna. I pioppi piegati dal vento.
“Ma dove caspita abita quell’uomo?”
Non era un gran periodo della mia vita e il clima padano contribuiva a tenere l’umore sintonizzato con la tristezza. La pioggia era un brusio sordo, il tergicristallo cigolava ritmicamente.
Alla radio davano la notizia della morte di un bambino di nove anni. Il piccolo Fabio. Lo aveva investito un pirata della strada, quella mattina stessa, su quelle stesse mulattiere piovose che stavo percorrendo. La spina dorsale si era spezzata in tre punti, così diceva il giornalista. Fingeva di essere affranto, o forse lo era davvero. Il bambino aveva una madre e un fratello, che lo piangevano disperati. Il pirata, che guidava un grosso Suv, era riuscito a scappare favorito dalla scarsa visibilità. Allegria.
La notizia mi fece ricordare altri bambini che avevo conosciuto in Africa, dove seguivo un progetto per favorire l’istruzione primaria.
Tre mesi a Luanda, in Angola, mi avevano convinto che quella era la vita giusta per me. Invece, la ONG per cui lavoravo scomparve nel nulla, la solita truffa di fondi internazionali, e dall’oggi al domani fui costretta a fare le valigie. Ero tornata in Italia a malincuore, col desiderio struggente di rivedere quei mezzogiorni di caldo che franavano in un azzurro intenso, i bambini che schiamazzavano nell’aula, i denti splendenti come una finestra aperta in un mattino d’estate.
Il rientro non era stato facile. Mi ero accorta che la relazione con Leonardo si reggeva proprio sulla distanza. Aveva amato altre ragazze nel frattempo. Non lo allettava l’idea di rinunciarvi per il mio improvvido ritorno. Suonava in un gruppo Klezmer, e non era neppure ebreo.
Dopo due settimane eravamo ai ferri corti. Le mie spese per i prodotti biologici lo disturbavano. Minavano il bilancio famigliare, così diceva. A me disturbavano le sue spese per la marijuana.
Cominciai a dormire in salotto. Spinta dalla rabbia, non avevo considerato le conseguenze del trasloco. Leonardo aveva il vantaggio della serratura. Portava a casa le amiche e si chiudeva a chiave nell’unica camera da letto. Dovevo andarmene.
Così mi misi a cercare un lavoro.
Saul Lovisoni era famoso a Parma. Mi stupii di trovare un suo annuncio tra le pagine della “Gazzetta”. Di famiglia ricchissima, una laurea a Harvard in Diritto internazionale, contro ogni previsione aveva deciso di dedicare la vita a dar la caccia ai cattivi nella polizia della sua città. Dopo aver risolto alcuni casi mirabolanti, aveva scritto un romanzo giallo da un milione di copie. E poi? Poi niente. Si era chiuso in un silenzio che durava da cinque anni. Si diceva che fosse strambo... “Fuori come un balcone”, questa la formula esatta che si usava a Parma... Be’, anche l’annuncio era strambo, così mi rivolsi a proposte lavorative più “normali”.
Per due settimane feci la banconiera in una birreria. L’umanità ai minimi termini. Quando il proprietario decise che era arrivato il momento di palparmi, decisi che era arrivato il momento di andarmene. Tra l’altro, scalava dalla paga le birre bevute durante il servizio. A fine giornata non mi restava quasi nulla.
Nella stanza di fianco, Leonardo continuava ad accordare le sue amiche da vero musicista. Una delle ragazze, Donatella, suonava che era una meraviglia. Gli urletti salivano e scendevano come scale armoniche. Che fosse vero amore?
Tornai a spulciare tra le pagine della “Gazzetta”.
C’era ancora l’annuncio di Saul.
“CERCO UNA SEGRETARIA CHE SAPPIA LEGGERE. LAVORO DI INVESTIGAZIONE E DI ARCHIVIO.”
“Che sappia leggere”? Cosa significava? Decisi di andare a scoprirlo.
Così chiamai. Saul rispose sbrigativamente dandomi un’ora, un giorno e un indirizzo. Attaccò senza salutare. Se quello era lo stile, il colloquio sarebbe durato una manciata di secondi.
La Twingo ogni tanto scendeva di giri. Vagai a vuoto per mezz’ora. Trovai il casolare quando non ci speravo più. Rintanato nella campagna, si ergeva in mezzo a fulmini, nere nubi e improvvise schiarite. Da vicino perdeva la sua maestosa grandezza: porte di legno mezzo ammuffito, vecchi infissi in alluminio, erbacce che crescevano qua e là. Nonostante la decadenza, l’aspetto era confortevole. Come può essere confortevole la tana di un animale.
Mi coprii con il bavero del cappotto.
Suonai. Nessuno rispose. La porta era aperta.
Chi abitava in quella casa non amava la luce e non amava nemmeno la modernità. Nel buio, ardeva qualche candela da chiesa. Abat-jour scoloriti. Divani di pelle scrostata.
La pendola in avorio mi mise in allarme.
Più andavo avanti e più incontravo oggetti bizzarri. Teschi di animali preistorici, stampe erotiche settecentesche.
«E allora, cosa aspetta?»
Mi guardai intorno, ma non vidi altro che un salotto pieno di bambole di ceramica. La statua di un cane addormentato.
Poi la voce prese forma.
Proveniva da un uomo sotterrato in uno studio che odorava di sigari, polvere e fiori appassiti.
«Vuole sedersi? O rimarrà lì immobile per sempre?»
Lo osservai meglio. Aveva tratti marcati ma eleganti. Sembrava fatto di nulla, anche se i muscoli urgevano contro il tessuto della camicia. Meno di quarant’anni, forse trentasette o trentotto. Capelli scuri. Labbra carnose. Un pallore malinconico, come di certe montagne che spuntano dalla nebbia, solitarie.
Era chino su un taccuino di pelle nera. Parlava senza alzare gli occhi.
Dietro di lui, una libreria di quercia, scura e pesante, dove erano disposti dei taccuini identici a quello sui cui scriveva. Niente li distingueva uno dall’altro, né un numero né una lettera.
Saul alzò per un attimo gli occhi neri e intelligenti. Poi disse, come per giustificarsi: «Sono i miei romanzi...».
Non ebbi il tempo di articolare una reazione.
«Come ti chiami?»
«Margherita...» risposi. Mi parve poco, così aggiunsi: «Meggy per gli amici».
Saul storse la bocca come se lo avessero ferito.
«Meggy? È orribile. Se proprio dovessi darti un soprannome potrei arrivare fino a Marghe. Ma penso che mi fermerò prima.»
«Preferirei che non mi chiamasse Marghe.»
«Anch’io ho una specie di soprannome. Mi chiamano “Sòl”, all’inglese, come la nota musicale.»
«Ok, allora vada per Sòl...»
Tornò a concentrarsi sul taccuino, come se non ci fossi.
«Quindi scrive ancora?» chiesi incuriosita. «Perché dicono...»
«Scrivo tutti i giorni. Non pubblico. Scrivere non significa necessariamente pubblicare.»
«Siamo uguali, perché anch’io scrivo senza che... Ma non importa... In ogni caso il suo romanzo mi era piaciuto» azzardai.
«Prima del caos? Un titolo profetico.»
Una risata amara. Un’occhiata tristemente ironica.
«Cosa sai fare?»
Quando mi chiedono delle mie numerose abilità, tendo a divagare.
«Leggo parecchio, so bene l’inglese. Sono stata in Africa con una ONG. E sono imbattibile dietro il bancone di una birreria.»
«La ONG è fallita, vero?»
«Sono scappati coi soldi.»
«Immaginavo. Hai altri piercing oltre quello al naso? Tatuaggi?»
«Un piercing...» risposi imbarazzata.
«Capito. Il tatuaggio si può vedere?»
Non gli avevo parlato del tatuaggio ma, in effetti, avevo una tartaruga hawaiana sulla spalla sinistra. Mi voltai, abbassai la spallina dell’abito e gliela mostrai.
Il cucù prese a rintoccare.
Rintoccò per un tempo che mi parve eterno.
«Per essere una persona riflessiva, prendi le decisioni in fretta» concluse Saul. Parlavamo da due minuti e aveva già capito alcuni tratti della mia personalità.
«Dicono che sia isterica, che mi piaccia troppo il vino brusco.»
«Hai mai svolto un lavoro di segreteria?»
«Mai. Però un’estate ho fatto la stagione dei pomodori.»
Se mi sento in imbarazzo dico stupidaggini. Saul non se la prese. Rise, ed era una risata vera. Afferrò uno dei tan...