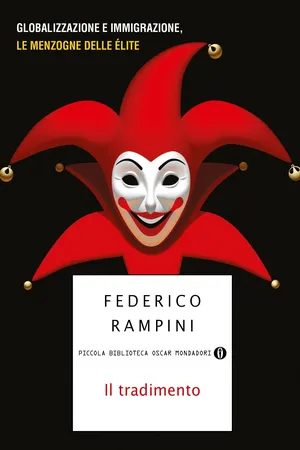«La missione a cui dedico la mia vita? Salvare gli elefanti. Non perdetevi le attività che sto organizzando per la giornata mondiale dell’elefante.» Chi parla è una splendida signora quarantenne, un metro e ottanta su tacchi a spillo, bionda dagli occhi verdi, un fisico da «Baywatch» di cui l’abito da sera valorizza le curve e nasconde poco. Stiamo chiacchierando su un prato all’inglese, all’ora dell’aperitivo, in mezzo a un andirivieni di camerieri in livrea che servono caviale e champagne. Un centinaio di persone attorno a noi, in un parco meraviglioso, con vegetazione lussureggiante e curatissima, più spiaggia privata su una laguna di Southampton.
Insieme al destino degli elefanti in via di estinzione, la signora persegue un’altra missione: trovare marito. «Mi ero trasferita apposta per un anno a Los Angeles, mi sono immersa nel mondo dello spettacolo, ho fatto surf e beachvolley a Santa Monica, ma non ho trovato l’anima gemella.» La signora mette l’asticella in alto, in termini patrimoniali. Questa sera è nel posto giusto: i padroni di casa sono miliardari. Tra gli invitati c’è un pezzetto di Wall Street, più qualche grande editore o pubblicitario. Abbondano le «trophy wives», mogli-trofeo, ex top model alla Melania Trump. C’è anche qualche «trophy husband», giovanotto affascinante con vent’anni meno della moglie.
Gli Hamptons al plurale sono ex villaggi di pescatori situati sulla punta nord di Long Island, da oltre mezzo secolo sono (non per la bellezza ma per il denaro ostentato) come la Costa Smeralda o la Capalbio o la Capri dei ricchi newyorchesi. Siamo a 130 chilometri di distanza da Manhattan, circondati da grandi spiagge di dune sull’Atlantico, una natura selvaggia a perdita d’occhio. Per i comuni mortali che arrivano in macchina, il traffico della metropoli impone quasi tre ore di viaggio. I veri abitanti degli Hamptons usano perlopiù l’elicottero. Nel cuore di Southampton li incontri al bar pasticceria Sant Ambroeus, dove un caffè costa 5 dollari e le auto parcheggiate più comuni sono Ferrari e Bentley.
Insieme all’ex direttore dell’«Economist» sono ospite per il weekend da un amico che ha una proprietà quasi modesta per gli standard degli Hamptons: comunque ha un giardino privato, camere degli ospiti, una piscina, una governante. Ma di fianco alla sua ci sono ville che vogliono rivaleggiare con il castello di Versailles. Ogni tanto, agli Hamptons si affacciano i coniugi Clinton, che trovano un pubblico amico e organizzano cene per la raccolta di fondi. La maggior parte sono progressisti di quella categoria particolare alla quale appartengono Bill Gates o George Soros. Finanziano cause nobili: dalla lotta al cambiamento climatico ai diritti dei gay, dallo sradicamento della malaria nei paesi poveri all’alfabetizzazione digitale nei villaggi africani. Senza dimenticare gli elefanti.
Hanno però le idee chiare sul diritto di proprietà. L’amico che mi ospita mi accompagna in una lunga passeggiata sulla spiaggia dove il paesaggio naturale è stato preservato bene, a parte qualche eccezione. Mi indica un complesso di costruzioni modernissime, eleganti ma in stridente contrasto con le dune. Un pugno nell’occhio, un mostro dal punto di vista paesaggistico. Mi fa il nome del miliardario che l’ha edificato di recente. Piscine multiple, case degli ospiti separate da quella padronale. Un design da vascello spaziale, ancorché attenuato dall’uso di materiali edili molto naturali, «sostenibili». «Abbiamo provato a opporci,» mi spiega «si era formato un comitato locale per la tutela del paesaggio. Ma lui ha opposto questo argomento: ho comprato il terreno e quindi decido io cosa farci.»
Il microcosmo degli Hamptons è quasi una caricatura, la rappresentazione estrema di un certo establishment liberal, élite progressista saldamente installata in cima alla piramide sociale. Neppure l’1 per cento, ma lo 0,01. Le élite colpevoli di tradimento, però, non sono soltanto loro. Che Bill Gates e George Soros siano globalisti a oltranza, non stupisce. Ma attorno a loro è cresciuto un apparato di persuasori occulti, persone molto meno ricche e tuttavia influenti, che per decenni hanno fatto da cinghia di trasmissione, diffondendo acriticamente una visione del mondo fatta su misura per consentire il trionfo del modello-Hamptons. Mentre osservo questo microcosmo che si è conquistato privilegi feudali, ho la sensazione che salvare la democrazia sia importante quanto salvare gli elefanti. Anche lei è minacciata di estinzione.
La fabbrica delle salsicce è meglio non visitarla mai, se non vuoi diventare vegetariano per sempre.
È una vecchia battuta di cui molti si sono attribuiti la paternità. Risale alla fine dell’Ottocento. La fabbrica delle salsicce è la democrazia. È la politica vista da vicino. Brutta, sporca e cattiva. Nauseabonda. Disgustosa. Poi, alla fine, guardando ai risultati, è meno peggio di ogni altro regime al mondo. Non scambieremmo mai le nostre scassate e deludenti democrazie occidentali con una teocrazia degli ayatollah, o con una dittatura fascista o comunista che decida quali libri o siti Internet possiamo leggere o visitare, o se abbiamo il diritto di viaggiare all’estero.
Ogni quattro anni, fa parte del mio mestiere visitare la fabbrica delle salsicce americana. Una visita molto ravvicinata. Diversa da quello studio permanente che ne faccio come corrispondente. Nella vita normale di un corrispondente la maggior parte del tempo va trascorso a New York e a Washington, i centri del potere, là dove si prendono decisioni di portata mondiale. Con l’aggiunta di San Francisco, per via della Silicon Valley: anche quello è, a modo suo, un centro del mondo, dove regnano i Padroni della Rete. Occasionalmente ci scappano le visite a Boston (grande centro universitario), a Los Angeles (cinema e dintorni), a Seattle (Microsoft, Amazon). Qualche inchiesta può esigere un sopralluogo al confine con il Messico, o in località improvvisamente divenute «calde» per le tensioni tra la polizia e la comunità afroamericana (Ferguson, Baltimora, Charleston). Ma sono delle puntate una tantum, in genere.
Ogni quattro anni, però, diventa obbligatorio seguire un itinerario molto più variegato, complicato, e istruttivo. Si comincia da Des Moines, in mezzo ai campi di granturco dell’Iowa, Stato agricolo del Midwest. Poi c’è Manchester, nel New Hampshire, tra i primi insediamenti dei coloni venuti dall’Inghilterra. A seguire c’è il Nevada, sempre più ispanico; il profondo Texas, dove comanda il trio Bibbia-petrolio-armi; poi la Florida. Con puntate possibilmente anche in Ohio e in Pennsylvania. È il percorso a ostacoli delle primarie; cui segue l’itinerario molto simile dei grandi comizi per i candidati prescelti dai partiti. Applica un calendario casuale, stabilito tanti anni fa (1972), quando vennero adottate le attuali regole del gioco per le elezioni presidenziali.
Questo tortuoso gioco dell’oca costringe almeno noi giornalisti a entrare nell’America poco conosciuta e meno raccontata. «Finalmente vi accorgete che esistiamo» sembrano ghignare gli elettori di quei posti sperduti, improvvisamente invasi dai network televisivi americani, che paiono colonne blindate di invasori inviati da una potenza aliena (il più banale dei collegamenti con un seggio elettorale coinvolge Tir spaziali targati Fox, Cnn, Msnbc, con padelloni satellitari che potrebbero comunicare oltre la Via Lattea). Più una miriade di cronisti stranieri come me: mai visti così tanti giornalisti messicani o tedeschi, giapponesi o russi; in quei luoghi remoti appaiono d’incanto soltanto una volta, ogni quattro anni. Così gli habitué di Washington e di New York sono obbligati a soggiornare per lunghi periodi nella «fly-over country», quella nazione che di solito sorvoliamo per passare da una costa all’altra. (E sono sei ore di sorvolo: ce n’è di roba là sotto.)
Nel corso del 2016 ho avuto più volte una sensazione di «déjà vu». L’Italia mi è apparsa come un laboratorio politico, un concetto rovesciato: di solito pensiamo che le novità debbano nascere al centro dell’impero, non alla periferia, e quindi consideriamo l’America come la fabbrica di tutti i trend. Ma mettendo insieme le date di apparizione di fenomeni come il berlusconismo, il leghismo, e il Movimento 5 Stelle, abbiamo avuto un ruolo da precursori.
Vivevo a Milano quando, due anni dopo Tangentopoli, Silvio Berlusconi si lanciò in politica. Seguii la sua prima campagna elettorale (1994) mentre ero vicedirettore del «Sole 24-Ore». Per le legislative del 1996 ero diventato il capo della redazione milanese della «Repubblica». Le successive campagne elettorali le seguii dall’estero. Ricordo la fatica che facevo a spiegare il fenomeno Berlusconi agli stranieri. Oggi no, non farei nessuna fatica, anzi sono gli americani a tracciare analogie fin troppo facili tra Berlusconi e Trump. Inoltre, ricordo i momenti iniziali in cui era difficile «conoscere un berlusconiano»: nella cerchia dei propri amici e conoscenti, se qualcuno lo votava non te lo diceva. Poi, alle urne, scoprivi che erano tanti. Idem per quanto riguarda la stampa, gli intellettuali, le élite, ivi compresi i grandi imprenditori (Gianni Agnelli inizialmente lo snobbava): se toglievi quelli legati direttamente a Fininvest, sembrava che l’Italia colta, influente, autorevole, fosse compatta nel bocciare Berlusconi. Eppure, tre volte ha vinto e tre governi ha guidato.
E allora un problema riguarda quel «noi», pronome plurale che sto usando spesso. Noi giornalisti. Noi opinionisti. Noi intellettuali. Noi liberal delle due coste, abitanti di New York Boston Washington San Francisco Los Angeles. Noi che ci frequentiamo tra simili, e tra le nostre conoscenze facciamo fatica a trovare un rappresentante di quell’altra America. E li abbiamo anche visti, per carità, e raccontati ai lettori. Non c’è reporter che non si sia fatto i suoi bei comizi con Trump, le immersioni nella folla che lo adora. Ma poi, una volta tornati in redazione, al momento di scrivere, ci siamo immersi in un mondo dove «quelli là» sono ovviamente trogloditi, esseri rozzi, dominati da istinti deteriori. Dalla parte sbagliata della Storia.
Fra le tante sorprese del 2016 c’è quella di Trump che sdogana l’elusione fiscale. Credevamo fosse un vizio italico sottrarsi ai doveri del contribuente e vantarsi di essere «furbi». Che colpo per il nostro mito americano.
Vale la pena ricordare uno scambio di battute fra Hillary e Donald nel corso di un duello televisivo. Lei: «Perché Trump si ostina a non mostrarvi le sue dichiarazioni dei redditi, primo candidato in quarant’anni che nega questa trasparenza fiscale? Forse non vuole far sapere agli elettori che non paga tasse federali?». Lui: «Be’, vuol dire che sono smart». «Smart», come furbo, brillante, geniale.
Questo mi riguarda. È un duro colpo a una certa immagine dell’America alla quale ho creduto sinceramente, e che a suo tempo usai anche per denunciare le anomalie italiane: Berlusconi, e non solo. Tante volte ho raccontato ai lettori italiani la storia – vera – del boss Al Capone incastrato inizialmente non per mafia, ma per evasione. Era il simbolo di un modello sociale virtuoso: l’America non perdona chi viene meno ai propri doveri fiscali.
Purtroppo non è così. O, almeno, non sempre. Dipende. La vicenda Trump costringe a fare i conti con due verità scomode. Primo, c’è un capitalismo americano che pratica l’elusione fiscale sfruttando tutte le possibilità offerte da normative perverse, leggi ad hoc, conquistate con la pressione lobbistica. Certe forme di elusione avvengono in casa, senza bisogno di andare a Dublino, come fa Apple. Interi settori come quello immobiliare si sono costruiti dei «paradisi fiscali interni», ricattando le amministrazioni locali. Democratici inclusi: a New York, il governatore Andrew Cuomo e il sindaco Bill de Blasio. O mi cancelli le tasse oppure io costruisco altrove, e i posti di lavoro li creo nel collegio elettorale di un altro governatore, di un altro sindaco. Il risultato è una giungla immonda di esenzioni e sovvenzioni, tali che alla fine un miliardario paga meno di un impiegato. Alla fine il ricatto diventa una sorta di collusione.
Il mio sindaco di sinistra (radicale!) de Blasio non pone limiti alla speculazione edilizia a Manhattan e Brooklyn, purché gli affaristi immobiliari gli costruiscano anche un po’ di case popolari. Le due parti diventano complici, le regole vengono distorte a patto che, alla fine, ciascuno ne abbia un tornaconto. Ma in questo patto scellerato, a quelli delle case popolari vanno le briciole. Per questo New York è un cantiere perpetuo: le gru le paghiamo noi contribuenti normali, i profitti degli immobiliaristi non sarebbero così elevati se non fossero di fatto esentasse. Intanto i ceti popolari continuano a essere espulsi sempre più lontano, con la «gentrification».
Altra verità scomoda. Una parte della società americana si sente oppressa dal fisco, e riceve servizi pubblici così scadenti in cambio delle imposte da solidarizzare con il miliardario. L’affarista sussidiato dai favoritismi fiscali riscatta le sofferenze del contribuente medio, in un assurdo rovesciamento delle parti. Questo rivela un problema per i democratici, per i progressisti. Se la sinistra diventa il partito dell’Agenzia delle Entrate, una fascia di elettori la teme come la peste. Se il Partito democratico si presta alla caricatura – «per la sinistra ogni problema nazionale si risolve solo buttandogli addosso altro denaro pubblico» –, un pezzo di America starà sempre dalla parte opposta.
Quando Obama vinse – sia la prima sia la seconda volta, nel 2008 e nel 2012 –, «quelli là» tornarono a essere maggioranza in soli due anni, appena si spense l’eccitazione delle presidenziali e si votò per il Congresso. C’è qualcosa che non funziona nella democrazia, nel discorso pubblico, e nel nostro modo di raccontare le cose, se le due tribù continuano a convivere come separate in casa, nel più profondo disprezzo reciproco.
La salvezza verrà dai social media? C’è una visione anarco-libertaria che attribuisce alle tecnologie digitali una valenza politica, rivoluzionaria. I limiti della vecchia democrazia svaniscono d’incanto, da soli, via via che questa nuova tribù di nativi digitali prende il potere, e la sovranità popolare diventa il flusso continuo d’informazioni e decisioni via Facebook, Twitter e compagni. Si tende a dimenticare che i regimi autoritari abbracciano i social media, purché non siano americani. Noi tendiamo a considerare l’Occidente come l’ombelico del mondo, ma in termini di masse di utenti bisogna ormai fare i conti con i social media cinesi, per esempio l’onnipresente Weixin (in inglese WeChat), messaggeria istantanea per oltre mezzo miliardo di persone che vi custodiscono anche il loro album fotografico, una sorta di diario permanente a disposizione degli amici.
Il fondatore e chief executive di Facebook, Mark Zuckerberg, è stato uno dei primi a teorizzare che il business più attraente dei social media si sta spostando dalla comunicazione «scritta» (digitale, s’intende) alla comunicazione di contenuti video: più caldi, più intensi, più emotivi, più sintetici. Per Zuckerberg, l’intuizione è stata precoce. Nel 2012 comprò per 1 miliardo Instagram, che aveva 30 milioni di utenti: oggi ne ha più di 400 milioni. Poi, nel 2014, comprò per 19 miliardi WhatsApp, che aveva 450 milioni di utenti: oggi sono più che raddoppiati, superando la soglia del miliardo.
Nei social media le fonti di fatturato e di profitto continuano a essere sempre due: la vendita di informazioni su di noi (saccheggiando la nostra privacy) e le inserzioni pubblicitarie (distruggendo lentamente ogni settore che campava di pubblicità). Fermo restando che il futuro appartiene alla comunicazione di contenuti video «live», e quindi ai social più adeguati e flessibili per questo tipo di uso, ora bisogna prepararsi al prossimo balzo in avanti: l’uso sistematico della realtà virtuale. In altri termini, scordatevi l’idea che le notizie vi vengano trasmesse sullo schermo dello smartphone dal faccione di un reporter o di un «citizen-journalist» (testimone oculare). La realtà virtuale consentirà di trasformare le brutte facce in avatar degni di Pixar e Disney. Le notizie diventeranno più attraenti: effetti speciali, animazione, videogame. Buon divertimento.
In quanto a Zuckerberg, che possa essere il facilitatore di una nuova democrazia digitale è dubbio. Basta ricordare i suoi atti di servilismo verso il governo di Pechino, la superpotenza comunista che continua a opporgli barriere alte quanto la Grande Muraglia. Pur di accattivarsi Xi Jinping, Zuckerberg si è fatto fotografare mentre faceva running per le vie di Pechino, suscitando ilarità o irritazione fra chi in quella città ci vive e ne respira lo smog. La piaggeria non è bastata a far revocare il divieto di accesso a Facebook in Cina. Ma la dice lunga sul legame tra social media e salute della democrazia: inesistente.
Altro eroe dell’insurrezione digitale è Julian Assange, il capo di WikiLeaks. Da anni conduce una vita difficile, recluso nell’ambasciata ecuadoregna a Londra per sottrarsi a un mandato di estradizione in Svezia. Ma è un eroe della democrazia? Ripercorrendo la storia decennale di WikiLeaks, il tratto unificante è questo: gli attacchi sono abbastanza unilaterali, salvo rare eccezioni è l’America il bersaglio principale. La Russia appare sempre più spesso come la sua fonte, e lui non lo nega. È quando se la prende con gli Stati Uniti che WikiLeaks fa notizia e la sua fama s’ingigantisce.
L’elenco parte dal dicembre 2007, con la pubblicazione del manuale interno d’istruzioni ai militari di Guantánamo Bay, l’indegno supercarcere dove gli Usa, dalla guerra in Afghanistan in poi, detengono molti prigionieri accusati di essere «combattenti nemici». Poi arriva un regalo alla destra americana, la divulgazione nel novembre 2009 degli scambi di email tra autorevoli scienziati ambientalisti, da cui risulterebbe un complotto contro i rari studiosi che negano il cambiamento climatico. Il 25 luglio 2010 Assange rende di dominio pubblico 75.000 rapporti segreti dei militari Usa sulla guerra in Afghanistan. Il 22 ottobre dello stesso anno è la volta di 400.000 documenti riservati sulla guerra in Iraq dai quali trapela, fra l’altro, un bilancio di centomila vittime irachene di cui il 60 per cento sono civili.
Il grande botto arriva poco dopo, il 28 novembre 2010: è il cosiddetto «Cablegate», la rivelazione di 250.000 comunicazioni riservate tra il Dipartimento di Stato e le sue ambasciate nel mondo. I dialoghi interni alla diplomazia Usa diventano di dominio pubblico, creando tensioni con i governi (alleati o meno), talvolta scatenano crisi politiche all’interno di paesi stranieri destabilizzati dai giudizi confidenziali degli americani o dalle notizie che Washington e gli ambasciatori si scambiano sulla corruzione di questo o quel regime. Compreso il versante italiano, che coinvolge Berlusconi, Eni, Putin. In alcuni casi, come la Tunisia, è stato osservato che le «primavere arabe» hanno avuto una scintilla iniziale anche ...