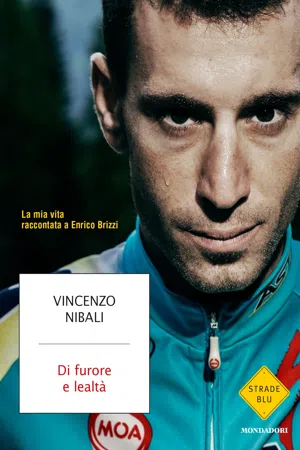“Che ci faccio io qui?” mi domandai dopo l’ennesimo brindisi. Cominciavo a sentirmi offuscato.
Eravamo in diciotto intorno alla tavola imbandita e, secondo l’usanza locale, ognuno doveva tenere un breve discorso, seguito da un nuovo giro di vodka.
Resistere svegli a un pranzo del genere era un’impresa, ma non ci si poteva sottrarre. Vinokurov mi aveva spiegato che i nostri commensali erano tutte persone importanti: ministri, sottosegretari e alti dirigenti delle compagnie di Stato che sponsorizzavano la squadra, la divisione ciclistica del Professional Presidential Sports Club Astana.
“Presidential” perché dipendeva direttamente dal leader del Paese, Nursultan Nazarbaev, già segretario del Partito comunista kazako all’epoca dell’Unione Sovietica e, dal 1990, capo dello Stato e comandante supremo delle Forze armate della repubblica indipendente del Kazakistan.
Il suo colossale ritratto regnava sulla tavolata, ed era già stato onorato da diverse levate di bicchierini colmi.
«Il signore che parla adesso è il team manager della squadra di hockey su ghiaccio Barys Astana» mi sussurrò all’orecchio l’interprete, l’unico che parlasse italiano oltre a Vinokurov. E a me, se ancora mi fosse riuscito di sillabare qualcosa senza imbrogliarmi, con la lingua gonfia che mi ritrovavo. «Barys significa “leopardo delle nevi”. È l’animale simbolo del Kazakistan.»
Annuii, tentando di sorridere.
Quella polisportiva di Stato era una struttura inimmaginabile per un occidentale: avevano già parlato il numero uno dell’Astana Football Club e quello dell’Astana pallacanestro, e più tardi sarebbe toccato al collega responsabile dell’Astana rally e a quello dell’Astana pallanuoto.
Le tre sillabe di quel nome venivano ripetute ogni poche parole: Astana era un brand, non solo la città da ottocentomila abitanti che si estendeva fuori dal finestrone panoramico.
La cupola dorata del palazzo presidenziale era l’unica costruzione dal sapore esotico, capace di ricordare che ci si trovava in un Paese un tempo abitato solo da nomadi islamici; per il resto, svettavano grattacieli in vetro e cemento e costruzioni faraoniche come la sede della KazMunay, la compagnia nazionale del gas, e l’imponente edificio dell’Università Euro-Asiatica.
Eppure mi avevano raccontato che, fino all’Ottocento, da queste parti c’erano solo steppa e neve. Era stato un distaccamento di cosacchi a fondare il primo insediamento, avamposto della Grande Madre Russia e della fede cristiano-ortodossa sulle rive del fiume Ishim.
Da allora la città aveva cambiato nome almeno tre volte e, all’epoca di Stalin, era circondata da gulag riservati alle mogli dei “traditori del popolo”. Più di recente, nel periodo in cui io frequentavo le elementari alla Cannizzaro, l’Unione Sovietica si era disintegrata e la Repubblica Socialista Sovietica del Kazakistan era diventata uno Stato indipendente, vasto quanto mezza Europa e deciso a sfruttare in proprio gli immensi giacimenti di gas naturale del sottosuolo. Senza, peraltro, che il molto onorevole Nazarbaev perdesse una briciola di potere, come testimoniava il suo ritratto incombente su di noi.
Parte dei miei commensali aveva lineamenti turcheschi simili ai suoi; parte, invece, era bianca e di sangue russo come Vinokurov, il primo sportivo che avesse portato al Kazakistan indipendente vittorie prestigiose, a riprova del fatto che gli eredi delle orde nomadi e quelli dei cosacchi potevano convivere senza fanatismi. C’erano risorse a sufficienza per tutti, nel Paese, e non serviva accapigliarsi: bastava onorare il presidente, rispettare le gerarchie e brindare al momento giusto.
Ma ecco che il team manager dei “Leopardi delle Nevi” aveva concluso il suo discorso: i bicchierini si levavano un’altra volta, in un’esplosione collettiva di voci.
«Salute» tradusse per me l’interprete, e anch’io buttai giù il mio sorso di vodka.
Avevo lo stomaco in fiamme, ma dovevo resistere. Avrebbero parlato ancora in cinque o sei, e poi sarei potuto andare a riposare.
Forse, nel giro di un’oretta, ce la saremmo cavata.
Anche quello, alla fine, era lavoro.
La dominazione dei cavalieri neri sul Tour de France sembrava non conoscere fine. Dopo la vittoria di sir Wiggins, l’edizione 2013 fu dominata dal suo stempiato ed esangue erede Chris Froome. Se a Wiggins andava riconosciuta una certa classe e un carattere al limite dell’eccentricità, il suo successore era invece il prototipo del ciclista-robot dallo sguardo opaco e incapace di mostrare passioni.
Froome era nato in Kenya e cresciuto a Johannesburg, così la sua carriera aveva preso il via nelle file della Barloworld, l’unico team di qualche peso attivo in Sudafrica, ma era davvero decollata solo quando l’emaciato giovanotto era stato arruolato nello squadrone britannico Sky.
Detrattori e invidiosi, convinti che le prestazioni di Froome fossero largamente costruite in laboratorio, lo chiamavano dietro le spalle “Biohazard”, né lui si sforzava di fare alcunché per risultare più umano: nelle interviste parlava solo di diete e allenamenti, e sembrava alieno alla gioia di vivere.
Persino sul podio del Tour, dal quale era riuscito a tenere fuori il Pistolero Contador, il robotico Chris aveva sorriso a fatica.
E dire che era salito sul gradino più alto. Era da lì che, la prossima volta, avrei dovuto provare a buttarlo giù.
Il ciclismo era uno sport che affondava le proprie radici in un’Italia rurale, praticato a costo di mille sacrifici da tanti ragazzi di umili origini. Erano pochi, nel gruppo, i figli di notai o di primari ospedalieri, forse perché serviva essere addestrati fin da piccoli a soffrire.
Così erano semplici anche i nostri sogni: un matrimonio sereno, una bella casa e una macchina potente, che certificasse il nostro successo e ci mettesse sullo stesso piano dei signori. D’altronde, a differenza di loro, non potevamo mai concederci una vacanza.
Anch’io, appassionato di meccanica sin da piccolo, avevo sempre immaginato che il passo successivo alla vittoria del Giro fosse comprarsi un bolide col cavallino rampante sul cofano. L’avevano fatto altri prima di me e ora, coi soldi del contratto kazako, avrei potuto farlo anch’io. Solo che mi sembrava un’ostentazione esagerata. Se non uno schiaffo alla miseria, perlomeno un indizio del fatto che mi ero insuperbito.
No, non avrei avuto il coraggio di presentarmi a Messina guidando una Ferrari. E neppure a Mastromarco. I Cannibali mi avrebbero domandato chi credevo di essere, e io mi sarei sepolto vivo dalla vergogna.
Però potevo sempre ripiegare su un altro dei miei sogni di bambino: una Porsche Carrera mi sembrò il giusto compromesso.
Quando entrai dal concessionario, fui preso per un perditempo e, per un bel pezzo, nessun venditore mi diede retta. Capirono che ero uno sportivo affermato solo quando ottenni udienza e dovetti mostrare i documenti; allora cominciarono le riverenze e le proposte di sconto sugli allestimenti speciali.
Mi faceva rabbia il fatto che proponessero un prezzo di favore a chi, in quel momento, avrebbe potuto pagare la cifra piena, mentre quando ero un ragazzo squattrinato non mi faceva lo sconto nessuno.
Non era così anche per le bici? Da piccolo, quando le sistemavo col Lupo, i negozianti non ci regalavano neppure la leva d’un freno o un copertoncino di riserva, mentre adesso la Specialized mi riforniva gratis di modelli top in fibra di carbonio, ruote spaziali e abbigliamento tecnico, perché potessi sfoggiare il loro marchio non solo in gara, ma anche quando mi allenavo da solo.
Il mondo era un posto balordo, ma ormai ero in ballo. Ordinai il mio Carrera bianco con capottina rossa e, nello spazio d’una settimana, potei inaugurarlo portando Rachele in gita lungo le più spettacolari strade panoramiche del Canton Ticino.
Non avevo mai posseduto in tutta la vita un giocattolo così bello e gratificante, ma subito mi prese un senso di colpa: avevo ritegno a confessare a papà e mamma quell’acquisto, così pregai la mia signora di mantenere il segreto.
«Voi grassi!» sbraitò Vinokurov di fronte alla squadra riunita al termine del Tour di Polonia. «Dove avere testa, voi?»
Valerio Agnoli, Vanotti e io ci guardammo di sottecchi: “grassi” era sicuramente un termine fuori luogo, ma bisognava ammettere che i nostri ventri non erano tirati come due mesi prima.
«Nessuno di Astana in top ten!» ci rinfacciò, mettendoci sotto il naso il foglio dell’ordine d’arrivo.
L’estone Kangert ascoltava a testa bassa. Djacenko, l’unico kazako della compagnia, sembrava sul punto di piangere. E anche Paolo Tiralongo, coi suoi lunghi anni di esperienza ad alto livello, pareva turbato.
«Voi corre male! Malissimo!» rincarò la dose Vino. «E avere faccia di fantasmi!»
Anche in questo caso, non aveva tutti i torti.
Il guaio era che i festeggiamenti per la vittoria del Giro si erano protratti per settimane, interrotti a malapena per il mio viaggio in Kazakistan, e ci eravamo preparati per la corsa polacca solo all’ultimo minuto. Così, quello che doveva essere il nostro grande ritorno dopo la Corsa rosa si era ridotto a una svogliata settimana di pedalate nel ventre del gruppo.
«Voi pensa essere campioni? Ascolta me! Se voi corre così in Spagna, è figura di merda!» concluse la sua sfuriata il team manager.
L’ipotesi di vincere nello stesso anno Giro e Vuelta era suggestiva.
Nessun ciclista nella storia aveva mai conquistato le tre grandi corse a tappe nello stesso anno, e anche la doppietta era riuscita a pochissimi: da quando ero al mondo io, solo a Roche e al grande Indurain, al Pirata nel ’98 e al Pistolero dieci anni più tardi.
Così, mentre chi non correva in bici si apprestava ad andare in ferie, mi misi d’impegno per recuperare la forma insieme ai compagni dell’Astana.
La prova generale in vista della corsa spagnola era il Giro di Burgos, cinque giornate di gara indicatissime per abituarci al sole abbacinante e alle temperature torride dell’estate iberica. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, avremmo dovuto trarne foschi presagi. Nel bel mezzo della seconda tappa, infatti, il treno dei compagni che si dannavano per tirarmi avanti esplose in un pandemonio di ruote all’aria, ginocchia sull’asfalto ed espressioni incredule. Feci appena in tempo a realizzare che stavo piombando loro addosso, ed ero già in volo anch’io. Non finii sulla strada, ma dritto sul mio buon amico Agnoli, e rabbrividii nel sentire il poveretto mandare un gemito straziante.
«Porca miseria, Squalo!» esclamò da sotto e, non appena mi risollevai, si portò le mani al costato con una smorfia di dolore. «Mi sono rotto!»
«Scusa, scusa, scusa» gemetti a mia volta, poi mi misi subito in piedi, a sbracciarmi per avvertire il personale sanitario.
Risultò che gli avevo incrinato due costole, compromettendo la sua partecipazione alla Vuelta. Se pure non era stata colpa mia, mi sentivo desolato: Valerio mi aveva presentato la donna della mia vita, e io lo ripagavo a quel modo? Non mi risollevarono l’umore né gli inviti di Martino ad accettare quella fatalità, né i complimenti che ottenni da Vinokurov per avere chiuso la Vuelta a Burgos al terzo posto.
Decisamente la campagna spagnola era partita col piede sbagliato.
La Vuelta di quell’anno, con undici tappe di montagna su ventuno, sembrava destinata a incoronare uno scalatore.
I più attesi, oltre a me, erano i due arcirivali di casa: il peso piuma Purito Rodríguez e l’antipatico lungagnone Valverde. Le loro squadre, Katusha e Movistar, erano pronte a darsi battaglia all’ultimo sangue, decise a sfruttare l’assenza dalla corsa del Pistolero Co...