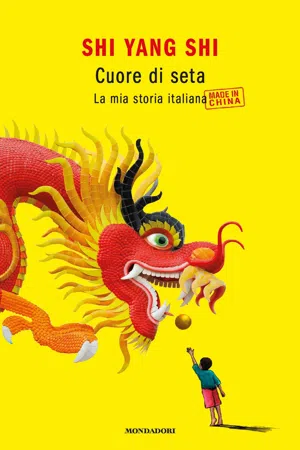![]()
![]()
Per tutto il viaggio me ne restai con la testa appoggiata al sedile, abbandonato in un sonno a prova di bomba.
Era la prima volta che volavo, mi facevano male le orecchie, avevo un po’ di nausea, e mi spaventavo ogni volta che l’aereo traballava. Col risultato che per tutto il viaggio non spiccicai parola né riuscii a mangiare nulla.
Nei pochi momenti in cui ero sveglio sbirciavo verso il finestrino alla mia sinistra: non è, però, che si vedesse poi tanto bene cosa stavamo sorvolando. Solo all’inizio, mentre il nostro aereo decollava dall’aeroporto di Pechino, ero riuscito a vedere le case farsi sempre più piccole, e le persone diventare dei puntini neri. Poi mi ero messo a inventare storie coi personaggi che le forme delle nuvole di volta in volta mi suggerivano. Erano nuvole di mían hūatáng, “cotone caramella”, lo zucchero filato che spiluccavo in Cina fra le bancarelle dei mercatini serali.
Era il marzo del 1990 e dalla capitale della Repubblica popolare cinese, dopo aver fatto scalo a Hong Kong, volavo verso Francoforte insieme a Māma, mia madre.
Sapevo che stavamo andando in Yìdàlì, l’Italia. Era quella la nostra destinazione finale.
Uscire dalla Cina, chūgú, era il sogno di tantissimi miei connazionali. Era quasi una corrente di pensiero, una moda.
Mentre gli italiani che agli inizi del Novecento emigravano in America lo facevano in gran parte per disperazione, noi cinesi adesso lo facevamo per lo più per migliorare la nostra condizione sociale. E così la mia famiglia, che era benestante: restando in Cina non avremmo certo sofferto la fame, anzi.
Ma questi sono pensieri che neppure mi sfioravano in quel momento, sull’aereo diretto a Francoforte. Pensavo soltanto che per me iniziava un bellissimo viaggio, e che alla fine sarei tornato a casa con qualcosa in più rispetto a tutti i miei coetanei.
Io sarei stato in Europa, Oūzhōu, loro no.
La notizia di quella partenza mi era stata data una mattina da mia madre. Era entrata nella mia camera e, vestendomi per la scuola, mi aveva detto con un tono scherzoso: «Yì laí shēn shǒu, fàn laí zhāng kǒu», “è finito il tempo in cui ti arriva il vestito e tu tendi la mano, ti arriva il cibo e tu apri la bocca”.
Mezzo addormentato, con gli occhi ancora socchiusi, il mio unico pensiero era il brodo di riso che avrei trovato sul tavolo insieme a due uova fritte e alle verdurine in salamoia – il tutto preparatomi amorevolmente da Bàba, mio padre.
Non capivo cosa volesse dirmi con quella frase venuta fuori dal nulla, e neppure mi interessava.
«Su, vai» mi disse lei col solito tono dolce, e la conversazione finì lì.
Una volta uscito, come al solito avevo inforcato la bicicletta e mi ero immerso nella marea di ruote e persone che affollavano le strade della città, diretto a scuola.
Era normale per noi bambini viaggiare da soli in bicicletta. Era la cosa che più mi faceva sentire leggero. Libero. All’epoca in cui ero ragazzino io – la fine degli anni Ottanta – non c’erano così tante automobili in Cina... e se anche cadevi, nessun problema, ti rialzavi, mentre la folla di ciclisti ti scansava con la massima tranquillità. Magari avevi un ginocchio sbucciato, ma poi passava pure quello.
Sentivo però che c’era qualcosa di strano nella nostra partenza.
Lo avevo capito quando mia madre mi aveva detto che quel viaggio doveva restare un segreto: «Non farne parola coi tuoi compagni di classe, per nessuna ragione al mondo» mi disse con una luce gelida negli occhi.
Così io, che morivo dalla voglia di raccontare tutto ai miei amici, tenni la bocca chiusa.
E c’era di più: Baba non sarebbe venuto con noi.
«Perché dobbiamo partire da soli?» gli chiesi quando lo venni a sapere.
Era complicato. C’entrava il lavoro. E poi avrebbe dovuto lasciare da sola la nonna...
«Comunque» mi aveva promesso lui «vi raggiungerò prestissimo.»
Quella era una promessa che non avrebbe mantenuto, però.
Ci sarebbero voluti quattro anni prima che lui potesse stabilirsi definitivamente in Italia con noi.
![]()
Ero nato e cresciuto a Jǐnán, città capoluogo della provincia dello Shandong – nome che significa “a oriente del monte” –, quella penisola, grande due terzi dell’Italia, che sul mappamondo si allunga nel Mar Giallo verso la Corea del Sud.
Il monte in questione è il Taishan, la più importante delle cinque montagne sacre del taoismo. Per arrivare in cima ci vogliono anche otto ore di salita. Lungo il tragitto, vedi numerose pagode, ma anche edifici fastosi come il tempio della Roccia Divina, e muri con su epigrafi lasciate da grandi poeti e imperatori. Da lassù, dopo una camminata notturna, si può ammirare il sole nascere su tutta la vallata.
Una volta Baba mi ci aveva portato. Camminammo per tutta la notte su sentieri fatti di migliaia di gradini, e alla fine anche noi facemmo la foto con alle spalle il sole che sorgeva dalle nostre mani.
Situata a quattrocento chilometri a sud di Pechino, Jǐnán era una città piuttosto grande, con cinque milioni di abitanti già nel 1990. A sud si sviluppava verso le colline che preannunciavano il Taishan, mentre a nord verso il Húanghé, il Fiume Giallo. Insomma, bisognava avere le gambe ben allenate se si volevano percorrere, in bicicletta, o anche solo a piedi, le sue strade che andavano sempre su e giù.
D’estate faceva molto caldo, così tanto che si sudava anche a star fermi accanto al ventilatore, e d’inverno molto freddo, al punto che bisognava mettere la calzamaglia di lana sotto i pantaloni. Ma io amavo Jǐnán soprattutto in questa stagione, perché quando la città diventava bianca per settimane intere, capitava che i miei genitori mi portassero a giocare a palle di neve sulle colline piene di pini. D’inverno, poi, la città era in festa per il Capodanno cinese, e ti perdevi fra tavole imbandite, vestiti rossi, stordito dai petardi e da lanterne di ogni forma e colore.
Le fabbriche brulicavano ovunque, in città, e anche mio padre aveva lavorato per un periodo come ingegnere in una di queste, per poi diventare manager in un’azienda statale di importazione di macchinari dall’estero.
Ecco, non pensavo di starmi lasciando tutto questo alle spalle la notte della partenza, una fredda notte di marzo che apparteneva più all’inverno che alla primavera.
Indossavo una bellissima giacca di pelle grigio-azzurro che mi arrivava alle ginocchia. Mia madre me l’aveva comprata a Pechino appositamente di un po’ di taglie più grande, in modo che mi stesse ancora bene per qualche anno.
Da Jǐnán avremmo viaggiato in treno tutta la notte fino a Pechino, e in stazione erano venuti a salutarci la zia Gūgu e il marito Gufu.
In cinese ogni grado di parentela ha un termine preciso. Gūgu vuol dire infatti “zia sorella maggiore di papà”, mentre Gūfu “marito della zia Gugu”. Insomma, impossibile sbagliarsi.
Con loro c’erano i due figli. Ránran, “gradualmente ascendente”, era una bambina dolce e un po’ cicciottella proprio come me, di un anno più grande, anche se sembrava più piccola. Liáoliao, un soprannome che significava “chiacchiera chiacchiera”, era invece un ragazzo molto più grande, ed era stato cresciuto a Shanghai dai nonni paterni. Per questo con lui non avevo tanta confidenza.
Erano venuti con noi fino al binario comprando i biglietti speciali da accompagnatori. Ci sorridevano, poche parole e zero abbracci. Tra cinesi tradizionalmente è così, anche coi parenti più stretti, compresi Mama e Baba.
Lo zio, nel salutarci, poco prima che il treno verde militare partisse, disse: «Dài, ora andate a vedere com’è... poi al limite tornate indietro».
Ma in Cina c’è un detto: yījǐn húanxīang, quando lasci il tuo villaggio per emigrare, ci ritorni solo con l’abito di seta. In altre parole: se non ce l’hai fatta, ti conviene restare dove te ne sei andato. Finisci incastrato in un meccanismo.
Avrei scoperto, guardando in TV Raffaella Carrà, che anche agli italiani emigrati in Argentina era accaduto lo stesso. Alcuni erano rimasti lì pure senza aver fatto fortuna. Tutt’altro.
Io, comunque, in quel momento non diedi peso alle sue parole, assonnato com’ero.
Non avrei mai immaginato che per quel viaggio non c’era un biglietto di ritorno e che stavo dicendo addio alla mia infanzia felice a Jǐnán.
Prima di rivedere la mia città natale, le sue colline, le strade colme di biciclette, la mia vecchia scuola elementare – Weǐ jǐu lù xǐao xúe, “Latitudine nove” –, sarebbe passato molto, molto tempo.
![]()
Il perché fummo costretti a fare tappa a Francoforte lo scoprii qualche anno dopo.
La verità era che noi avevamo provato in ogni modo a ottenere il visto per l’Italia, in modo da arrivare regolarmente a Milano. Regalammo perfino una teiera a forma di Gūanyīn – il bodhisattva della compassione, in sanscrito Avalokiteśvara, quella che per i cinesi è un po’ come la Madonna per gli italiani –, a una funzionaria della Banca commerciale italiana che lavorava a Pechino. Una donna sui quarant’anni, con capelli biondi e vaporosi, dall’aspetto elegante, che mi ricordava la signora Thatcher vista in TV.
Ma fu tutto inutile.
Solo in Germania potevamo arrivare regolarmente, cioè col nostro vero passaporto, quello su cui stava scritto il mio cognome e nome: Shí, che significa “pietra”, e Yáng, “sole”, o “positivo”, “maschio”. Per l’ultima tratta del viaggio, da Francoforte a Milano, avremmo preso un treno insieme a un “traghettatore”, e saremmo entrati in Italia come clandestini. Io, naturalmente, non ne sapevo nulla.
Il nostro volo faceva scalo a Roma. Ci arrivammo stanchissimi, specialmente io, che durante il viaggio per l’agitazione non ero riuscito a mangiare niente. Proprio io, soprannominato da sempre Pang Pang, “Ciccio Ciccio”, per la mia voracità.
Mia madre – lei che era magra magra e non mangiava mai tanto – pur di non sprecare il cibo, e nonostante il sonno, si era presa anche la mia porzione. Fin da quando era bambina, il governo cinese aveva fatto martellanti campagne informative sul non sprecare il cibo, e poi il biglietto era costato moltissimo.
«Siamo arrivati?» chiesi quando ci fecero scendere dall’aereo.
Non mi sentivo quasi più le gambe, tanto ero rimasto seduto. Ero felice di poter camminare un po’, lì nell’area internazionale dell’aeroporto.
«Non ancora. Dobbiamo fare scalo adesso» mi rispose lei.
«E quando arriviamo?»
«Stai tranquillo» mi disse. «Intanto dobbiamo scoprire dove andare.»
Il nostro volo da Hong Kong era arrivato in ritardo e avevamo perso la coincidenza.
Sbuffai e mi guardai intorno. L’aeroporto era strano, senza neanche una scritta in cinese. Da ogni parte, poi, facce di lǎowài, “stranieri”, con occhi grandi e nasi grossi, che si assomigliavano un po’ tutti.
Così uguali che quando mia madre provò a chiedere informazioni su dove dovessimo andare per prendere il volo diretto a Francoforte e ci indicarono un lǎowài con la barba nera, in divisa blu e col cappello bianco – «Seguite lui» ci dissero –, noi per sbaglio ci mettemmo a seguire un altro lǎowài, sempre con la barba. La fotocopia sputata del capitano Haddock delle “Avventure di Tintin”.
Per me, e anche per mia madre, non c’era differenza.
![]()
Volando volando, anche la mia cameretta a Jǐnán mi sembrava volata via lontano.
Il letto largo una piazza e mezza, d’inverno con la trapunta rossa a fiori e d’estate col líang xí, un fresco copriletto di vimini, lo scaffale dei libri con l’enciclopedia Diecimila perché, regalatami dalla mia nonna paterna, e poi la scrivania dove facevo i compiti, e in una bella scatola sotto il letto tutti i miei fumetti.
Chissà cosa ne sarebbe stato, pensai seguendo quel capitano Haddock, della mia collezione delle “Avventure di Tintin”.
“Tintin” lo avevo scoperto a otto, forse a nove anni, ed era diventato subito una delle mie letture preferite.
Mi...