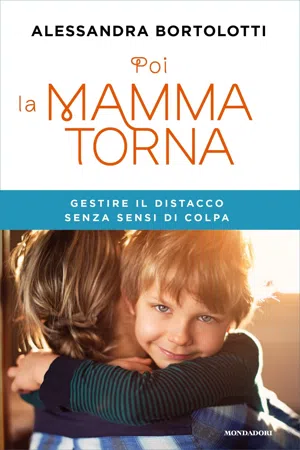Educazione affettiva: perché?
È il primo giorno del tuo nuovo lavoro. Sei emozionata e anche un po’ spaventata. Tutti ti hanno detto che sarà una magnifica occasione per crescere e fare nuovi incontri. Hai conosciuto i tuoi capi, e ti senti fortunata perché ti hanno fatto un’ottima impressione: ti sei sentita accolta! Ti hanno fatto vedere la stanza in cui lavorerai: è colorata e arredata con cura. Anche chi ti ha accompagnato in questa prima esplorazione si è mostrato entusiasta e ti ha incoraggiata. Hai potuto portare in anticipo i tuoi effetti personali e, a quanto pare, ti sentirai come a casa: potrai perfino stare in ciabatte!
L’orario sarà flessibile e conoscerai tanti colleghi che, come te, stanno vivendo la stessa esperienza. Avrete sicuramente modo di familiarizzare, e c’è chi faciliterà le vostre relazioni con competenza e disponibilità. Tutto si mette proprio nel migliore dei modi.
Quando arriva il grande giorno l’emozione è davvero forte: il tuo cuore batte all’impazzata e tutti hanno scelto vestiti speciali, proprio come a una festa. Decidi di farti accompagnare da chi ti vuole bene come nessun altro e, insieme, camminate attraverso il giardino (ah sì, c’è pure il giardino per prendere un po’ d’aria e sgranchirti le gambe: wow!), pronti a entrare nella stanza che conosci già... Che l’avventura cominci!
A quel punto però succede qualcosa di strano... qualcosa che non ti aspettavi proprio.
In corridoio, resti di stucco vedendo che uno dei tuoi colleghi piange e si attacca alle gambe del suo accompagnatore: perché? Cosa sta succedendo?
Piena di fiducia, entri nella stanza che hai già visitato e trovi una situazione strana: un gruppo di colleghi soli, senza accompagnatori, con l’aria a dir poco smarrita.
Sembrano tristi e spaventati.
Altri, che tornano lì già da un paio d’anni, sono felici e contenti, chiacchierano fra loro ridendo fragorosamente e aspettano l’inizio delle attività.
Eppure è così difficile veder piangere degli sconosciuti... Ti senti un po’ stranita: quante emozioni in quella stanza, quante persone estranee!
Poi ti accorgi che gli accompagnatori sono gentilmente invitati ad andarsene. La porta d’ingresso viene chiusa, ma tu non puoi uscire. Piangere non servirà a far tornare chi ti dà sicurezza: devi fidarti dei tuoi capi, che però per te sono ancora dei perfetti sconosciuti, specie ora che sei all’inizio. Dentro di te cominciano a farsi strada mille pensieri e mille sensazioni: mi sento sola! Non conosco nessuno! Perché non posso uscire? Quando posso tornare a casa?
Che strano modo di cominciare un libro. Una storia paradossale e per certi versi comica, che accosta il primo giorno d’asilo al primo giorno di lavoro di un adulto. Ma no, direte voi, il paragone non ci sta. Gli adulti sanno cosa stanno andando a fare: non si fanno accompagnare, non lavorano in ciabatte, ma soprattutto possono uscire e rientrare dalla loro stanza quando vogliono.
Infatti, è proprio questo il punto: gli adulti lo sanno, i piccoli no. Non sanno perché sono lì, non vogliono restare soli, non hanno una cognizione del tempo abbastanza strutturata da dar loro la certezza che... poi la mamma torna.
Se è in crisi, il bambino vuole soltanto una cosa: che la mamma, il papà, la nonna o qualsiasi altra figura familiare torni a prenderlo proprio ora, nell’esatto momento in cui si sente spaventato, sorpreso, abbandonato, incerto, curioso o tutte queste cose insieme. Non dopo, quando ha finito di lavorare, colorare o mangiare. Ora. Punto.
Eppure un elemento in comune fra bambini e adulti c’è.
Pensateci un attimo.
Entrambi provano emozioni forti, dettate dalla novità e dal cambiamento. L’adulto però ha una motivazione chiara del perché si trova lì, e farà tesoro di altre esperienze o situazioni nuove che ha già vissuto e superato in passato, anche quando era piccolo.
Il bambino no. In quel frangente, avrà bisogno che le sue sensazioni vengano riconosciute, accolte e prese sul serio. Avrà bisogno di fiducia, di sentirsi autorizzato anche a provare emozioni come l’incertezza o lo sconforto.
Non sempre le emozioni di grandi e piccini vengono prese sul serio. Accade tutti i giorni, in qualsiasi contesto. Non a caso, ho scelto come esempio il primo giorno di nido o di scuola dell’infanzia. Con questo non intendo dire che non esistano nidi, scuole dell’infanzia e educatrici fantastiche o criticare la scelta di mandarci i vostri figli. Si tratta di una decisione strettamente personale, e l’intento di questo libro non è metterla in discussione.
Il messaggio che voglio promuovere è un altro.
Scorrendo le prossime pagine e i prossimi capitoli sarà chiaro a tutti che parlo di emozioni e di educazione affettiva: un argomento che riguarda le persone in quanto tali, indipendentemente dalla loro età o dal loro ruolo. Questo è un libro che tenta di abbattere dei muri: il muro dell’incomunicabilità affettiva fra grandi e piccini, il muro dei metodi educativi che alterano la relazione con i nostri figli, il muro di una società e di una norma culturale che impongono ai genitori di omologarsi a un’ideologia comune basata sull’interferenza, l’alterazione o addirittura la repressione di ciò che proviene dal nostro cuore, dal nostro mondo affettivo. L’obiettivo, forse un po’ ottimistico, è quello di promuovere una società di persone che si sentano legittimate a dare valore alle proprie storie e a quelle degli altri: storie fatte di vissuti e di emozioni, senza distinzione di ruoli, età, nazionalità o scuole di pensiero. Questo libro parla anche dei bambini che siamo stati e di ciò che ci portiamo dentro come memoria affettiva. Avete appena letto una storia alla rovescia, in cui l’adulto viene paragonato a un bambino di tre anni all’epoca dell’inserimento nella scuola dell’infanzia. Alla rovescia, perché siamo soliti vivere in una società adultocentrica che tende a vedere i bambini come piccoli adulti da impostare, da adeguare ai tempi e ai modi dei grandi.
Molti di voi avranno sorriso, o forse pensato che quel paragone fosse paradossale. E infatti lo è. Vi sarà sembrato bizzarro che si possa andare a lavorare in ciabatte... Ma se accettiamo che un adulto possa sentirsi a disagio pur avendo ben presente la motivazione che lo porta a trovarsi in un luogo ignoto con persone ignote, perché pretendiamo che i bambini debbano abituarsi rapidamente e in tempi prestabiliti ad ambienti e persone mai viste?
A questo punto converrà soffermarci brevemente sui concetti di abituazione e abitudine che tanto ricorrono nei libri e nelle parole di chi ha a che fare con i bambini. L’abituazione è il processo inibitorio di risposte nuove che porta all’abitudine, cioè a comportamenti appresi destinati a riproporsi automaticamente in presenza di particolari stimoli o situazioni. Per esempio, se un bambino di notte chiama o piange per essere consolato e nessuno risponde a quei segnali prendendosi cura di lui, alla fine non chiamerà più: avrà capito che le sue richieste, nelle varie forme e modalità in cui le ha espresse, non vengono accolte. I suoi tentativi di richiamo in un momento di difficoltà, il suo sano e legittimo istinto di cercare risposta nelle relazioni affettive, il suo tentativo di trovare un segnale efficace per ristabilire una relazione di sicurezza con l’adulto saranno così inibiti, perché non sono serviti a ottenere ciò di cui aveva estremo bisogno. Il tutto perché gran parte degli adulti è ancora convinta che un bambino che non dorme come i grandi vada educato al sonno, e non invece rispettato nel suo essere bambino. Lui non chiamerà più, non perché la frustrazione delle sue richieste lo abbia spinto a tirare fuori le sue risorse, ma perché chi si prende cura di lui ha risposto con l’indifferenza al suo richiamo e al suo modo di manifestare affettivamente un bisogno di rassicurazione, di contatto, di vicinanza e di calore. Il nostro bambino, inoltre, non penserà che la sua domanda di aiuto sia sbagliata: anche questa è una deduzione derivata da una competenza adulta, così come l’affermazione fin troppo nota che la frustrazione vada indotta come metodo educativo perché stimola i bambini a sfoderare le loro competenze.
No, le cose non stanno così e lo vedremo meglio più avanti. L’unico risultato sarà questo: il bambino penserà che a essere sbagliato sia lui, se prova emozioni che i grandi mostrano espressamente di non accogliere e giudicano negative, indesiderabili, fastidiose, manipolatrici o furbe, specie se chiama di notte, quando tutti sanno che “di notte si deve dormire”. Il sonno dei bambini fino ai tre anni è completamente diverso per qualità e quantità da quello degli adulti. Prima ce ne facciamo una ragione e ci decidiamo a fornire ai genitori le corrette informazioni sulla fisiologia del sonno infantile, prima potremo aiutarli a gestire i risvegli notturni dei figli come tutti gli altri aspetti che si trovano già a gestire di giorno. Invece continuiamo ad assistere imperterriti al proliferare di metodi e pubblicazioni che invitano i genitori a distanziare le poppate notturne o a utilizzare il ciuccio con l’intento di modificare i loro ritmi di sonno fisiologici, cioè normali. Certo, la mattina i genitori lavorano ed è fondamentale non essere troppo stanchi. Ma la soluzione non è proiettare sui piccoli le aspettative di produttività ed efficienza che caratterizzano il mondo degli adulti; piuttosto, è quella di stabilire chiari confini tra ciò che significa essere un bambino e ciò che significa essere un adulto, tra ciò che compete all’uno e ciò che compete all’altro.
Nella nostra società sembra che il mondo affettivo si strutturi in base a meccanismi educativi basati più sul potere gerarchico che sul riconoscimento dei bisogni di tutti e sull’evolversi delle loro relazioni. Per continuare con gli esempi, nel novembre di qualche anno fa, durante una riunione di post-inserimento alla scuola dell’infanzia con gli educatori, ricordo che una coordinatrice si complimentò con molti genitori dei bambini di tre anni perché finalmente erano riusciti a “lasciare” i figli, anche se piangevano, dimostrando fiducia nelle maestre. Peccato però che la fiducia nelle emozioni di quei bambini non sia stata altrettanto considerata, accolta e rispettata, e che i genitori in questione siano stati giudicati più bravi e con una marcia in più rispetto a quelli che invece avevano preferito aspettare che la loro creatura si calmasse e accettasse il distacco temporaneo da loro (senza nulla togliere alla capacità delle maestre di consolare i bambini).
Nel capitolo dedicato agli asili nido e alle scuole dell’infanzia avremo modo di constatare che nella fase di inserimento la separazione dai genitori viene favorita e in genere meglio tollerata dai più piccoli quando si opta per una collaborazione fra educatrici, genitori e bambini e non per una rigida adesione ai protocolli. Vedremo anche che dare importanza al processo con cui il bambino struttura dentro di sé la sicurezza che poi la mamma torna dà più risultati della scelta di rispettare tempi prestabiliti che rischiano di non tenere conto dell’unicità delle persone coinvolte e del momento che stanno affrontando.
Per continuare con il nostro apparente paradosso – che troppo spesso, purtroppo per i più piccoli, diventa una realtà – immaginiamo di essere in ufficio e di dover andare via proprio quando alcuni colleghi iniziano a manifestare un profondo disagio. Ce ne andremmo via di fretta, magari di soppiatto, aspettandoci pure i complimenti del nostro datore di lavoro per averli lasciati soli? E ancora: immaginiamo di svegliarci impauriti nel cuore della notte e di essere rassicurati da una mano, un abbraccio o una parola dolce del nostro compagno o della nostra compagna. A chi non è capitato? Ora proviamo a immaginare la stessa situazione, ma che al nostro risveglio lui o lei ci spieghino con parole amorevoli che quel contatto minaccia la nostra autonomia e che sarebbe meglio, anzi, se andassimo a dormire in un’altra stanza: come ci sentiremmo?
Nella nostra cultura i bisogni dei bambini non sono ritenuti importanti come quelli degli adulti. Non solo, ma si tende a considerare normale, nel senso di normalità culturale, il ricorso a metodi basati su regole e limiti stabiliti da esperti, miranti a educare i bambini alla disciplina, a evitare i capricci e a comportarsi bene. Il conflitto inoltre è visto come qualcosa da scongiurare perché rivelerebbe una mancanza educativa, piuttosto che una risorsa da gestire per dare voce ai bisogni di tutti in vista di nuovi equilibri. Non si ritiene altrettanto importante che gli adulti imparino a capire, a sentire con il cuore e nel cuore da dove hanno origine i comportamenti dei bambini che di solito vengono valutati negativamente e catalogati con parole come capricci o sfide. Sembra che il loro universo affettivo abbia valore solo nei primi mesi di vita, passati i quali la maggior parte dei manuali o degli esperti prevede un metodo o qualche genere di interferenza da frapporre nella relazione con gli adulti. La relazione non viene considerata come una risorsa da potenziare in vista di una soluzione, ma come un ostacolo o, tutt’al più, come un fattore importante solo a orari alterni. Come nel caso dell’allattamento notturno: guai a portarlo avanti nei mesi (o negli anni) senza limiti e orari! E questo nonostante le indicazioni della comunità scientifica concordino nel consigliare e promuovere l’allattamento a richiesta nelle 24 ore, anche in caso di allattamento artificiale. Se ciò accade è perché spesso i bisogni dei più piccoli vengono visti come potenziali vizi: in quel caso, è molto più facile stabilire regole attraverso la delega a presunti esperti che mettersi in gioco come persone in divenire, concedendosi il tempo e lo spazio necessari per capire che cosa succede a quel bambino e a quegli adulti in quel preciso contesto ambientale e affettivo.
Cosa vuol dire educare agli affetti
Quale genitore non si è mai chiesto se sia meglio un’educazione ferma, basata su regole, limiti e punizioni, o un’educazione permissiva che asseconda ogni esigenza del bambino per evitargli possibili traumi? La mia idea è che, per rispondere a questa domanda, disponiamo di alternative meno dogmatiche e più efficaci, capaci di rispettare i bisogni di tutti.
L’unica vera regola è che esiste una fisiologia degli affetti, valida anche da un punto di vista scientifico, e che interrompere la comunicazione con quel complesso sistema corporeo ed emotivo grazie al quale viviamo, amiamo, ci arrabbiamo, camminiamo, pensiamo, significa interrompere un processo vitale che dovrebbe portare a fidarci di ciò che emerge spontaneamente dentro di noi. L’ambiente emotivo in cui viviamo va inteso in una duplice accezione: è un ambiente interno e al tempo stesso esterno. Quello interno è scritto dentro di noi come uno spartito musicale in cui le note vengono inserite giorno dopo giorno. Questo ha cominciato a riempirsi ancora prima che fossimo concepiti, grazie alle esperienze e ai vissuti dei nostri genitori. La nostra vita prenatale, la nostra nascita, i primi giorni, i primi mesi e i primi anni di vita restano scolpiti come ricordi indelebili in quello spartito, che forse non è di facile accesso alla nostra memoria cosciente, ma lo è senza ombra di dubbio alla nostra memoria affettiva. Attraverso l’unione di tutte quelle note si origina una melodia che caratterizza ciascuno di noi in maniera unica e irripetibile, e ogni volta che la ascoltiamo ci riporta alla nostra storia più profonda, una storia che non si può spiegare ma soltanto sentire col cuore e in connessione con le parti più universali dell’essere umano. Una melodia è molto più della somma delle sue note: è un tutto che, se non viene ascoltato e preso nella sua interezza, ci fa sentire “a pezzi”, smembrati, non completi. Un concetto che un famoso scrittore è riuscito a esprimere in una frase semplicissima e al tempo stesso pregnante: «Tutti i grandi sono stati bambini, ma pochi di essi se ne ricordano».1
Anche l’ambiente emotivo esterno fa parte dell’esperienza di ognuno di noi, per il semplice fatto che viviamo in una società dotata di norme sociali e culturali con cui fare i conti e con cui misurarci in base alle nostre credenze e ai nostri valori. Un altro aspetto cruciale che affronteremo insieme, quindi, riguarda le varie possibilità di comunicazione fra i nostri ambienti. Prenderci cura delle relazioni, a partire da quella con noi stessi, metterci in gioco in prima persona e prestare l’attenzione necessaria ai nostri processi comunicativi verbali e non verbali, è uno strumento prezioso che permette di valorizzare il mondo affettivo e rispettare i bisogni di tutti. Significa concepire le relazioni come una sorta di teatro in cui si rappresenta la vita vera, dove gli attori sono tutti persone egualmente meritevoli di considerazione e rispetto e nel quale è possibile esperire emozioni di ogni genere e trovare lo spazio per manifestarle ed elaborarle. Significa vivere con i bambini, e non nonostante i bambini. Significa anche vivere, dare valore e mettersi in contatto con il bambino interiore che è dentro di noi.
La comunicazione verbale e non verbale degli adulti è un esempio che i bambini assimilano come il cibo che mangiano. Dal punto di vista affettivo, i piccoli sono molto più competenti di quanto pensino gli adulti, perché dalle nostre espressioni corporee e dai nostri atteggiamenti capiscono immediatamente se siamo felici o se qualcosa non va. Il nostro esempio per loro è una fonte di esperienza, un modello di riferimento per le relazioni presenti e future. La comunicazione umana è un sistem...