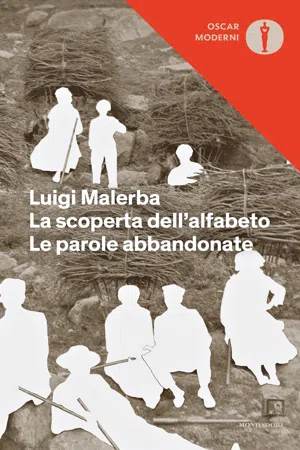
- 322 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La scoperta dell'alfabeto - Le parole abbandonate.
Informazioni su questo libro
I racconti della Scoperta dell'alfabeto (1963) sono ambientati nelle terre dell'Appennino parmense che hanno dato i natali a Malerba: la culla di una cultura contadina arcaica rimasta immune per secoli a ogni sorta di rinnovamento e infine toccata, e distrutta, dalla società dei consumi. Malerba ne rievoca l'aspra lotta contro fame e fatica, la violenza di rapporti umani basati sulla necessità di sopravvivere, una pena dell'esistere di lontanissima memoria. Tanto forte è l'interesse per questa civiltà contadina che Malerba vi ritorna anche dal punto di vista saggistico con Le parole abbandonate (1977), «repertorio dialettale emiliano» che rappresenta il versante linguistico e antropologico della sua originale indagine narrativa.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a La scoperta dell'alfabeto - Le parole abbandonate. di Luigi Malerba in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788804681564eBook ISBN
9788852083242LE PAROLE ABBANDONATE
Un repertorio dialettale emiliano
Nota bibliografica
Settantamila voci compongono il Vocabolario parmigiano-italiano di Carlo Malaspina (4 voll., Tipografia Carmignani, Parma, 1856). Nonostante alcune incertezze, che crescono man mano che ci si allontana dall’area cittadina, il Malaspina è il più ricco punto di riferimento per ogni raffronto tra il dialetto parmigiano vero e proprio e i dialetti delle zone circostanti. Vi si riscontrano tuttavia delle lacune soprattutto per quanto riguarda la terminologia agricola. In molti casi le definizioni sono parziali o errate (per esempio la maràsa, grossa roncola per tagliare i rami degli alberi, non si può usare per potare le viti). Incerte spesso anche le definizioni più comuni: sol (sole) viene definito: “Pianeta che illumina il mondo e conduce il giorno”. Di utile consultazione, anche se più ridotti come numero di voci, sono il Dizionario parmigiano-italiano di Ilario Peschieri (2 voll., Tipografia Vecchi, Borgo San Donnino, 1836), il Dizionario parmigiano-italiano di G. Carpi e V. Pavarani (Cremona, 1966) e il Vocabolario parmigiano-italiano di Carlo Pariset (Ferrari e Pellegrini, Parma, 1885-1892). L’uso dei vocabolari dialettali presuppone comunque una conoscenza iniziale del dialetto dal momento che sono tutti e sempre a senso unico (dal dialetto all’italiano e non viceversa) e data anche la grafia non uniformata, almeno per quanto riguarda il dialetto parmigiano e i dialetti del parmense.
Per una bibliografia essenziale sui dialetti dell’Emilia-Romagna si può consultare quella de I dialetti delle regioni d’Italia di Giacomo Devoto e Gabriella Giacometti (Sansoni, Firenze, 1972). Modi di dire, filastrocche e scherzi dell’Appennino parmense, soprattutto di Solignano, si trovano in Pellagra allegra, le rime popolari parmensi di Giovanni Petrolini (La Pilotta, Parma, 1975). Lo stesso autore dà una notevole esemplificazione del turpiloquio dialettale del parmense in uno studio sulle interdizioni verbali, Tabù della parlata di Parma e del suo contado (La Pilotta, Parma, 1971) dove tuttavia l’autore curiosamente è vittima a sua volta almeno di un tabù quando traduce eufemisticamente conno le voci dialettali corrispondenti a fica. Un buon repertorio di Proverbi e modi di dire parmigiani, ma anche dei dintorni, è quello di Guglielmo Capacchi (Gazzetta di Parma-Artegrafica Silva, Parma, 1975). Sebbene si riferisca a un’area dialettale di influenza prevalentemente ligure, ricordiamo anche L’alta valle del Taro e il suo dialetto di Antonio Emmanueli (Tipografia Cavanna, Borgotaro, 1886).
Per i riferimenti di carattere generale sul lessico va consultato l’Atlante linguistico italo-svizzero di Karl Jaberg e Jacob Jud e, per la fonetica, la morfologia e la sintassi, la Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti di Gerhard Rohlfs (Einaudi, Torino, 1966) anche se in quest’ultima i riferimenti al dialetto parmigiano sono relativamente scarsi e scarsissimi quelli ai dialetti dell’Appennino. Sui substrati dialettali dell’Emilia-Romagna vedi il Saggio sui dialetti gallo-italici di Bernardino Biondelli (Bernardoni, Milano, 1853). Per le derivazioni latine il Glossario latino-emiliano di Pietro Sella (Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1937). Nella vastissima letteratura sui dialetti italiani, utili riferimenti a voci dialettali dell’Appennino si trovano in Italia dialettale di Giulio Bertoni (Hoepli, Milano, 1916), in Studi e ricerche su lingua e dialetti d’Italia di Gerhard Rohlfs (Sansoni, Firenze, 1972), in Il linguaggio d’Italia di Giacomo Devoto (Rizzoli, Milano, 1974) e nelle Postille italiane al REW di Meyer-Lübke di Paolo A. Faré (Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano, 1972).
Sulla storia della zona appenninica parmense si possono consultare le pagine a essa dedicate nella monumentale Storia della città di Parma di Ireneo Affò (Tipografia Carmignani, Parma, 1792-1795, riediz. La Bodoniana, Parma, 1956). Si raccomanda più che altro per le notizie sulle pievi della zona, ricavate dagli archivi parrocchiali, Le valli dell’Appennino parmense nella storia e nel canto dei poeti di Italo Dall’Aglio (Scuola Tipografica Benedettina, Parma, 1956). Per altre notizie storiche, geografiche e demografiche riferite ai primi decenni del secolo scorso: Vocabolario topografico dei Ducati di Parma Piacenza e Guastalla di Lorenzo Molossi (Tipografia Ducale, Parma, 1832-1834) e Manuale topografico degli Stati Parmensi dello stesso autore (Tipografia Reale, Parma, 1856). Una breve monografia su Berceto, ricca di notizie storiche e di indicazioni bibliografiche e di archivio è Una finestra aperta sul passato, Berceto di Franco Grisenti (Arte Grafica, Fidenza, 1964). Va segnalato inoltre La strada romea di Arturo Carlo Quintavalle (Silvana, Milano, 1976). Un documento di grande interesse sia per la lingua parlata nel Cinquecento a livello popolare, sia per la descrizione della vita quotidiana in un borgo dell’Appennino, è il diario cinquecentesco del parroco di Berceto, Giorgio Franchi (Poveri homini, Cooperativa Scrittori, Roma, 1976).
Utili soprattutto per il reperimento di dati e statistiche attuali: La montagna vuole vivere di Fabio Fabbri (SEER, Parma, 1975) e i volumetti che di anno in anno dal 1967 vengono pubblicati a cura del Comune di Berceto (Arte Grafica, Fidenza). Notevole copia di informazioni sulla geologia, il clima, la flora e la fauna delle valli del parmense compongono la Guida naturalistica del parmense di Angelo De Marchi (La Nazionale, Parma, 1974). In appendice alla guida è riportato un elenco di toponimi naturalistici, località che hanno preso nome da caratteristiche del terreno, e una ampia bibliografia sugli studi naturalistici della zona.
Per un raffronto con altre aree dialettali si potranno leggere alcuni testi recenti che, pure con angolazioni diverse di volta in volta, offrono materia di riflessione sulla sopravvivenza delle culture marginali: Paese perduto di Dino Coltro (Bertani, Verona, 1975-1976) per la zona lungo il corso dell’Adige fra Zevio e Legnago, Una cultura in estinzione di Ulderico Bernardi (Marsilio, Venezia, 1975) per le campagne intorno a Oderzo fra il Piave e la Livenza, Il re è un feticcio di G. Barbiellini Amidei e B. Bandinu (Rizzoli, Milano, 1976) per il paese di Bitti in Barbagia, Sardegna, La cultura sommersa di Giuseppe Lisi (Libreria Ed. Fiorentina, Firenze, 1972) per la zona dell’alto Mugello in Toscana.
Un riferimento, alla fine di questa nota, va fatto a La scoperta dell’alfabeto (Bompiani, Milano, 1963), un libro di racconti ambientati nella zona di Berceto, Solignano e Valmozzola, scritto dallo stesso autore di questo repertorio dialettale emiliano.
Sono debitore di utili consigli, per quanto riguarda la impostazione generale del lavoro a Maria Corti, per le singole voci a Aldo Chierici, Giampaolo Dossena e al prof. Angelo Stella dell’Università di Pavia.
L.M
La ca’
(la casa)
Arlöj. Orologio. Arlujèr, orologiaio. L’orologio “da tasca” in realtà resta quasi semypre appeso a una parete della cucina. È impensabile un contadino che va a lavorare nei campi portando con sé l’orologio. Il contadino regola il suo tempo con il sole: il sole è il suo orologio e la luna il suo calendario.
Bazlōtt. Bacile (bacilotto), catino. Serve per lavarsi la faccia, le mani, i piedi. Può essere di ferro smaltato o di alluminio. Il catino vecchio e ammaccato viene usato per dare al rùmel (il pastone di crusca) alle galline o al bevròn (il beverone) ai vitellini appena slattati. I bazlōtt sfondati, ormai inservibili, restano ad arrugginire per anni dietro la casa del contadino buttati lì insieme a barattoli di conserva e scatolette di sardine.
Bilèin. Gioco, giocattolo. Mentre zög (gioco) significa giocattolo per bambini più grandicelli (ma anche “gioco” in senso generale come in italiano), il bilèin appartiene ai bambini molto piccoli. Bilèin non è quasi mai un giocattolo nel senso proprio, cioè confezionato come tale, ma piuttosto un oggetto qualsiasi che il bambino assume come giocattolo.
Brònza. Pentola. Sembra prendere il nome dal bronzo, ma in realtà era di rame prima che si diffondesse l’uso dell’alluminio. La pentola di rame deve essere stagnata periodicamente all’interno allo scopo di evitare la formazione dell’ossido di rame, fortemente tossico. Questa operazione la fanno sul luogo gli stagnini (i magnàn) ambulanti. La parte interna da stagnare viene prima lavata con l’acido solforico e quindi vi si versa lo stagno fuso che viene spalmato sulla superficie con un batuffolo di stoppa. In ca’ sùa a-gh’é sèimper la brònza pièina, si dice della massaia (resdùra) che sa amministrare con saggezza le risorse famigliari.
Buchèl. Vaso da notte. Sarebbe letteralmente “boccale”. È probabile che in questa denominazione ci sia una intenzione eufemistica, ma può anche darsi più semplicemente che abbia contribuito a dargli questo nome il manico che in qualche modo lo fa somigliare, in grande, a un boccale per la birra. Può essere di ferro smaltato o di ceramica, spesso decorata a fiori anche nella parte interna. Viene tenuto sotto il letto e vuotato la mattina dalla finestra che dà sul dietro della casa. Si usa qualche volta al posto del bazlōtt per buttar su l’alsìa (la liscivia) del bucato. Caghèr föra dal buchèl, commettere un errore.
Bufòn. Soffione. Da bufèr, soffiare. Fa parte della attrezzatura del focolare e serve per soffiare sul fuoco. Consiste in una canna di ferro con una strozzatura nella parte terminale bassa, dove passa il fiato. Due zampe di ferro lunghe una decina di centimetri, saldate in basso ai lati della strozzatura, servono di appoggio. Quasi sempre i bufòn venivano ricavati dalle canne dei vecchi fucili ad avancarica, quando questi vennero sostituiti dalle doppiette a retrocarica.
Büghè. Bucato. Si mettono i panni sporchi in un mastello di legno (la sujöla), sopra vi si stende un telo pesante di canapa (al bügaròn) e su questo si depone la cenere sulla quale viene versata acqua bollente per una intera mattinata. La sujöla ha un buco in basso dal quale esce lentamente l’acqua filtrata attraverso la cenere e i panni (l’alsìa) che viene raccolta e versata di nuovo sulla cenere.
Burnēl. Trave maestra della campata per sostenere il tetto. Può essere di castagno, di quercia, di abete. I trèvel sono le travi laterali della campata mentre per travèt si intendono piuttosto le travi squadrate che servono a sostenere le tavole di legno dei pavimenti del primo piano. Il Vocabolario nomenclatore del Premoli dà “bordonale”, il Devoto-Oli anche “bordone” e lo fa derivare dal tardo latino burdo, mulo, con riferimento evidente al portare pesi.
Ca’. Casa. L’ideale del contadino è di avere una casa cun tütt i sò còmed, con tutte le sue comodità. Le comodità si riducono a poco: le porte che non lasciano passare gli spifferi nella stagione fredda, il camino che non fa fumo, una cucina grande e calda, lo spazio per conservare all’asciutto il grano e la farina, una cantina fresca per il vino e i salumi, una camera da letto con una buona esposizione e perciò senza umidità. Di solito la camera da letto viene collocata sopra la cucina in modo che il calore del camino o della stufa la riscaldi durante l’inverno. Un calendario, un ventaglio di cartoline con un mazzetto di spighe di grano, una carta a fiori e pizzi per la credenza a muro, qualche fotografia in cornice, sono le...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Introduzione. di Paolo Mauri
- LA SCOPERTA DELL’ALFABETO
- La scoperta dell’alfabeto
- Fuoco e fiamme
- L’anello nella neve
- I dollari
- Il silenzio
- L’amore in fondo al pozzo
- L’acqua del mare
- Il letto caldo
- Storia della morìa
- Il toro argentino
- Dignità
- Federico e Napoleone
- Il museo
- I mongoli
- La difesa della lingua
- Le oche volano
- La bomba
- Le ruote della civiltà
- Il rospo
- Buongiorno e buonasera
- La polmonite
- Verde come il mare
- LE PAROLE ABBANDONATE. Un repertorio dialettale emiliano
- Copyright