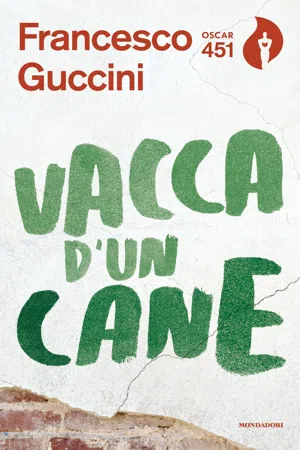Non è micca un lavoro facile, andare a stare in cità. Che senso ha, cosa vuol dire, dov’è la necessità? Lì d’atorno hai la tua vita, tutta intera, quello che ti basta, tutto il tuo bisogno senza stare a cercare inutilità più o meno vaghe, di località remote e di posti sentiti dire ma non conosciuti, e forse paurosi. Hai un fiume, dei monti, degli alberi e delle stagioni, della gente che conosci e incontri tutti i giorni. E allora? Non si vive? Non si mangia? Non siamo già coperti e rincalzati, protetti dal freddo e da altri eventuali spiacevoli improvvisi accadimenti atmosferici? Siamo garantiti o no? Cosa c’è da andare a cercare in luoghi che non sai? Cos’è, questo improvviso desiderio d’avventura, di cambiamento, d’emigrazione, di Patagònia?
Anzitutto si guarda con sospetto a certi preparativi più o meno furtivi, casse che vengono costruite ad arte distruggendo altre casse poi segando, schiodando e nuovamente inchiodando. La guerra appena finita, perché è finita (ma cosa vuol dire che prima c’era la guerra e ora non c’è più? Che non c’è più gli americani? Che è tornato tuo babbo? Ciài guadagnato nel cambio? Effettivamente cos’è, in cosa realmente consiste una guerra?), ha lasciato dietro di sé un mucchio di materiali vari che, se opportunamente adattati, risolvono i mille problemi del nuovo vivere, come le casse appunto, che ne disfi tre per farne una nuova a tenuta sicura con scritte da una parte in americano e dall’altra in tognino. Poi si sentono discorsi a mezz’aria e si girotta atorno, tampelando or l’uno or l’altro per sapere cos’è che sucede, farete micca degli sgóbi?, che ’sta roba non mi convince del tutto, avendo però risposte oziose sulla necessità e il dovere e il lavoro che deve ricominciare; o, le àvole, sospiri e gemiti che però non consolano. Si vocifera anche di una località vicina e remota, vinta ed avvinta da tremendi geli invernali di uno sconosciuto profondo nord (perché, qui c’è tutto quel caldo, d’inverno? ma là allora come sarà?); per questo, abili artigiani all’uopo assoldati, ti confezionano per ogni eventuale bisogna scarpe a doppia o tripla suola in ben saldo corame di un bel marrone chiaro quasi giallo, profondamente imbollettate e con le sue lunette davanti e dietro che non si consumino subito. Il nome delle scarpe chiarisce la loro morbidezza e agilità, vengono nomati “tronchétti”. In cità con quele scarpe lì?, fa dice mia mamma, però sei preso da una parte che tè lasciali pur dire, anche quelli di cità, che poi piove e nevica e loro ciànno i piedi tutti bagnati e tè belli asciutti e caldi. Che gente è, coi piedi sempre bagnati spólti per la loro mania d’eleganza, quelli di cità?
Cos’è poi una cità? Più grande di qui, certo. Ma quanto? Ci si può perdere? Hai vaghi ricordi, sentori di qualcosa intravisto e intrasentito, e la paura confina a destra anche con una certa curiosità, un po’ come quel Colombo che salpa pel nuovo mondo nell’oleografia in casa di quella parente, ed è pieno d’ardire in viso, si capisce, ma anche di melancolìa, che sembra dire vado, non vado, sì adesso vado ma un po’ di calma, uno non può micca andare in America così di brutta, due minuti, e si capisce che, una volta andato, assieme ai marinari tutti starà sulla tolda finché l’ultimo lembo di terra non scompare alla vista, e da vedere c’è solo il mare e la scia di vapore che la nave si lascia dietro. Colombo il vapore? Be’ no, forse quello è il treno. Perché si apprende che prenderemo il treno.
Il treno poi aspettalo, perché non c’è più, che la linea (la ferrovia si chiama così, linea, come una riga che unisce un punto a un altro), è tutta bombardata, e i ponti sono finiti nel fiume, e le rotaie son là a svirgolare sulle massicciate e i vagoni a pancia in su, come agonizzanti galane senza speranza.
Poi, dai e dai, il giorno fatale arriva, arriva sì, ti cullavi in una sua improbabile impossibilità, ma sai mai, fingevi a te stesso una non realizzazione; per quella illusione hai fin lì trattenuto lacrime e invocazioni di mercé, ma ora sei di fronte all’ineluttabile, e le effondi in tutta la loro possanza, a gran gola, e vieni a viva forza scalzato da un alberino (non sai più i nomi?) al quale ti eri aggrappato a mani giunte nella speranza già morta in cor tuo che, visto che eri lì attaccato, tanto valeva lasciartici e gràzzie di aver partecipato, ma quasi per salvare la faccia, perché sapevi che non c’era niente da fare e il destino doveva seguire il suo corso e che nuove terre e terribili avventure ti avrebbero atteso.
S’ciào monti sorgenti, e non il treno ma un càmmion con de le panche ci caricò. Sono allegri o tristi i viaggiatori del dopoguerra? Sono soprattutto carichi all’inverosimile, di qualunque cosa atta a portare altre cose, borse valigie cavagne sporte e sportelli, casse rifatte, zaini e tascapani, e motteggiano quel bambino d’allora che s’illude di scorgere lungo la strada luoghi familiari segnati da un albero o da un dosso o da un fosso, come quando, dopo un po’ di tempo in un posto, ritorni e ti sembra di vedere per via facce che è impossibile che siano lì, ma fino a un giorno prima ti erano famiglie e ti andavi a ṡburlare contro ad ogni passo, e ti pare d’essere ancora lì, e di incontrarle.
Si comincia a vedere cos’è stata la guerra vera, al di là di quel mondo che in parte te l’aveva risparmiata. Si passa in mezzo a paesi di case ṡmitragliate, coi buchi delle pallottole che seguono loro illogici ricami, e case completamente per terra, ed altre che mostrano impudicamente un angolo di stanza, dove gente mangiava o dormiva, un resto di colore azzurrino alla parete, un quadro o una fotografia ancora appesi. I ponti spesso si interrompono bruscamente, per poi continuare a stampelle in legno o su un Bailey di ferro, e c’è anche una torretta in mattoni affumicata da un incendio che mostra ancora un orologio fermo ad un’ora che fortunatamente non conosci. E quell’ora la vedrai per anni.
Poi si arriva in una grande stazione, piena di gente confusamente viva, che sembra anche allegra, e completata l’odissea carico scarico finalmente si sale su un treno a vapore anche se per carrozza ci sono ancora i carri bestiame, e dopo un tragitto per una terra curiosamente tutta pari, fra infiniti filari d’uva retti da alberi e non da pali piantati, pare si sia arrivati. È la Città della Mòtta, la tua futura città. Per Carpi-Sużaramàntova si cambia.
C’è che ti aspetta, in stazione, una zia sconosciuta, o almeno così dicono, sai tè, e tutti ci si bacia con contentezza, ma ratti, perché c’è di nuovo da scaricare in fuga, prima che il treno prosegua oltre, l’ira di dio della roba, e da caricar tutto su un tricicclo che la zia ha astutamente portato, col padre che si mette al volante e spinge e tè stai giù che ha già il suo peso da far andare quel uomo, e anche noi carichi ci si incammina per distanze interminabili guardando in giro altre case diroccate, un parco con un muretto senza cancellate (ma perché qui gli alberi li tengono chiusi dentro?) o non guardando, con la testa bassa in segno di sprègio o conclamato disinteresse. Ma si arriva, finalmente, dove c’è una casa enorme e giallina, che dicono essere casa tua. Tutta? No, solo quella parte lì dove entri. Allora la zia, tanto i tuoi devono svaligiare tutto, cominciare quel lento lavoro d’assestamento che deve durare anni d’abitabilità, capisce la tua profonda malinconia e dice, fa: «Dai che andiamo a fare un giro in tram! Sei mai stato in tram?!». Ammettiamolo, è una grossa novità, il tram; come tale, ci amancava. E su, salito, c’è un odore, un odore come? da tram, è evidente. Bisogna fare il biglietto, ci sono lucide panche sui due fianchi, scintillanti ottoni, e gente sconosciuta, ma che immagini ben presto conoscerai tutta, come quella del paese. «Guarda questo! Era il palazzo dell’Agil!» «Cos’è l’Agil?», di marmo bianco e mattoni rossi, una strana architettura squadrata, e scure scritte semicancellate. Bello, se non fosse per il nero di un incendio che l’ha devastato ed ha anche fatto fondere i vetri che sono ancora ribollenti in fuori, globosi e non più trasparenti, bianchi gessosi e pieni di bolle, come se si fossero fusi cinque minuti prima. «Questa è la Stazione Piccola», e il tram gira, ci sono ancora soldati americani, li riconosci subito, dalla stella bianca sui càmmion sulle gip e su un tank, innocente plantigrado perché c’è già stata la liberazione. E se fossero quelli di su, i miei amici, quelli arrivati in quell’autunno? Ma il tram gira ancora, chi sale e chi scende e cominci a pensare che non ce la farai mai, a conoscerli tutti, e c’è un’altra casa bombardata, che rimarrà lì tanto, un’ala ritta e fiorente sulle rovine, e lì, in quel mucchio di macerie, c’era la mia casa, che fortunatamente eravamo sfollati, un miracolo, perché pròpio quel giorno lo Żiovàlter aveva gli straordinari e io ero andata in bicicletta a cercare delle uova in campagna, sembrava che dentro qualcuno ce lo dicesse, ci avvertisse, che la notte prima avevo sognato il povero Enea, che mi parlava parlava e io non capivo, ma stanno già pensando a ricostruirla, la ricostruiremo come prima, no, più bella, più moderna, e si vede infatti attorno che non è tutto morto, tutto a terra, perché ci sono colori e insegne e manifesti, cose queste mai viste, e negozi aperti e gente che cammina dappertutto come se tutti avessero uno scopo preciso, una direzione, senza perdersi lì in mezzo.
Quando si torna ci sono altri bimbi che ti scrutano, una strada e dei campi subito attorno. Senti una voce che dice: «È tornato quel bambino che abitava lì». Sembra che parlino di un altro, senti che parlano un po’ diverso. E hai l’impressione di una terra malvagia, non tua, dove sarebbe desiderabile stare solo un poco, di passaggio, turista, per poi tornare alla tua vera appartenenza. E invece quei muri ti rinchiuderanno per anni. Li guardi di sotto in su, li mastichi coi denti davanti. Stanze dove i tuoi frullano ancora avanti e indietro, scassando, spacchettando. Dov’è, in questo disordine, il mio libro di Pinocchio? Dov’è la gip dei soldati braṡiléro, quella che m’hanno fatto loro, quella tutta dipinta di verde, con la stella bianca amica sul cofano, quella col parabrezza di vetro vero e con la scritta Military Police?
La Strada, da un lato, principia dalla via Emilia e da essa diparte; dall’altro finisce e si disperde nel Far West, in direzione del campo di Magnavacca (tereno avelenato, reca il cartello, ma son balle per tener lontani noi mas’cini) e dell’isolato capannone delle Carozze Orlandi, milleottocento e ṡbliṡga, verso la Stazione Piccola, fra mandrie, chitarre, e future angosce e gioie adolescenti, quando il segno zodiacale della mina sorse in cielo sull’asse dell’eclittica. La via Emilia è poi quel tratto lì, non hai idea che attraversi tutta una Regione da est a ovest, o che sia il ricalco di quell’antica pista-cavedagna che univa tutti i villaggi su palafitte ai piedi del Grande Dio Appennino che allora si specchiava su una vasta laguna, Tin Affnin arse verse, averte ignem Iuppiter Appennine, quando la Città della Mòtta (per Carpi-Sużaramàntova si cambia), era davvero una mòtta e vi parlavano forse la strana lingua dell’Ávia Pèrvia, e la trivella qualcosa di più che mero emblema nello stendardo comunale. Prima ancora che arrivassero i Tóschi, poi i rossi celti dai capelli pieni di gesso rappreso, che lasciarono posto ai romani colonizzatori e finalmente costruttori della grande strada lastricata, continuamente percorsa, scomparsa e inondata, risorta e segnalata non più da pietre miliari ma dalle Grandi Cattedrali Romaniche, dei Lanfranco, dei Wilighelmo e degli Antèlami, vacca d’un cane!
Ma ora la via Emìglia è solo un nome, ed è solo quel pezzo lì vicino a casa tua, grosso modo dalle sbarre del passaggio a livello vicino al forno di Pavarotti e al barbiere con i giornali con le donne mezze nude; continua, si immagina quasi più che saperlo,verso il Ponte della Pradella, andando avanti fino in città, dove probabilmente finisce. Costituisce limite invalicabile, vallo da non superare perché ci passano i càmmion, oltre alle poche macchine, e ti è stato ordinato di non osare oltrepassarla, quella via Emìglia, che vai sotto a qualcosa, se no tè prendi un’unta che te la ricordi. Tè poi la passi lo stesso, perché Barchesini a cui genitori liberali e scialacquatori comprano Topolino, da poco riuscito a rinverdire antichi fasti, te lo fa leggere solo a casa sua, la tròglia, non te l’impresta; allora vale la pena quel rischio, e il guardarsi rapido in qua e in là per poi spiccare la breve corsa che ti porta, ansimante e al sicuro, nella strada alberata dall’altra parte, dove Barks t’attende con le sue lusinghe. Ci finisti anche in mezzo, una volta, quando un carambano sparò una raffica di MAB dietro a un càmmion che per suoi motivi non s’era fermato al posto di blocco, e la ghiottornia di quei bossoli lucenti sulla strada, i primi veri dopo i felici tempi della guerra e degli americani, era troppo grossa, e ti scaravoltasti quasi con gli altri monèlo litigando e pugnando per farne su almeno un paio. Di domenica si potrebbe passare più facilmente, perché quel giorno non c’è càmmion ma è piena solo delle cicclo appaiate anche in file di sei-sette, dei contado che vengono in città per ballare o per il cine, dimenticando, si dirà più avanti negli anni con sottile urbano disprezzante humour, attrezzi agricoli e animali di piccola taglia negli spogliatoi e nei cessi.
La Strada è invece l’unità territoriale più intima e identificante, e naturalmente solo quel tratto lì, quello iniziale; già non è più Strada là dove s’incrocia con altre anonime di villini e piante da villino ed anche se è la stessa, nei pressi della Stazione Piccola, quella del trenino a cuccio, che torna indietro a spinta con un vagone di sabióne davanti e uno di dietro, è già località remota, ignota, magari atta a coraggiose esplorazioni tribali. La parallela via del Gambero è altra Strada, ed è infatti abitata dai gamberini, gente temibile perché di origine più duramente proletaria; anche se noi, nei nostri imperiosi proclami, affermiamo con sicumera di non tenerli in nessun conto, come di gente davvero lòfi (e lo scriviamo sui muri, col gesso cucato a scuola, abbasso i gamberini, con quel segno che sembra una W rovesciata, che quella vuol dire viva, l’abbiamo imparato dalle scritte a catrame dei Grandi, quel segno) è meglio, se non in robusta compagnia, evitare di passarci, che si potrebbero anche prendere come minimo delle ṡgiaronate, se non delle tambusate. Noi siamo i cuchiarini, di via Cucchiari, ma non c’entra quello che si adopera per mangiare, e hai anche fatto la figura del caitóne quando, a scuola, al maestro che spiegava come e qualmente in periodo lontano ed oscuro ci fossero vie chiamate col nome degli artigiani che le abitavano, e così c’era via Orefici, via Drappieri, e via Coltelli, ad esempio, tu entusiasta proponesti appunto via Cucchiari, e ti fu ironicamente spiegato, tra cachinni e lazzi di imbecerati compagni, che di Cucchiari sì trattavasi, ma Domenico, Generalissimo di una guerra sconosciuta, la Prima, altra razza e sugo di quella lì appena finita (che è quasi un pecato. Era anche tògo, dai!), la tua guerra, quella Vera.
La Strada è ancora sterrata, l’asfalto di là da venire, fangosa e piena di buche l’inverno, con le tracce scavate in pioggia e seccate in gelo delle molte cicclo e poche auto che la percorrono; piena di polvere l’estate. Hanno piantato, ai bordi, stenti alberelli, confidando che ormai nessuno li segherà più per farci combustibile invernale, come le panchine ridotte ai soli ferri portanti del Parco. Erano bagolari o platani, tigli o ippocastani? Niente. Per la prima volta nella vita sono senza nome, alberini e basta, secchi come tutti in quei giorni, vittime continue di incisioni, scortecciamenti, tentativi cocciuti di sradicamento col sistema astuto e pervicace del filo di ferro (un colpo avanti, uno indietro), cicclo gettate più che appoggiate contro, pisciate di cani e mas’cini; qualcuno ci molla, ma gli altri crescono con grande coraggio e speranza, come tutto, d’altra parte, allora, noi stessi e il mondo attorno in quel primo dopoguerra. Ma se non hanno più nome la cosa non ti preoccupa poi tanto, non te ne addai neanche. Le piante che importano hanno nome, e ben sai come si chiama e dov’è, quel marusticano che si va in branco ad assalire appena dopo che i fiori (già guardati con avida cupidigia) cominciano a legare e le baline verdi dei frutti iniziano a spuntare fra le foglie (nessuno al mondo, ovviamente, conosce il sapore del marusticano maturo), e poi sono l’ultima possibilità per noi mas’cini di esercitare il legittimo diritto di incursione e rapina, di furare frutta, col passare la rete o alzandola di sotto o scavalcandola, e il verbo scavalcare è di grande importanza: si passano giornate a scavalcare cancelli, muri, reti, siepi, fili spinati, tutto ciò che di scavalcabile esiste, sempre nel raggio della Strada, e chi più scavalca e con più agilità più conta, e ha i maróni. Come la rete di quel Campetto superstite, quasi giardino, che misteriosamente impedisce, residuo di antica proprietà privata, l’accesso a via del Gambero che raggiungi solo aggirando il Gruppo Sinigaglia, e che verrà debitamente confiscato e abbattuto per creare la completezza di via Monte Sabotino, che si spinge quasi fino in città, verso lontananze impensabili. Dentro c’è un bimbo ancora piccolo e gnolóne, che corre a chiamare nonni e aìta appena calano i barbari. La rete è tutta imborsata di sotto, piegata di sopra, meta quel filare d’uva che rappresenta un’intera campagna persa e per sempre per molti di noi. Le foglie erano verde pallido, poi azzurre di verderame e piano ingiallivano a segnalare fra i palazzi di quella periferia un ultimo tentativo di indicare il passaggio delle stagioni, lampo di malinconia intuita più che capita, in quell’universo dove le stagioni passavano quasi per sentito dire, o marcate dai terribili ritmi degli impegni scolastici.
Ma non erano furti con destrezza, più che altro erano assalti alla diligenza, o calate vandaliche. Contavano velocità e vedere, rapidi nell’attacco e nella fuga, che si disperdeva vociante al risuonare del grido «Maràia!» di quello che, rimasto appunto a far maràia, ululava alto in caso di pericolo reale o supposto; sostantivo e invocazione, e la maraglia urlante correndo si spargeva per ricomporsi a piccoli gruppi nelle cantine dei palazzi, in qualche giardino, negli anfratti semidiroccati del Gruppo Rionale Fascista Sinigaglia, oggi Casa del Popolo e neo-Florida, dancing. E il marusticano si riempiva improvviso, nelle ore della nòna dell’avanzata primavera, quando tutti s’addormivano dopo i pistóni di lambrusco dell’una, di mas’cini che urlavano a bassa voce la gioia del sacco. Finché la padrona dell’albero, ridotta quasi al gòmito non per il furto in sé ma per l’essere deṡdata cotidie sul più bello del suo spigozare, un giorno afferrò scala e sega e ce ne tagliò un ramo, quello che dava sulla strada, un intero colossale ramo, e ne facemmo crapula, che qualcuno stette anche male e al gòmito ci arrivò davvero, verde in ghigna, pe...