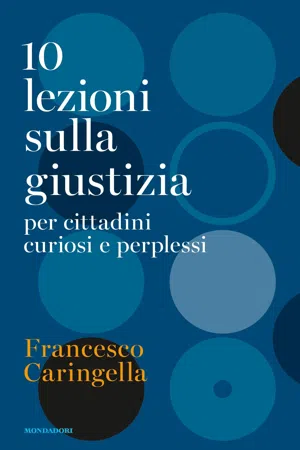Introduzione. La giustizia riguarda tutti
1. È la domanda che dà il titolo al celebre saggio di Hans Kelsen tratto dalla lezione tenuta all’Università di Berkeley il 27 maggio 1952 (trad. it. in Che cos’è la giustizia? Lezioni americane, a cura di P. Di Lucia e L. Passerini Glazel, Macerata, Quodlibet, 2015, pp. 103 sgg.).
2. È il quesito che si pone, con accenti vibranti, papa Francesco nel libro Chi sono io per giudicare?, Milano, Piemme, 2016, in cui evidenzia il pericolo insito nel giudicare e riafferma il primato della misericordia sul giudizio.
3. Ci sono alcune meravigliose pagine di Georges Simenon che, attraverso il suo alter ego, il commissario Maigret, critica la figura del giudice incapace di comprendere l’uomo che si nasconde dietro il delitto. Fra gli altri ricordiamo Maigret si confida (trad. it. Milano, Adelphi, 2007): «Non è colpa sua [del giudice], in realtà. È colpa dell’idea che ha del suo ruolo, e quindi dei suoi doveri. Essendo pagato per tutelare la società, è convinto di doversi mostrare inflessibile nei confronti di tutto ciò che minaccia di turbare l’ordine costituito. Non penso che abbia mai saputo cos’è un dubbio. Divide tranquillamente gli uomini in buoni e cattivi, e neppure concepisce che ci siano vie di mezzo». Oppure Il morto di Maigret (trad. it. Milano, Adelphi, 2000): «La mancanza di senso della realtà del giudice era incredibile! Come poteva un uomo che non aveva mai messo piede in un bistrot … né sul prato di un ippodromo, un uomo che non conosceva neanche una parola di gergo, come poteva pretendere di decifrare l’animo dei criminali?». Insomma, Simenon insiste molto nello stigmatizzare la figura del giudice non in quanto tale, ma quando non cerca di comprendere l’uomo che delinque.
4. Friedrich Nietzsche, Frammenti postumi 1885-1887, trad. it. Milano, Adelphi, 1975, p. 7. Alla lettera, questa affermazione si confuta da sola: poiché le interpretazioni sono interpretazioni di qualcosa di esistente, un’interpretazione può essere interpretazione di un’altra interpretazione, ma all’origine devono esserci dei fatti, altrimenti non esisterebbero nemmeno le interpretazioni. Ma Nietzsche la intende così: «Non esistono fatti puri, ma solo interpretazioni, cioè fatti interpretati dai soggetti umani». Non esiste, cioè, la plena veritas: auctoritas, non veritas facit legem. In questo senso, la sua è una posizione antipositivistica. Per i positivisti, infatti, la conoscenza scientifica, la conoscenza giunta allo stadio positivo, parte da fatti verificabili. Secondo Nietzsche, quando il positivismo afferma che si parte dal fatto e che la conoscenza vera si fonda solo sui fatti, in realtà non si rende conto che il fatto puro non esiste, in quanto il fatto presente alla coscienza dell’uomo è già frutto di un’interpretazione. Altro punto critico: come evitare che la negazione di ogni verità immutabile e oggettiva (in tale negazione è sostanzialmente impegnata quasi tutta la filosofia contemporanea) finisca con il diventare essa stessa, contraddittoriamente, una verità immutabile e oggettiva? Questa, proprio a partire dalla frase di Nietzsche sopra citata, è la preoccupazione fondamentale di Gianni Vattimo nel suo Oltre l’interpretazione, Roma-Bari, Laterza, 1994.
5. Michele Ainis, Se tocca al giudice difendere la lingua italiana, in «la Repubblica», 8 marzo 2017, dove si commentano le vicende relative alla decisione del Politecnico di Milano di tenere corsi di laurea e dottorati di ricerca esclusivamente in inglese e quella della Commissione paritetica Stato - Provincia autonoma di Bolzano di attuare una riforma della toponomastica sudtirolese per cancellare il 60% delle denominazioni geografiche in lingua italiana. Ainis cita alcune sentenze della Corte costituzionale (n. 28/1982 sull’obbligo di usare l’italiano nelle comunicazioni degli uffici pubblici; n. 159/1999, sull’impossibilità che la tutela delle minoranze linguistiche marginalizzi la lingua italiana; n. 42/2017, che, proprio con riguardo al caso del Politecnico di Milano, stabilisce che è lecito impartire corsi in lingua inglese, purché in misura residuale rispetto all’offerta complessiva dei singoli atenei) orientate in direzione della faticosa difesa della «lingua ufficiale dello Stato», difesa che, lungi dall’essere un retaggio del passato, è uno strumento per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell’identità nazionale dell’Italia, sempre più minacciata, da un lato, dalle sirene di un regressivo localismo campanilistico e, dall’altro, da una globalizzazione che abbatte confini e mescola culture.
6. Dai dati di un sondaggio su un campione di 1500 cittadini commissionato dall’associazione Fino a prova contraria e riportati dal «Corriere della Sera» del 27 marzo 2017, emerge un vero e proprio crollo di fiducia: mentre nel 1994, in piena inchiesta «Mani pulite», l’83% dei cittadini promuoveva i giudici e Antonio Di Pietro era l’uomo più popolare d’Italia, oggi 2 italiani su 3 non credono nel sistema giudiziario e 1 su 2 non si fida dei giudici. Quel che è peggio è che il 69% ritiene che settori rilevanti della magistratura perseguano obiettivi politici. Il 42% degli intervistati si dice contrario all’ingresso in politica dei magistrati, mentre il 62% non vede di buon occhio le «porte girevoli», ovvero il rientro nei ranghi dei togati dopo il mandato elettorale.
Lezione prima. Che cos’è la giustizia?
1. Salvatore Satta, Il mistero del processo, Milano, Adelphi, 1994, p. 23.
2. Corrado Augias, Le ultime diciotto ore di Gesù, Torino, Einaudi, 2015.
3. Anatole France, Il procuratore della Giudea, trad. it. di L. Sciascia, Palermo, Sellerio, 1980. Sciascia lo definisce «un apologo e un’apologia dello scetticismo e della tolleranza che ne è figlia, e quindi particolarmente salutare in un momento in cui le certezze sembrano morire e, al tempo stesso, di certezze si muore».
4. Tacito, Annali, trad. it. a cura di Azelia Arici, Torino, UTET, 1983.
5. Samuel S.G. Brandon, Il processo a Gesù, trad. it. di M. Segre, Milano, Edizioni di Comunità, 1974.
6. Nel luglio 2013 l’avvocato keniota Dola Indidis, ex portavoce della magistratura del suo paese, ha fatto ricorso alla Corte internazionale dell’Aja per chiedere l’annullamento della sentenza di condanna di Gesù. A suo giudizio, il verdetto di Ponzio Pilato fu frutto di «un processo selettivo e malevolo» che ha violato il diritto alla difesa. Indidis ha citato in giudizio l’imperatore Tiberio, gli anziani del sinedrio ebraico, re Erode, la Repubblica italiana e lo Stato di Israele. Fra i motivi di ricorso: scorrettezza di giudizio, parzialità e pregiudizio. Per la cronaca, il tribunale dell’Aja si è dichiarato incompetente a prendere in esame il ricorso. Di parere opposto José María Ribas Alba, professore di diritto romano all’Università di Siviglia (Proceso a Jesús: derecho, religión y política en la muerte de Jesús de Nazaret, Córdoba, Almuzara, 2013), secondo cui nel procedimento, nonostante l’intreccio di colpe politiche e religiose, furono sostanzialmente rispettate le norme procedurali del diritto romano vigenti in una provincia occupata.
7. Un esame rigoroso del processo a Gesù è stato condotto, da ultimo, da Aldo Schiavone, Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria, Torino, Einaudi, 2016, che delinea un puntuale ritratto del prefetto di Giudea e ripercorre gli eventi che portarono alla morte di Gesù, culmine della narrazione cristiana e punto d’intersezione fra ricordo evangelico e storia imperiale.
8. Vedi Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie, trad. it. Torino, Einaudi, 2014, p. 3.
9. «Su tre cose si regge il mondo: la giustizia, la verità e la pace.» Così la Mishnah (Avoth 1,18), che commenta: «Le tre cose sono in realtà una sola, la giustizia. Infatti, poiché la giustizia poggia sulla verità, consegue la pace». Sul tema vedi Carlo Maria Martini e Gustavo Zagrebelsky, La domanda di giustizia, Torino, Einaudi, 2003. Nelle pagine finali il cardinale Martini formula cinque esortazioni: 1) lasciarsi inquietare dalle ingiustizie che sono nel mondo, vicine o lontane, ma sempre causa di inaudite sofferenze; 2) non dare mai per scontata una soluzione, come se fosse assolutamente giusta, e sottoporla sempre a critica; 3) diffidare del proprio egoismo, della propria comodità, del proprio punto di vista, e cercare il punto di vista dell’altro; 4) non cedere alle tentazioni del disfattismo (la giustizia è impossibile!), perché in tal caso ogni impegno viene tagliato alla radice; 5) affidarsi al mistero di Dio che regge il mondo («Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi verrà dato in aggiunta», Mt 6,33).
10. Del diritto come meccanismo generalizzato di controllo sociale che serve a evitare i potenziali elementi di conflitto parla Talcott Parsons, La struttura dell’azione sociale, trad. it. Bologna, il Mulino, 1987.
11. Quest’ultima affermazione solo in apparenza contraddice quella della Mishnah citata in precedenza, secondo cui il mondo si regge sulla giustizia. In una prospettiva squisitamente filosofica, infatti, non vi è contrapposizione fra giustizia e ingiustizia, giacché la prima comprende in sé la seconda: l’ingiustizia altro non è che assenza di giustizia, ma la giustizia, essendo l’ingiustizia storicamente dominante, può essere definita solo a partire da quest’ultima. I riferimenti sono da un lato sant’Agostino (il male non esiste perché è, ontologicamente, assenza di bene), dall’altro lato Parmenide (la conoscenza della verità, se non può essere pura, deve tener conto delle sue imperfezioni. Dalle parole di Dike, la dea della giustizia, Parmenide imparerà «come l’esistenza delle apparenze sia necessario ammetta colui che in tutti i sensi tutto indaga»).
12. Il procuratore capo statunitense Robert H. Jackson definì così il significato del giudizio: «Il fatto che quattro grandi potenze, inorgoglite dalla vittoria e lacerate dalle ferite, trattengano la mano dalla vendetta e sottopongano volontariamente i loro nemici al giudizio della legge, è uno dei tributi più significativi che la forza abbia mai pagato alla ragione». Eppure, come ricorda Carlo Nordio, E i nemici dell’uomo finirono alla sbarra, in «Il Messaggero», 1° aprile 2017, non fu confortato da succe...