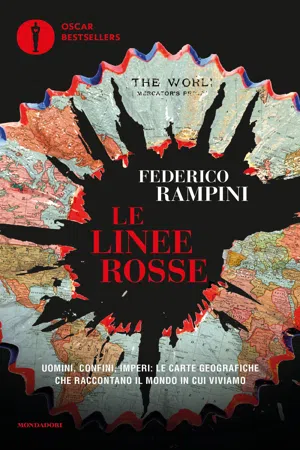Dove vi porto in viaggio con me nell’America profonda dei metalmeccanici che hanno votato Trump; la sinistra ha rinunciato a rappresentarli e loro lo sanno; Nord e Sud degli Stati Uniti continuano a combattere la guerra di secessione 150 anni dopo; in Inghilterra e in Francia la stessa mappa delle recenti elezioni rivela società spaccate tra globalisti e sovranisti; un voto «di classe» esiste, ed è la destra a conquistare i più deboli, meno ingenui di quanto crediamo.
L’America che non lo ha votato l’8 novembre 2016 (cioè la maggioranza, con tre milioni di voti in più a favore di Hillary Clinton a livello nazionale) decreta il fallimento precoce di una presidenza inaudita, grottesca, distruttiva. Lui tira avanti come nulla fosse, allergico ai fatti, continuando a vantare una «realtà alternativa». Si muove come fosse sempre in campagna elettorale, da comiziante e showman più che da statista. Forse perché la memoria della campagna lo rassicura: anche allora sondaggi e media lo davano per spacciato. A salvarlo dalla sconfitta, quell’8 novembre, ci fu – metafora della teoria del caos – un battito d’ala di farfalla che, amplificandosi a dismisura, si trasformò in uragano su scala nazionale e mondiale. Il battito quasi impercettibile fu lo spostamento di poche centinaia di migliaia di elettori (su 136 milioni di votanti!). Perlopiù operai bianchi, e le loro mogli. Alcuni di loro avevano votato Obama una o due volte, ma nel 2016 hanno scelto l’outsider, il magnate che prometteva sfracelli contro l’establishment. Quel minuscolo spostamento ha precipitato l’America e il mondo in una storia senza precedenti. È a quegli operai che Trump dedicò il 20 gennaio 2017 il suo discorso all’Inauguration Day a Washington: il discorso più «dark» di tutte le inaugurazioni presidenziali, una visione tragica dello stato del paese, la promessa di una rivincita improntata al nazionalismo.
Per capire a che punto siamo davvero, bisogna tornare nell’epicentro del sisma. Tra i metalmeccanici di Detroit, dove tutto è cominciato. Sono andato a sentire la loro versione su questo presidente. È da loro che bisogna ripartire anche per tracciare la linea rossa che separa le due Americhe: sovranisti contro globalisti, ceti popolari contro élite, provincia profonda contro zone costiere cosmopolite. Gli operai a cui do la parola per questa lezione di geografia del voto vivono nell’America di mezzo, quella che con un termine spregiativo viene definita come «fly-over country», perché le élite delle due coste preferiscono sorvolarla senza atterrare, osservarla distrattamente dall’alto senza mischiarsi nei suoi pensieri. Solo ogni quattro anni, almeno noi giornalisti siamo finalmente obbligati a immergerci lì dentro, per le primarie presidenziali: e ne vediamo di tutti i colori. Poi ricorderò che dietro il fenomeno Trump c’è un’altra lettura necessaria, il Sud contro il Nord, una mappatura alternativa che esplorerò più avanti. Alla fine, questa geografia elettorale la ritroveremo, molto simile, anche nella vecchia Europa.
Bisogna arrendersi all’evidenza, la geografia è diventata anche una scienza politica. In alcune delle più antiche e solide liberaldemocrazie occidentali, «dove abiti» è diventato quasi un sinonimo di «come voti». È come se la popolazione di intere nazioni scegliesse di aggregarsi localmente seguendo logiche valoriali: in America, o in Inghilterra, o in Francia, tendiamo a vivere vicino a quelli che la pensano come noi. Le mappe elettorali che hanno sancito le vittorie di Trump, Brexit, Macron seguono una logica topografica, hanno agglomerazioni omogenee, confini precisi. La geografia s’intreccia con la condizione socio-economica, la professione e il reddito, il livello d’istruzione; si traduce in scelte di campo sull’immigrazione e la globalizzazione. Come quelle degli operai di Detroit. Sia chiaro, alcuni di loro, col passare del tempo, avranno pure cambiato parere su Trump, delusi dalle troppe promesse mancate; io ho fotografato con loro la situazione all’inizio della sua presidenza. È rilevante comunque, perché da un lato spiega come è stato eletto, dall’altro evidenzia la nuova geografia del voto, la linea rossa che separa le élite progressiste dai ceti popolari, l’abisso valoriale che si è scavato tra loro.
«Vediamoci, parliamo pure, a condizione che l’articolo sia oggettivo. Voi giornalisti non dite la verità su Donald Trump. Lo abbiamo eletto noi operai, e lui ci sta aiutando. Eccome. È uno che fa quello che dice, vuol mantenere davvero le promesse, non è un politico. Ha già convinto la Ford a tenere qui una fabbrica che doveva finire in Messico. Contro l’immigrazione clandestina, contro la concorrenza sleale della Cina, sulla deregulation e sull’attacco alla burocrazia, il nostro presidente sta facendo un gran lavoro. Crede nelle forze armate, e ha ragione. Se non tutte le riforme gli riescono, la colpa è dei parlamentari fannulloni, è dell’opposizione che lo boicotta. Oggi voi giornalisti liberal lo prendete in giro come un tempo sfottevate Ronald Reagan: uno dei più grandi presidenti della storia. Un giorno dovrete ricredervi anche su Trump.»
Così parla un uomo a cui il presidente deve molto. Brian Pannebecker, 57 anni, per vent’anni operaio alla Ford, da 19 anni alla Chrysler (oggi Fca-Fiat Chrysler Automobiles). Mansione attuale: manovratore di carrello elevatore. Lo incontro con due suoi amici e compagni di lavoro, Bill Dulchavsky e Frank Pitcher, in un «diner», americanissima istituzione dove si mangia tanto e si spende poco. Un ritrovo per «redneck» (colli rossi), come molti decenni fa l’intellighenzia liberal cominciò a etichettare, spregiativamente, quei maschi bianchi abbronzati dal lavoro manuale all’aria aperta; nomignolo che riassume una lunga serie di pregiudizi contro un proletariato bianco scivolato a destra, accusato di essere razzista e oscurantista, omofobo e islamofobo. I metalmeccanici di Trump, insomma. Se non fosse per Brian, Bill, Frank e quelli come loro, oggi alla Casa Bianca ci sarebbe Hillary Clinton.
Immergersi in mezzo a loro può essere uno shock. Gli irriducibili della rivolta operaia contro la sinistra élitaria si aggrappano al loro presidente. Di certo c’è qualche lezione che il Partito democratico farebbe bene ad apprendere, se vuole preparare la sua rivincita.
Il ristorante del nostro appuntamento si chiama LA Coney Island, e si trova al numero 39485 di Mound Road. Una superstrada come tante nell’America profonda, un rettifilo a perdita d’occhio, percorsa dai Tir, tra capannoni industriali e shopping mall «poveri», catene discount, fast-food. Siamo alla periferia di Sterling Heights, 35 chilometri a nord di Detroit. Qui batte il cuore del Michigan industriale, uno dei cinque Stati che furono decisivi per portare Trump alla Casa Bianca. E decisivi lo sono stati questi operai che incontro due ore prima che inizi il turno pomeridiano, quello delle 14. Sull’altro lato della superstrada c’è lo stabilimento Ford Sterling che assembla alberi motore; poco distante, una fabbrica Fiat Chrysler. La cittadina di Sterling Heights (130.000 abitanti) e i suoi sobborghi operai appartengono alla contea di Macomb. In questa circoscrizione elettorale Trump vinse con un margine schiacciante: 54 per cento di voti, contro il 42 di Hillary Clinton. Nel 2012, invece, qui aveva vinto Barack Obama, sia pure di stretta misura (il 51,6 per cento contro il 47,6 di Mitt Romney). Tutto il Michigan ha seguito l’esempio di Macomb County, passando in quattro anni da «obamiano» a «trumpiano». Contro le direttive del sindacato: la confederazione dei metalmeccanici United Auto Workers (Uaw) è da sempre allineata col Partito democratico; i suoi leader avevano dato indicazione di voto per Hillary. Una buona parte della base ha fatto di testa sua, ignorando i capi sindacali. Questa non è una novità per Brian. Lui è un ribelle che rifiuta di pagare l’iscrizione semiobbligatoria alle Union («i leader sindacali fanno i loro interessi, non i nostri, e il tesseramento lo hanno trasformato in una tassa»). Discendente di immigrati dal Belgio, fiero dei quattro anni in cui servì la US Army, Pannebecker si presenta all’appuntamento indossando la sua maglietta elettorale Trump-Pence, e si fa fotografare dietro al suo Suv Ford Escape dove spicca l’adesivo trumpiano.
Per i due suoi compagni la conversione a destra è stata recente. Dulchavsky, 54 anni, single con un figlio, barba e capello lungo. Anche lui ha lavorato alla Ford e ora alla Fiat Chrysler. Pitcher, occhi azzurri e un’aria da ragazzino, lo sguardo sognatore, un fisico da country music, si presenta in tuta da lavoro della Ford. È il «sindacalizzato» dei tre. «Sono grato alla mia Union» dice Frank «perché i sindacalisti hanno sempre difeso i miei diritti. E soprattutto voglio che ci sia una Union per i giovani che verranno dopo di me.» Anche lui ha votato Trump, però. Ordiniamo la specialità della casa, omelette con tre uova, prosciutto e formaggio fuso. Frank aggiunge un «extra» di bacon fritto. Sulle pareti ci sono fotografie di auto modello Nascar, la competizione che è una passione tipicamente redneck, condivisa da Trump. Ci raggiungeranno qui anche degli italoamericani, che gravitano sempre sulla capitale dell’industria automobilistica. Tutti elettori di Trump. È questa l’America di cui bisogna sondare i pensieri profondi, le emozioni e le paure, per capire com’è stato possibile ritrovarsi Trump alla Casa Bianca.
Da quando esistono le indagini demoscopiche, mai nessun presidente si era trovato così in basso al suo esordio, sempre sotto il 40 per cento di consensi nel suo primo anno. Brian insiste a dare la colpa a noi: «Non abbiamo dei media oggettivi, equilibrati. Voi giornalisti non dite la verità su quello che sta accadendo. Il Partito democratico fa ostruzionismo su ogni proposta del presidente e se ne vanta pure, fiero di potergli rinfacciare che lui non riesce a fare nulla. L’altro grande colpevole è il Congresso, repubblicani inclusi. Sono molto deluso, ad esempio, dall’insuccesso nell’abrogare la riforma sanitaria di Obama. È da sette anni che i repubblicani vogliono cancellare l’Obamacare per sostituirlo con un sistema meno oneroso, una sanità non statalista, che non imponga pesanti obblighi agli americani. Se non ci sono riusciti ora, è perché i parlamentari sono degli incapaci. Ma il presidente non c’entra. Lasciatelo lavorare!».
Gli stessi sondaggi negativi confermano al loro interno il «fenomeno Brian»: ci dicono infatti che rimane fedele a Trump proprio il nocciolo duro della sua base, in particolare l’America operaia. In generale chi ha votato per lui è molto restio a cambiare giudizio: un sondaggio nazionale dell’estate 2017 (realizzato quando già la sua amministrazione aveva accumulato scandali e sconfitte) rivela che il 60 per cento dei suoi elettori «non lo abbandonerà mai», e questa percentuale di irriducibili sale al 72 per cento tra le donne che lo hanno votato.
Di concreto cos’ha offerto Trump a questo zoccolo duro? Lui ha provato a sfoggiare un suo attivismo esecutivo e in certi casi c’è riuscito: gli sono bastati dei decreti presidenziali per smantellare l’eredità di Obama sull’ambiente (autorizza oleodotti e trivellazioni, abolisce restrizioni all’inquinamento di automobili e centrali elettriche, taglia fondi alla ricerca, azzoppa l’authority ambientale). È andato a fare comizi immergendosi nella sua base operaia, da Detroit fino al Wisconsin. «Ho firmato un ordine esecutivo Buy American, Hire American (compra americano, assumi americani). È un’azione storica.» Prevale l’effetto-annuncio, le conseguenze pratiche le vedremo col tempo. Cerca di cambiare qualche regola negli appalti pubblici, onde garantire che le imprese appaltatrici usino solo materiali made in Usa (acciaio). Sulle assunzioni ha annunciato un giro di vite contro certi visti (H1-B) con cui le aziende digitali della Silicon Valley assumono informatici cinesi e indiani, italiani e francesi. Per l’industria dell’auto la novità concreta e immediata è proprio il «liberi tutti» sulle norme ambientali: stracciando di fatto gli accordi di Parigi sul cambiamento climatico, cancellando i limiti di Obama alle emissioni carboniche, autorizzando la produzione di modelli più inquinanti, Trump alleggerisce i costi di produzione.
Come qui nel Michigan, in tutta la Rust Belt americana (la «cintura della ruggine» che descrive le zone di vecchia industrializzazione) lo spostamento della classe operaia a destra è stato reale. Nel vicino Ohio, altro Stato cruciale per l’elezione di Trump, il dirigente locale del sindacato Uaw, Tim O’Hara, stima che «dal 40 al 50 per cento degli iscritti hanno votato Trump ignorando le direttive dei leader». E accusa i democratici di aver perso contatto con una base impoverita e declassata, un ceto sociale dove «un salario operaio che era di 80.000 dollari [annui lordi] e ti consentiva di mantenere una famiglia, in pochi anni è sceso a 35.000».
Per capire quel che è successo, per spiegare quella frana dei salari, l’epicentro della storia è Detroit e il suo hinterland, dove si concentra la massima parte della produzione automobilistica delle tre marche storiche: Ford, General Motors e Fiat Chrysler Automobiles. L’ultima crisi dell’auto made in Usa ha inizio dieci anni fa, nel 2007. L’anno seguente arriva lo shock della grande recessione e a seguire le bancarotte di Gm e Chrysler. Quel disastro non è completamente riassorbito neanche dopo otto anni di crescita economica. Detroit ha subìto uno spopolamento unico nella storia per dimensioni: dai massimi di due milioni di abitanti la città è scesa a 700.000, riducendosi a un terzo di ciò che era. Perfino per quell’America abituata in passato a una notevole mobilità geografica, la fuga in massa da questa città senza lavoro assume proporzioni inaudite. Ancora oggi interi quartieri restano pressoché disabitati, ridotti a fantasmi; malgrado gli esperimenti originali come «l’agricoltura in città», le zone degradate soffrono per la criminalità violenta. Il Comune ha fatto bancarotta e impone un’austerity feroce con tagli drastici a tutti i servizi pubblici (nei quartieri con pochi abitanti è stata interrotta perfino l’erogazione di acqua e luce).
Con la ripresa economica e il boom delle vendite di auto c’è un’inversione di tendenza, ma siamo ancora in un’area depressa. E il grosso del risanamento dei bilanci aziendali è avvenuto proprio a spese dei salari operai. La portavoce di Fiat Chrysler a Detroit, Jodi Tinson, mi riassume quell’accordo sindacale che già nel 2007 consentì di ridurre il costo del lavoro creando due livelli: «Gli operai assunti prima di dieci anni fa, con salario di 29 dollari l’ora; quelli assunti dopo, con salario di 17 dollari». Aggiunge che il nuovo contratto firmato nel 2015 prevede per i neoassunti un percorso graduale di avvicinamento al salario «pieno», ma in otto anni. Brian Pannebecker traduce così l’impatto all’interno della sua fabbrica: «Abbiamo un 20 per cento di colleghi che guadagnano dieci dollari in meno di me per ogni ora lavorata». La media di tutti gli stabilimenti Fiat Chrysler che mi fornisce la portavoce è più squilibrata verso i nuovi assunti: il 47 per cento del totale rientra nel regime salariale più basso.
All’impoverimento economico si è aggiunta una marginalizzazione che forse pesa perfino di più: quella culturale, valoriale, razziale, da parte della sinistra. Tutto ciò che appartiene al mondo dei redneck è diventato spregevole per un’élite globalista, multietnica, laicista. Lo stesso Obama fu colto in flagrante snobismo quando in una riunione a porte chiuse con ricchi finanziatori di San Francisco confidò questa sua descrizione degli operai del Midwest: «Diventano amari, si aggrappano alle loro armi, alla loro birra, alla loro Bibbia, all’ostilità verso gli immigrati o il libero commercio». Un quadretto abbastanza realistico, ma anche sprezzante. E un linguaggio così esplicito, così duro, non verrebbe usato dalla sinistra verso altre categorie di elettori. Lo stesso Obama avrebbe osato ironizzare su quelli che si aggrappano al loro Corano? Sicuramente no. Gli imam vanno rispettati anche se predicano regole più oscurantiste e retrograde degli evangelici di destra; no, criticare i musulmani non è politically correct. Con la campagna elettorale di Hillary nel 2016 divenne ancora più marcato l’appello ai diritti di tutte le minoranze: gay, lesbiche, transgender, neri, ispanici, islamici, più ovviamente le donne, che avrebbero finalmente polverizzato il metaforico soffitto di vetro, la barriera invisibile all’emancipazione femminile. Tutti avevano qualcosa da guadagnare se vinceva lei, tutti eccetto «loro». Quelli come Brian, Bill e Frank.
È un fenomeno sul quale ha riflettuto lo storico Walter Russell Mead, secondo il quale «molti americani bianchi si trovano in una società che parla costantemente dell’importanza delle identità, che valorizza l’autenticità etnica, che offre aiuti economici e sostegni sociali sulla base dell’identità; per tutti fuorché per loro. Nel corso della campagna elettorale del 2016, tutto quel parlare di un’emergente maggioranza democratica basata sul declino secolare dei bianchi venne percepito come un progetto deliberato per trasformare la composizione dell’America. Hanno visto l’immigrazione come parte di un tentativo determinato e consapevole per marginalizzarli nel loro stesso paese». Un’indagine condotta dal «Washington Post» e dalla Kaiser Family Foundation rivela che, tra coloro che appoggiano Trump, il 46 per cento mette al primo posto tra le preoccupazioni il fatto che i bianchi stanno «perdendo».
Un best seller del 2017 s’intitola proprio Strangers In Their Own Land (The New Press), «estranei nel loro stesso paese». Con una forzatura linguistica si potrebbe anche tradurre con «stranieri in patria». L’autrice, la sociologa Arlie Russell Hochschild, esplora la frustrazione, il risentimento, il rancore che covano nell’elettorato popolare (la sua inchiesta si concentra geograficamente più a sud, in Louisiana). Nelle sue interviste ricorre un’immagine metaforica. La condizione in cui versa il paese viene rappresentata – anzi vissuta nella «deep story», la narrazione profonda che ciascuno si crea – come una fila sempre più lunga di masse che aspirano all’American Dream. Traguardo ambito, ma un tempo accessibile: un modesto benessere per tutti, la proprietà della casa, sicurezza economica, opportunità per i figli. E mentre la fila d’ingresso al Sogno americano si allunga, e avanza sempre più lentamente o sta quasi immobile, ci sono categorie appena arrivate che passano davanti a tutti, si avvalgono di aiuti per le minoranze, sorpassano i bianchi poveri a cui nessuno presta attenzione. Donne, neri, ispanici, profughi, ciascuno ha diritto a «quote», agevolazioni, «affirmative action» per promuoverne l’ascesa.
Frank Pitcher, l’operaio con la tuta della Ford, allude a qualcosa di simile parlando della condizione degli afroamericani a Detroit e dintorni. «Negli anni Sessanta» mi dice «qui ci furono scontri razziali violenti. Poi negli anni Settanta le cose migliorarono molto, e tanti operai neri entrarono a lavorare in fabbrica insieme a noi. Adesso invece abbiamo generazioni che pensano solo di avere dei diritti da rivendicare. Siamo diventati una nazione di diritti acquisiti.» Approva e rincara la dose Bill Dulchavsky: «Più gli dai e più chiedono; più si aspettano, più esigono dal Welfare».
Lo storico Mead, che traccia un parallelo fra il populismo di Trump e quello di Andrew Jackson (settimo presidente degli Stati Uniti, fondatore del Partito democratico), è convinto che molti operai bianchi sentono che «Trump sta inequivocabilmente dalla loro parte, le élite no».
A conferma che oggi loro si sentono i veri perdenti, c’è la droga in fabbrica. Nella nostra conversazione al diner sollevo questo problema dopo aver letto tante denunce di medici sui giornali: le nuove droghe che uccidono negli ultimi anni sono potenti antidolorifici a base di oppioidi, come l’Oxycontin. E le nuove vittime sono loro: operai bianchi di mezza età. Colpisce il fatto che Trump se ne sia occupato quasi subito: tra gli ordini presidenziali firmati nei primi cento giorni c’è stata la creazione di una «Commissione per combattere la crisi degli oppioidi».
«Cominciò anni fa» racconta Brian «quando qualcuno, lavorando in fabbrica, soffriva di artrite e i medici gli prescrivevano l’Oxycontin. Le ricette hanno cominciato a circolare, qualcuno se le rivendeva. Nel mio stabilimento, decine di uomini della mia età sono diventati tossicodipendenti in questo modo, a poco a poco. E naturalmente questo peggiorava i loro problemi economici, finivano per spendere centinaia di dollari al mese per procurarsi quelle medicine. Non abbiamo avuto un’ecatombe paragonabile alle zone più pove...