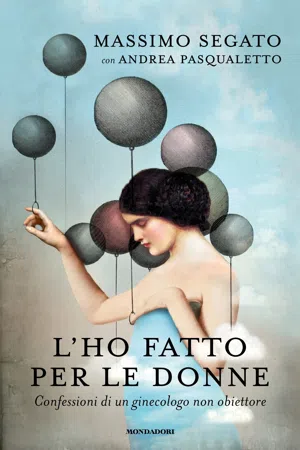Caterina aveva gli occhi stanchi, struccati e lucidi. Venne nel mio studio con un uomo nel gennaio 1983, di fresca mattina. Era una visita prenotata in reparto una settimana prima.
Si sedettero di fronte a me. Dovevano avere entrambi una quarantina d’anni. Lei teneva in mano una cartellina di cartone dove c’era scritto in obliquo «Paolo», sottolineato due volte.
«Questo è mio marito» disse presentandomi l’uomo in giacca e cravatta che era con lei.
Gli strinsi la mano e lo osservai per capire il motivo della sua presenza.
Caterina indossava una camicia elegante, larga, leggermente sbottonata. Non riuscivo a capire se era incinta, ma gli occhi, lo sguardo, lo smarrimento erano quelli. Peggio, erano quelli di una donna che ha in grembo un bambino indesiderato. E lui era certamente il padre. Qualcosa però non tornava.
Caterina aprì la cartellina bianca e mi mostrò un’ecografia.
«Questo è il nostro Paolo» e non aggiunse altro.
Guardai le immagini e sospirai. Della testa si vedevano gli occhi del bambino e poi poco altro. Mancava la calotta cranica.
«Sospetta anencefalia» aveva scritto il medico a referto dell’ecografia.
Si trattava di un caso di «testa a ranocchio», tutto occhi, senza il cervello. Quel bambino non sarebbe sopravvissuto.
Caterina era al quarto mese di gravidanza, ma avrebbe potuto comunque abortire perché si trattava di uno di quei casi contemplati dalla legge in deroga al limite del novantesimo giorno: «L’interruzione volontaria dopo i primi novanta giorni è consentita quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o quando siano accertati rilevanti malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna».
Dunque bisognava valutare l’interruzione.
«Dottore, vorremmo una conferma che davvero Paolo è così.»
Gli avevano già dato un nome e questo era significativo di quanto tenessero al bambino sebbene avessero già quattro figli.
«Certo, facciamo subito un’ecografia di conferma» dissi io pur sapendo che non c’erano speranze.
Mi alzai e invitai la donna a sdraiarsi sul lettino.
«Se vuole può rimanere» mi rivolsi al marito che annuì.
L’uomo si era messo in piedi in modo da vedere bene il monitor dell’ecografo.
Dopo aver pulito e disinfettato lo strumento, misi il gel sulla pancia di Caterina e iniziai a far scorrere la sonda sulla sua pelle bianca.
«Non si muove da un po’» sussurrò lei.
Misi a fuoco la testa del feto. Passai e ripassai la sonda. Caterina non aveva il coraggio di guardare le immagini. Quegli attimi devono esserle sembrati un’eternità. Guardava il marito che aveva iniziato a scuotere la testa senza mascherare il suo dispiacere.
Indugiai ancora su quel corpicino che per il resto era normale.
«Ok, può pulirsi» dissi a Caterina allungandole dei fazzoletti di carta.
Tornai a sedermi e li aspettai. I volti erano tristi, nello studio era piombato un grande silenzio. Si sedettero.
«Confermato» aggiunsi senza tanti giri di parole guardando Caterina.
Lei strinse le labbra e gli occhi le si riempirono di lacrime.
«L’abbiamo chiamato Paolo come l’apostolo» sussurrò asciugandosi con un fazzoletto il viso. Sarà l’ennesimo pianto da quando hanno scoperto la malformazione, pensai io. Ma continuava a esserci in lei qualcosa che mi sfuggiva. A partire dal nome già dato al figlio. Non un nome a caso.
«Paolo diceva che la grazia di Dio va oltre l’intelligenza umana, che la carne, qualsiasi carne è un soffio di Dio» spiegò Caterina. «Ma questa cosa che ci è capitata è talmente grande che io…»
Erano profondamente credenti.
Quando mi trovavo di fronte a simili drammi sapevo che poteva esserci un problema di scelte, soprattutto se la mamma aveva una fede religiosa. Cercai le parole giuste, sicuro di non trovarle. Non ero abile in queste cose.
«Purtroppo ve lo devo dire: questo bambino non ha speranze di sopravvivenza» mormorai.
Lo sapevano. Dopo la prima ecografia si erano informati e quel nome, Paolo, era stato meditato quando avevano capito che il loro figlio aveva una malformazione encefalica.
«Può morire durante la gravidanza o subito dopo il parto» aggiunsi, guardando la madre. «Se muore nel corso della gravidanza, potrebbero subentrare delle complicanze per la sua salute.»
Ascoltavano in silenzio.
«Lei cosa ci consiglia?» chiese il marito, aprendo per la prima volta la bocca da quando era entrato nel mio studio.
«Io consiglio l’interruzione» dissi senza tergiversare.
«Interruzione terapeutica?»
«Sì, parto vaginale indotto tramite candelette di prostaglandine. Facciamo un po’ di anestesia, ma lei sarà cosciente in tutte le fasi dell’espulsione. Però non sentirà alcun dolore. Dopo il parto, se la placenta non è uscita del tutto è possibile che si faccia un raschiamento. Ricovero il giorno prima e dimissione il giorno dopo.»
Caterina scosse la testa con gli occhi sempre più tristi. Si guardarono fra loro ed era come se si fossero parlati.
«Paolo è sano, mi sembra. Voglio dire, il resto è sano o no?» chiese Caterina.
«Pare di sì» risposi.
«Lo teniamo» concluse lei con un tono sicuro, come se non avesse mai avuto dubbi. Aveva voluto capire cosa succede in questi casi senza però mai prendere in considerazione l’ipotesi dell’aborto.
Mi aveva spiazzato. Ero certo che avrebbero deciso per l’intervento, visti i rischi. Ma non avevo fatto i conti con la loro fede che doveva avere radici d’acciaio.
«Lei rischia la vita, questo lo devo sottolineare» aggiunsi.
Il marito la guardò aspettando una sua risposta.
«È più importante quella di mio figlio» disse Caterina.
Avrei voluto ribattere che quella di suo figlio non era una vita piena. Ma qui si entrava in una questione nella quale non avevo diritto di accesso. Mi sorprendeva la posizione del marito che non diceva alcunché, contrariamente a quello che fanno in questi casi gli uomini. Come quello del Borgo Roma, che scelse senza esitazioni la vita della moglie.
L’uomo silenzioso in giacca e cravatta era d’accordo con lei. Era disposto a perdere entrambi, la moglie e il figlio. Una fede rocciosa e sorprendente.
«La Provvidenza non ha limiti» sancì lei. «E se il miracolo non ci sarà e se gli organi di Paolo saranno sani, potremmo donarli…»
C’era poco da discutere davanti a tanta determinazione.
«Come volete» conclusi.
Mi chiesero se potevo seguire la gravidanza di Caterina, se potevano appoggiarsi a me fino al parto. Avrei fatto dei controlli per verificare che il bambino fosse vivo e avrei accompagnato la madre nei cinque mesi di gestazione che rimanevano.
Nonostante la diversità di vedute, la coraggiosa scelta di tenere il bambino mi aveva avvicinato a Caterina e volevo aiutarla.
Tornò dopo due mesi e la vidi più serena. La strada era stata intrapresa e una nuova consapevolezza le aveva dato evidentemente un po’ di pace.
«Io spero sempre, dottore. Ho Dio, ho Gesù, ho Maria, ho Paolo. Sento che sta crescendo. Sento i calci, sento le capriole» e mi sorrise, sempre con quegli occhi struccati e umidi che mi riempivano il cuore.
In effetti il bambino cresceva nella norma, le mani, i piedi, le braccia, le gambe. Anche la dimensione e il peso erano normali. Solo la testa era senza speranza.
Ci vedemmo un’altra volta. Non erano subentrate complicazioni.
«Penso che la gravidanza si chiuderà senza sorprese» le dissi.
Almeno una vita era salva: la sua.
Mi guardò sorridendo. Sembrava felice. Si stava preparando al parto che, escludendo complicazioni dell’ultima ora, sarebbe dovuto avvenire un mese dopo.
E così andò.
Non venne da noi, a partorire. Me l’aveva detto. Andò all’ospedale di Padova perché lì poteva contare sull’aiuto di alcuni parenti e amici.
Aveva preparato tutti. E aveva preparato anche se stessa.
«La informerò, dottore» mi salutò.
Ma il giorno dopo il parto non mi chiamò e neppure nei giorni successivi.
No, non poteva finire così quella grande storia.
Passato più o meno un mese, mi arrivò un messaggio. A portarmelo fu un’infermiera del reparto: «Dottore, ha chiamato una certa Caterina. Ha chiesto di dirle che presto le farà sapere. Non ha aggiunto altro».
Non mi era mai capitato un caso del genere. Eravamo di fronte a un bambino che non aveva alcuna possibilità di sopravvivenza e a una madre che aveva voluto tenerlo rischiando di morire, anche se questa probabilità non era alta. Caterina l’aveva fatto perché sperava nel miracolo, nella Provvidenza, perché voleva che fosse Dio a decidere, fino all’ultimo respiro. Dio, la natura, il mistero della vita. Per me non c’era, invece, alcun mistero. Era tutto già scritto: quel bambino non poteva vivere e, se anche fosse nato, sarebbe stato un vegetale destinato a morte rapida. Non avrebbe visto il mondo, non lo avrebbe goduto. Avrebbe solo inutilmente sofferto. Ma mi rendo conto che la mia posizione era dettata da un approccio diverso, più scientifico, se vogliamo materialista. Quella di Caterina e di suo marito era invece religiosa.
Li rispettavo, li ammiravo, li invidiavo per la loro fede. Ma non li capivo sino in fondo. Evidentemente mi mancava Dio, e questa era la nostra distanza.
La fede dettava talvolta comportamenti estremi. Ricordo la battaglia che fece un ventottenne vicentino contro la decisione di abortire della sua fidanzata, Chiara, di quattro anni più giovane. Battaglia che esplose una mattina d’inverno del 1985.
«Questo è un delitto! Dio ti punirà!» urlava in reparto mentre gli infermieri cercavano di allontanarlo dalla stanza dove era ricoverata la ragazza, in attesa dell’intervento di interruzione.
Lui era il padre del bambino e, animato da un profondo spirito religioso, non si era rassegnato alla scelta della fidanzata di abortire. Il giorno dell’intervento aveva così tentato il tutto per tutto, cercando di convincerla a rinunciare fin sulla soglia della sala operatoria. Ma Chiara era ferma nella sua decisione. Il confronto fra i due si era trasformato in uno scontro ed erano dovuti intervenire gli operatori sanitari.
«Assassini!» urlava il giovane mentre lo accompagnavano all’esterno. Era furioso. Ci fu un gran trambusto perché lui cercava di rientrare in reparto, divincolandosi da chi lo tratteneva. Fino a che la segreteria chiamò i carabinieri. Quando capì che stava arrivando una Gazzella dell’Arma per portarlo in caserma, desistette e se ne andò.
Poveretto, deve essere stata una grande sofferenza. E lo è stata a maggior ragione per Chiara, che ha dovuto subire una simile aggressione proprio nel giorno dell’intervento. Situazione terribile. Da una parte le urla del fidanzato che la insultava, dall’altra la sala operatoria che l’attendeva per il raschiamento.
«Quanto manca, dottore?» mi chiese agitata.
«Poco, stai tranquilla che è tutto risolto» risposi.
L’intervento fu eseguito e la gravidanza interrotta.
Ebbi modo poi di parlare con lei del suo rapporto con il fidanzato.
«L’ho lasciato» mi raccontò. «Era diventato impossibile…»
La storia del fidanzato di Chiara è estrema, ma significativa di un fatto: l’aborto non è solo una questione da donne. Esiste anche l’altra metà del cielo e bisogna sempre tenerne conto. Anche se spesso il marito o il fidanzato o il compagn...