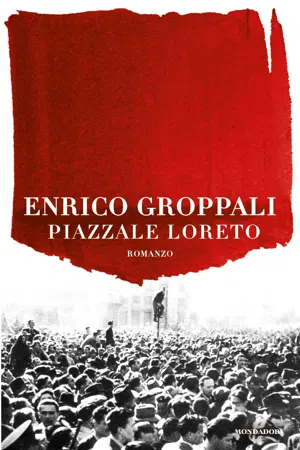Quando moriremo porteremo con noi un’immagine del cielo. Anche se mi hanno detto che non ricorderemo altro che delle nuvole nere battute dal vento. Ma adesso lascia che ti racconti come è andata.
La luce era alta quel giorno di aprile. Sembrava incendiare l’orizzonte da un capo all’altro a dispetto del sole che brillava a intermittenza, come se temesse un’insidia e controllasse atterrito la minaccia che stava per incombere.
Io non conoscevo l’uomo che mi parlava al di là del muro urlando oscenità nei miei confronti, ma la contiguità della sua stanza con la mia non mi lasciava scampo. Ero costretta a subire i suoi soliloqui persino quando mi precipitavo fuori per le vie inondate dalla primavera.
Le sue parole mi perseguitavano come se il mio passo esitante ripetesse incessante quella voce scura e volgare. Tipica di chi scambia il giorno con la notte e, bevendo, trasuda un dolore che mai riuscirà a placare.
Ho fatto di tutto per non sentire più quei toni rauchi da bestia ferita che aspetta solo il momento buono per lasciare la sua tana e avventarsi su di me, l’inquilina che gli abita accanto.
Un muro più bianco dei marmi candidi di un ospedale continua a rimandarmi l’eco spaventosa del suo respiro. Anche quando cammino, persino quando mi avventuro in centro o vago disperata ai margini della periferia.
È come un vecchio refrain a cui affidare una confessione o, peggio ancora, una condanna a morte. Ma io della morte non ho mai avuto paura, nemmeno da bambina. Perché sapevo che la vita eterna non esiste.
Al suo posto, gli uomini hanno inventato gli dei e i santi che raggiungeremo dopo morti. Sempre che ci piaccia credere alle bellissime favole del paradiso cinto di fiori e dell’inferno solcato dalle fiamme eterne.
Però io non sopporto i gemiti che emette quest’uomo. Non tollero più il suo fiato ansante che si spezza nell’urlo. Ho pensato spesso di liberarmi di questo scomodo testimone per vivere in pace il poco tempo che mi resta.
Infatti chi può dirmi se non sono già diventata una malata terminale fatta di carne putrida che erutta sangue prima di consegnarmi alla tomba dove finalmente troverò la pace?
Oddio, quasi me ne dimenticavo. Non posso più parlare con quella simpatica zitella che mi ha affittato questo tugurio perché da tempo, da molto tempo se n’è andata. Sulla porta c’è ancora la lucida targhetta con stampato il suo nome:
CONTESSA D’AULNOY, SCRITTRICE PER L’INFANZIA.
Chissà se è vero. Ma in fondo a chi importa appurarlo? Di certo a nessuno. Così mi rintano nella mia stanza. Dove chiunque può entrare a strangolarmi, se crede. Poiché il catenaccio è stato divelto tanto tempo fa. Come pure la serratura del portone di strada.
È stata strappata lasciando al suo posto un tondo che pare un occhio rimasto privo delle palpebre. Ma non divaghiamo. Sono serena, adesso che non so più come mi chiamo né come sono stata chiamata da chi mi ha conosciuta in passato.
Il fatto di avere smarrito qualsiasi identità come un pacchetto dimenticato per distrazione nell’atrio di una stazione deserta non mi sgomenta. Anzi, mi dà un senso incredibile di pace. È così noioso dover dare ragguagli su se stessi.
Meglio vegetare come una carcassa aspettando gli eventi, scongiurando la nausea nella pace ovattata delle lenzuola col mio gruzzolo fatto di pochi spiccioli, ma di tanti gioielli, che ho nascosto in uno scrigno che giace ai miei piedi, al posto dello scaldino.
Se adesso qualcuno mi vedesse, farebbe un balzo indietro. Si ha paura di un corpo che vive nell’inedia come un animale braccato, non è vero? Comunque sia, il fatto che ci si possa impadronire di una carcassa come la mia mi lascia del tutto indifferente.
Prima che quest’uomo mi torturasse col suo passo cadenzato, ho pensato spesso di ricorrere alla forza pubblica perché mi liberasse della sua scomoda presenza. Ma non l’ho mai fatto. Chissà, forse perché la vera padrona di questa casa sono io.
Invece la risposta è di una semplicità disarmante. Essere liberi non è che una pietosa menzogna. Siamo tutti destinati a incontrare un carnefice nella vita. A che pro dovremmo sbarazzarcene?
Anche se io ho trovato lui, lo sciagurato inquilino della stanza accanto. E le cose non cambierebbero se, al di là del muro, non ci fosse nessuno.
La presenza malefica di qualcuno che ci spia non si può evitare, credi a me che ne ho viste tante. Persino quando si è sicuri di essere sfuggiti a una maledizione simile, siamo noi i primi a improvvisarci carnefici di noi stessi.
E a ben poco servono certi innocui diversivi che di tanto in tanto mi procuro nella pietosa illusione di abbattere il muro del tempo.
Sì, perché mentre anelo di fregiarmi del titolo di Contessa di via degli Olivetani, combatto come un’anima dannata contro le rughe che deturpano le mie guance di camelia. E fingo di essere un’Estasi, come s’intitolava quel film famoso ai tempi di mia madre.
Quando sullo schermo si vedevano solo corpi che agivano senza pronunciare una sola parola. Tempi strani, tempi neri come la pece che tuttavia il sole della giovinezza adornava di uno strano colore.
Simile a quello sbiadito degli affreschi che spiccavano sulle pareti del Caffè Novecento. Io andavo là a mangiare un cartoccio di frittura mista accompagnato da un bicchiere di vino rosso. La sola pietanza che a quei tempi potevo permettermi.
Ma torniamo a noi. Non voglio suscitare nessuna compassione. Prima devi sentire la mia storia. Solo dopo essermi confidata con te, giudicherai se è il caso di assolvermi o di condannarmi.
Senza dimenticare che mi sono già condannata da sola. A patire la reclusione, voglio dire. In questo palazzo di un giallo sbiadito come le penne di un canarino, forato da ogive nere che fanno spavento.
Un edificio smangiato dalle pantegane. Pieno di scritte oltraggiose che grondano dall’intonaco come delle piaghe sanguinolente.
Una casa di mattoni sconnessi che mi tremano sotto i piedi. E pensare che fino a cinque anni fa questo rudere era una dimora gentilizia. Anche se siamo a due passi dal carcere di San Vittore.
In questa strana via che fa pensare a giardini segreti, a torrette svettanti e a porte segrete che danno su interni ariosi abitati dall’ombra. Quella che ci protegge dalle crude lame del sole.
C’è uno strano rumore al di là della parete. Sembra quello di un roditore che non riesce a trovare il pertugio in cui penetrare. Credevo che la mia stanza fosse isolata dai rumori del mondo, e invece c’è qualcosa che gracchia e tossisce di continuo.
Questo luogo prima della guerra era una delle tante stanze del marito della proprietaria che, dopo il colpo apoplettico che lo stroncò, la sua vedova inconsolabile ha tramutato in camere a ore.
Anche se so per certo che non è affatto defunto. Perché non si è mai saputo che fine abbia fatto veramente. E questo dà da pensare. Se non è morto, si sarà imboscato come il più fottuto dei traditori.
Magari per farla soffrire. Quindi non ti stupire se di tanto in tanto lei mi chiamerà con il patronimico che spettava soltanto al suo consorte. Conferendomi, addirittura, il titolo di Conte.
Come avrai capito, sono continuamente perseguitato da questa voce che blatera le sue litanie al di là del muro. E che di notte si agita nel dormiveglia con grida, lamenti e maledizioni. Anche se ieri ho finalmente avuto in dono un poco di pace.
Per fortuna non ho sentito i versi strascicati di questa bagascia, che, rivolgendosi alle tenebre, ulula al vento durante i suoi squallidi orgasmi rigirandosi nel letto.
Sia che torni ubriaca dai suoi giri a vuoto per la città deserta, sia che si corichi gioiosa con qualche sbrindellato adescato per strada. Dicono in giro sottovoce, come se la temessero, che si tratti di una nobildonna decaduta.
Ma io so benissimo che valore dare alle favole messe in circolazione da certi squinternati che, persino sul letto di morte, si sforzano di mascherare la verità. Contessa sì, ma dei miei stivali!
Io sputo su di te, sfiorita cinghiala in calore. Dai retta a me, che ho frequentato per davvero l’aristocrazia. Questa cialtrona non è altro che un’ignobile mentecatta. Punto e basta.
A proposito, ti ricorderai di avermi visto passeggiare per i viali del parco Sempione di prima mattina, quando le signore, quelle vere, rimangono a letto fino a mezzogiorno mandando fuori casa le governanti per far prendere un poco di aria ai bambini e ai cani, non è vero?
Ma oggi non c’era in giro nessuno. Che strano, nemmeno le carrozzine col mantice aperto ad accogliere l’aria tiepida del mattino. C’era solo un gran silenzio che faceva paura.
Ho viaggiato a lungo, volevo toccare con mano i corpi innocenti delle bambine più belle del mondo per farle giocare con me. E le portavo all’acquario per guardare dietro i vetri le mosse pigre e lente delle testuggini.
Allora la bambina di quel giorno fortunato batteva le mani felice. E io già mulinavo nella mente il gioco da inventare il pomeriggio successivo.
Arco e frecce se c’era bel tempo, con gli alberi a far da bersaglio. Se invece pioveva, l’avrei portata al caffè e avrei estratto di tasca il mio caleidoscopio per farla precipitare nell’universo dei colori puri.
Stamani, come sempre, sono andato al parco con la mia valigia di cuoio marrone piena zeppa di tesori nascosti da mostrare alle mie nuove amiche. Mi avrai visto senz’altro correre dietro a quelle seduttrici del futuro.
Un futuro che tra le mie mani si sfarina assumendo, senza battere ciglio, le fattezze del presente nelle loro pupille che spiovono sulle tumide labbra in attesa di un bacio.
Naturalmente, se voglio ottenerlo, quel bacio, devo prima ammansire con parole adeguate le rigide aguzzine che le governano mentre le bambine giocano a palla o fanno ondeggiare il cerchio dentro il primo raggio di sole. Devo blandirle con certi complimenti che, sulla bocca di un popolano, le farebbero arrossire.
Mentre, se vengono pronunciate dalla lingua zuccherosa di un gentleman come me, che le avvicina con fare insinuante togliendosi il cappello mormorando flautato la parola signorina, persino il semplice pretesto di fare due passi in loro compagnia diventa un invito allettante.
Povere care, sono soltanto delle misere creature rifiutate a priori dal maschio. Fanciulle avvizzite su cui le rughe hanno tessuto da tempo l’implacabile ragnatela che le condanna alla solitudine. Ma non appena le abbordo col mio sorriso a fior di labbra, tutte quante ne rimangono estasiate.
Lo scambiano per un timido raggio di sole sbucato dalle nuvole. Non sanno, non sospettano che io non miro a loro ma alle piccoline che tengono per mano. A quelle mocciose che quando, con finta timidezza, mi avvicino, sanno già sedurre insinuando nell’assenso la nota stonata della depravazione.
Naturalmente, quando prendo sottobraccio le custodi di tante primizie, devo promettere che non farò nulla perché perdano di vista le mie nuove amiche. Quelle che non appena possibile voglio trascinare dietro un cespuglio con la promessa di far scorgere loro il mio tesoro.
Che poi non è altro che il mio vecchio sesso. Quel turgido ramo di carne che gli schianterò nelle viscere facendole urlare di terrore o di gioia. Fino a che non sbucherò da quei cespugli pallido e tremante, gli occhi ardenti di felicità.
Perché tra quelle femminucce ce ne sono di bellissime che, senza confessarlo nemmeno a se stesse, sono stufe di giocare alle bambole o di saltare la corda facendo stupide smorfie o un inchino lezioso al primo sconosciuto che passa.
Mentre come si può negare il braccio a un signore compito che sfodera il più amabile dei sorrisi? Quello che, senza saperlo, le fa sentire donne quando serro tra le dita nodose della vecchiaia le giovani falangi di quelle puledrine.
Oggi però non c’è nessuna bambina che gioca spensierata. Non c’è nemmeno quella povera nana dalle gambe a spillo che ho intravisto l’altro giorno. E neppure quella zoppa nata con una zampa di coniglio al posto della caviglia tenera e snella.
Ma non divaghiamo. Non c’è più tempo, purtroppo. Dato che la strega che abita al di là del muro è tornata a farsi viva distruggendo sul nascere queste mie fantasie. Insinuandosi come una lama assassina tra i miei ricordi per sfigurarli, per combatterli, per annullarli.
Ora ogni cosa ha un senso. È qui dentro che tutto accade. Io sono la tua coscienza, l’hai capito o no? Mi auguro, per il tuo bene, che tu parli al passato remoto. O forse hai cambiato idea?
Da questo buco che ferisce la parete scorgo finalmente te, che ogni giorno mi torturi con i tuoi sproloqui. Sono arrivata persino a comprendere l’odio che provi nei miei confronti.
Adesso che ti osservo con la meticolosa attenzione che i medici riservano ai pazzi affidati alle loro cure....