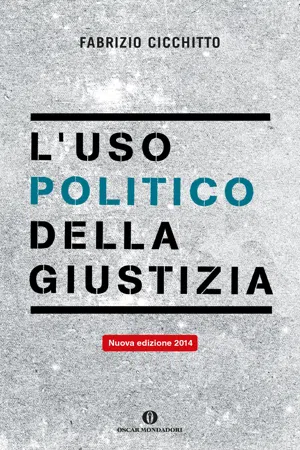L’anomalia più significativa del sistema politico italiano dal 1944 al 1989 è rappresentata dal fatto che, diversamente dal resto d’Europa, l’egemonia della sinistra è stata conquistata dal Pci, il più forte partito comunista dell’Occidente.
Nel nostro passato su questa «anomalia principale» se ne sono innestate anche altre. In primo luogo il retaggio della guerra civile nel ’43-45 da cui sono derivate una serie di conseguenze: la nascita di un partito nostalgico nei confronti di Mussolini e del fascismo, ma inseritosi faticosamente nella dialettica democratica; l’esistenza di un nucleo di estrema destra esplicitamente eversiva organizzatosi in Ordine nuovo e Avanguardia nazionale; il movimento carsico che, partendo da formazioni partigiane comuniste quali la Volante rossa e altre che agirono nel Triangolo della morte, arrivò fino alle Br. A ciò bisogna aggiungere: le molteplici implicazioni «sotterranee» della guerra fredda; la nascita spontanea negli anni Settanta di movimenti estremisti di destra e di sinistra; l’assenza di un autentico mercato e di una libera concorrenza intrecciata con l’importanza decisiva dei partiti non solo in politica ma anche in economia; l’esasperata divisione in correnti dei partiti di governo; l’esistenza in alcune regioni del Mezzogiorno di una criminalità organizzata sul piano verticale e sul territorio; la tendenza alla persistenza e alla ripetitività dei fenomeni di corruzione.
Il Pci – in primo luogo per la debolezza politica, culturale e organizzativa del gruppo dirigente del Psi – riuscì a radicarsi profondamente nella società italiana assorbendo in se stesso aree assai vaste e di opposto segno del movimento socialista, sia quelle tradizionalmente massimaliste sia quelle riformiste, e acquisì contemporaneamente anche il consenso di molti di coloro che erano stati fascisti. L’Emilia-Romagna passò quasi in blocco al Partito comunista, essendo già in precedenza trasmigrata dal riformismo socialista al fascismo. Un altro spostamento quasi globale di campo riguardò una parte significativa dei giovani intellettuali dei Guf e la grande maggioranza degli uomini di cultura che avevano aderito perinde ac cadaver al fascismo. Alcuni di essi erano stati anche finanziati dall’Ovra, come risultava dalle sue liste: l’opportunismo non ha colore, ma è una categoria dello spirito. Di fatto avvenne che tutto un ceto culturale che era stato nel cuore del regime fascista si spostò tra il 1944 e il 1945 su posizioni antifasciste, nel Pci o vicino al Pci, e in questo modo ebbe un ruolo centrale anche nella repubblica nata dopo la Resistenza.
Il «partito nuovo» di Togliatti fu tale perché «aperto» alle masse, e anche alle giovani leve intellettuali provenienti dal mondo culturale fascista (da riviste come «Primato», dai già citati Guf, ecc.). Nel contempo, quel partito aveva un «nocciolo duro» costituito da un gruppo dirigente forgiatosi alla scuola della Terza internazionale e caratterizzato da un legame di ferro con l’Urss.
All’interno stesso di quel «nocciolo duro» c’era un nucleo legato direttamente al Pcus e al Kgb che controllava anche Togliatti il quale, a sua volta, aveva autonomi rapporti con i sovietici.
Nel suo libro La guerra civile, Giovanni Pellegrino riporta un’analisi fatta da Cossiga alla Commissione stragi: «Secondo una descrizione che ci ha dato Cossiga, il Pci aveva una struttura interna su tre livelli. Al primo livello c’era un’“amministrazione speciale” che si occupava con ogni probabilità della gestione dei fondi sovietici. Poi, ad un secondo livello, più occulto, una struttura organizzata direttamente dalla Sezione esteri del Pcus, con l’aiuto del Kgb».1 Il nucleo marxista-leninista-stalinista del Pci concepì originariamente la Resistenza come una fase nella conquista per via armata del potere e adottò conseguenti scelte operative.
Per definire ulteriormente i termini dell’anomalia italiana è però indispensabile spiegare quella che è stata la traduzione «atipica» che nel nostro paese ha avuto il patto di Yalta e la divisione internazionale del mondo in due blocchi.
In seguito al fatto che l’Italia era stata liberata dagli eserciti alleati americani e inglesi, il nostro paese venne a far parte del mondo occidentale anche sul piano politico. Questa scelta fu convalidata dal voto del popolo italiano il 18 aprile 1948 e poi dalle elezioni successive. La conventio ad excludendum del Pci dal governo fu confermata dagli elettori dal 18 aprile 1948 fino a tutte le elezioni che si svolsero successivamente. Nel 1992 il partito postcomunista, cioè il Pds, crollò al 16%.
Dopo un travaglio assai complesso il Pci prese atto di tutte le implicazioni della divisione internazionale del mondo, mantenendo profondi rapporti con l’Urss e anzi organizzando reti finanziarie e strutture clandestine per ogni evenienza, compreso lo scoppio di una terza guerra mondiale e la conseguente invasione dell’Italia del Nord da parte delle truppe del Patto di Varsavia, per la quale esisteva un piano dettagliato inserito in un progetto riguardante una parte dell’Europa.
Il Partito comunista al Nord – guidato da coloro che fin dagli anni Trenta erano stati la «sinistra del Pci», cioè da Luigi Longo e da Pietro Secchia, in continuo confronto dialettico con il «gruppo romano» (Giorgio Amendola, Mauro Scoccimarro, Agostino Novella e altri)2 – aveva cercato di precostituire le condizioni per una successiva presa del potere. Per questo aveva puntato a conquistare con tutti i mezzi, nessuno escluso, la leadership del Clnai (Comitato di liberazione nazionale dell’alta Italia) e della Resistenza al Nord, emarginando sia la componente «militare» (Raffaele Cadorna) sia quella «finanziaria» (Pizzoni) sia i partiti «moderati» (Dc, liberali), radicalizzando lo scontro con i tedeschi e i «repubblichini», spesso concentrando i colpi contro i fascisti moderati attraverso l’azione dei Gap nella città, sviluppando gli attacchi ai tedeschi anche nei piccoli comuni di campagna senza farsi condizionare dalla certezza delle rappresaglie. L’attentato di via Rasella ebbe lo scopo preciso di far saltare il disegno del Vaticano di realizzare «Roma città aperta». Con la medesima logica fu decisa l’esecuzione di Mussolini e dei gerarchi, messa in atto direttamente dall’organizzazione partigiana comunista. La successiva esposizione in piazzale Loreto a Milano dei cadaveri del Duce, della Petacci e degli altri gerarchi fascisti fu concepita come un segnale molto chiaro non solo rispetto al passato, ma anche nei confronti del presente e del futuro. Si trattava, cioè, di radicalizzare la lotta partigiana per preparare la strada alla rivoluzione. Fu questa, infatti, l’interpretazione della «nuova fase» dopo il 25 aprile da parte della Volante rossa in Lombardia e di molti nuclei di partigiani e dei gruppi dirigenti del Pci in Piemonte, in Veneto e specialmente in Emilia-Romagna.
In effetti dopo il 25 aprile avvenne qualcosa di più e di peggio di una efferata persecuzione di massa nei confronti di chi era stato fascista. In alcune aree del paese ci fu, com’è noto, la scientifica eliminazione non solo di chi aveva in qualche modo militato nel movimento fascista, ma anche di chi avrebbe potuto ostacolare la presa del potere da parte dei comunisti. Molti settori del Pci e delle sue organizzazioni partigiane non si limitarono alle rappresaglie ma procedettero all’eliminazione «preventiva» dei possibili avversari politici del futuro: essi praticarono in Piemonte (specie in Valsesia con Moranino), in Lombardia e, in misura ancora maggiore, in Emilia-Romagna una sorta di «guerra civile di classe», uccidendo imprenditori, agrari, preti, dirigenti democristiani e socialdemocratici. Non si era assassinati solo perché si era stati fascisti o si era anticomunisti ma anche perché si apparteneva a una categoria sociale che avrebbe potuto intralciare la marcia dei comunisti verso la conquista del potere. Tale operazione in Emilia-Romagna servì a eliminare ogni alternativa politica al dominio del Pci. Il gruppo dirigente del Pci (Palmiro Togliatti, Luigi Longo, Pietro Secchia) «coprì» i partigiani comunisti che si resero responsabili degli efferati delitti di massa descritti da Giampaolo Pansa e da altri storici.3 Quei partigiani furono fatti fuggire in Cecoslovacchia. Invece tutta una rete facente capo in vario modo a Pietro Secchia rimase in campo in Italia. Alcune sue diramazioni e «filiazioni» arrivarono fino alle Brigate rosse. Tipica la storia dei «ragazzi di Reggio Emilia» e di Giambattista Lazagna.
In Cecoslovacchia alcuni di quei partigiani assassini andarono a far parte della redazione di Radio Praga diretta da Sandro Curzi. Sulla vicenda ha scritto un bel libro Giuseppe Fiori: Uomini ex.4 Molti anni dopo, Armando Cossutta prima e Ugo Pecchioli poi inviarono dall’Italia in Cecoslovacchia nuclei ristretti di quadri per l’addestramento a forme di lotta non convenzionali. Sullo sfondo c’erano i piani di invasione di una parte dell’Europa occidentale fino all’Italia a opera delle truppe del Patto di Varsavia che rimasero mobilitate per anni per poter infliggere «il primo colpo» con grande velocità e con una devastante forza d’impatto. Gli eserciti dei paesi dell’Est furono «smontati» solo quando negli Stati Uniti arrivò al potere Ronald Reagan e quando l’avvento di papa Wojtyla e l’espansione di Solidarność destabilizzarono la decisiva retrovia polacca. Ciò fornisce una possibile spiegazione dell’attentato al papa Giovanni Paolo II.
L’amnistia di Togliatti, allora ministro di Grazia e Giustizia, servì a sanare la situazione di illegalità nella quale si trovavano molti partigiani comunisti e fu anche intelligentemente estesa ai fascisti che a loro volta la utilizzarono per tornare in campo e per riorganizzarsi: una larga parte di essi nel Msi, una minoranza in formazioni quali Ordine nuovo, che praticò in una certa fase anche la linea degli attentati e dello stragismo in combutta con settori dei servizi segreti, o in Avanguardia nazionale che per parte sua si impegnava nella guerriglia urbana e nello scontro fisico (ma Serafino Di Luia svolse un’attività polivalente, «teleguidato» da alcuni uomini dei servizi). Ci fu più di un parallelismo fra le organizzazioni di estrema sinistra e quelle di estrema destra, ci fu anche una «divisione del lavoro» fra chi nell’estrema sinistra praticava la lotta armata (Br, Prima linea, ecc.) e chi praticava la guerriglia urbana (Autonomia operaia, Mls, servizio d’ordine di Lotta continua, ecc.). In parallelo, all’estrema destra v’era chi praticava lo stragismo e chi si mobilitava per la guerriglia urbana. Sul terreno della guerriglia urbana, poi, c’erano anche settori del Fuan e del servizio d’ordine del Msi: vedi l’«invasione» dell’università di Roma da parte della direzione nazionale del Msi (a guidare l’operazione c’erano Giorgio Almirante e Giulio Caradonna) al decollo del Sessantotto per marcare la scelta del «blocco d’ordine» e l’emarginazione dei «nazimaoisti» fino allora inseriti nel movimento studentesco.
Al Nord, nel ’45-47 c’erano le condizioni per una presa del potere da parte delle forze partigiane guidate dal Pci. Da Roma in giù, nel Mezzogiorno, la situazione invece era molto diversa, anzi opposta: le forze moderate e conservatrici erano largamente prevalenti negli apparati dello Stato e sul territorio. Al di là dei rapporti di forza esistenti nello Stato e nella società italiana fu però decisiva la presenza in Italia dell’esercito anglo-americano al quale si doveva la liberazione del paese dal nazifascismo.
Per quello che riguarda le scelte strategiche del Pci, però, la partita decisiva non fu giocata in Italia. Essa fu affrontata innanzitutto a livello internazionale sul terreno della divisione globale del mondo. Per quanto riguardò la traduzione di tutto ciò in Italia la decisione essenziale fu presa a Mosca il 3-4 marzo 1944, quando Stalin, rovesciando la condotta fino allora seguita dalla diplomazia sovietica e soprattutto facendo cambiare totalmente la linea «di sinistra» seguita dal Pci (Ercoli compreso), spiegò a Togliatti i termini della «scelta moderata» che poi andò sotto il nome di «svolta di Salerno». In Italia quella scelta è stata attribuita alla genialità politica di Palmiro Togliatti, alla sua linea di cauta «autonomia nazionale». Invece essa fu decisa dal «padre dei popoli», come dimostra in modo indiscutibile la documentazione proveniente anche dagli archivi in Urss.5 In sostanza, se in Italia dopo il 1945 non c’è stata una seconda guerra civile il merito, da parte comunista, è stato di Stalin e non di Togliatti, che era l’esecutore delle direttive sovietiche. L’origine sovietica di quelle direttive spiega perché anche la direzione «nordista» del Pci (cioè Longo e Secchia) si allineò.
Con la «svolta di Salerno» e con la scelta di una linea moderata nei confronti della dialettica politica in corso nel nostro paese Stalin creava le condizioni per la versione italiana di Yalta,6 che era l’opposto di quella definita in Germania, dove avvenne una sorta di spartizione geografica: mentre nella Ddr il Partito comunista conquistava e gestiva in modo totale il potere, nella Rft esso era posto fuori legge. In Italia il Pci veniva ad avere uno status speciale: non «poteva» conquistare il potere né, passata la prima fase, stare al governo, ma andava «rispettato» come forza di opposizione, anche con il bagaglio di tutte le sue «doppiezze» e delle sue «irregolarità» (i diretti rapporti informativi al limite dello spionaggio del gruppo dirigente del Pci con l’ambasciata sovietica negli anni ’45-48, i massicci finanziamenti dall’Urss, l’addestramento per attività paramilitare di «quadri» italiani in Urss, l’esistenza dell’«Apparato» o Gladio rossa, l’istituzione di una rete di ricetrasmittenti clandestine, il sistema di appartamenti e rifugi riservati, l’inserimento nei corpi separati dello Stato).
Nella complessità di questi rapporti internazionali e nella preferenza reciproca per uno scontro politico e sociale «a bassa intensità» per ciò che riguardava l’uso della violenza, entrambe le parti, però, si precostituivano gli strumenti per affrontare eventuali scontri radicali e frontali. Gli americani mettevano in conto la possibilità che, così come era avvenuto in Corea, Stalin decidesse di forzare la situazione: di qui il Patto atlantico, il monitoraggio da parte della Cia della situazione italiana e la successiva organizzazione di Stay behind, una struttura paramilitare che doveva agire «dietro le linee» nel caso di un’invasione sovietica del nostro paese. Ancor più complessa era la problematica che caratterizzava l’Urss e gli Stati comunisti. La battuta di Stalin: «Ora non è possibile» rivolta a Pietro Secchia che lo interrogava sull’ipotesi del «salto rivoluzionario» in Italia ebbe due versioni sul piano più strettamente politico: la politica dell’inserimento a tutti i costi nell’area di governo fino a quando resse l’intesa fra i «tre grandi» e poi una politica di opposizione frontale quando, come suol dirsi, fu alzata la «cortina di ferro». La svolta del Cominform, fatta in seguito al mutamento complessivo della situazione internazionale, comportò anche una critica durissima del Pcus al Pci e al Pcf perché si erano lasciati escludere dai rispettivi governi senza sviluppare grandi lotte di massa. Di qui la perentoria richiesta (immediatamente raccolta dai due partiti), rivolta al Pci e al Pcf, di una radicalizzazione dello scontro politico e sociale. Anche in questo caso, però, non andava superata una soglia decisiva: quella del passaggio alla lotta armata. Come dimostrano le carte uscite dagli archivi sovietici, sia la radicalizzazione politica e sociale dello scontro sia il netto rifiuto della lotta armata furono scelte politiche fatte in primo luogo dal gruppo dirigente sovietico e «comunicate» al Pci che le fece sue, adeguando di volta in volta la propria linea politica.
Togliatti manifestò una grande capacità di adattamento a ogni «svolta» richiesta dai sovietici e certamente diede il meglio di se stesso nel tradurre la linea «pacifica» in una grande operazione di radicamento nella società italiana, anche perché quella era la linea che egli preferiva a condizione che si inserisse nella strategia globale del Pcus.
Infatti anche alla vigilia del 18 aprile 1948 Togliatti non escludeva il ricorso alla lotta armata e poneva un interrogativo conseguente ai sovietici che rispondevano suggerendo di preparare la difesa armata delle sedi ma escludendo il passaggio all’insurrezione per conquistare il potere. Togliatti pose su tutto ciò all’ambasciatore sovietico Kostylev un quesito assai preciso ricevendo qualche tempo dopo una risposta altrettanto dettagliata dagli «amici» sovietici. Il 26 marzo Molotov telegrafò a Kostylev la risposta di Mosca affinché la trasmettesse a Togliatti: «In caso di attacco armato delle bande fasciste alle sedi del partito e ai suoi rappresentanti, il Cc della Vkp(b) consigliava che i gruppi comunisti d’assalto rispondessero con le armi. “Ma, per ciò che riguarda la presa del potere attraverso l’insurrezione armata, noi crediamo che il Partito comunista italiano, al momento attuale, non debba tentarla per nessuna ragione.” Pur non considerando l’Europa occidentale come facente parte della zona di influenza sovietica, l’Urss contava tuttavia sul mantenimento e sul consolidamento delle posizioni dei partiti comunisti in Italia e in Francia e non voleva correre il rischio del loro annientamento».7
Tutto ciò conferma il fatto che dobbiamo a Stalin e non a Togliatti il mancato scoppio in Italia della guerra civile. Anche Pietro Ingrao, in una intervista a «l’Unità», ha confermato questa interpretazione prendendo nettamente le distanze dal suo intervistatore, il giornalista Bruno Gravagnuolo, che su Togliatti e anche sulle Br aveva tentato di «suggerirgli» la linea ufficiale: «Gravagnolo: “Eppure già il Pci nuovo di Togliatti non contemplava più la violenza dello scontro armato. Propugnava anzi la via pacifica ed escludeva la violenza rivoluzionaria”. Ingrao: “Non sono d’accordo con te. Tanta parte del quadro comunista nel dopoguerra pensava ancora all’ora X. Almeno fino agli anni Sessanta. Prova ne sia che negli anni Settanta è emersa una componente, quella del brigatismo rosso che aveva addentellati nel Pci”. Gravagnolo: “Una parentela sovversiva molto alla lontana. Quelli erano gli eredi di un estremismo che fu subito battuto e sconfitto da Togliatti nell’immediato dopoguerra”. Ingrao: “Ma alcuni di quegli estremisti erano comunisti. E poi Togliatti non ha mai detto che il socialismo non si doveva fare con le armi. Trovami una pagina in cui lo escluda in linea di principio”».8 Ciò vuol dire che Togliatti non avrebbe esitato a scatenare la lotta armata qualora questa fosse stata la scelta dei sovietici. Va anche detto che Togliatti, a differenza di Secchia, preferiva la gestione della via pacifica. D’altra parte, pur avendo dovuto frenare Secchia sul terreno strategico, è anche evidente che i sovietici si servivano di Sec...