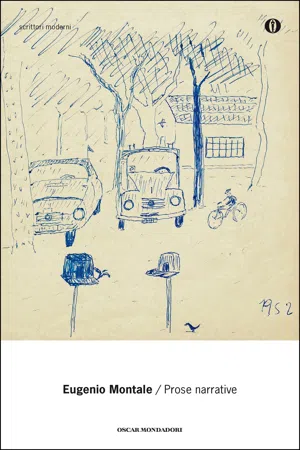Racconto d’uno sconosciuto
1. Il personaggio che racconta (un narratore di secondo grado rispetto a quello, di primo grado, che trascrive il racconto) si rivolge a un muto interlocutore. La situazione non è, perciò, troppo lontana da quella di molti testi poetici montaliani: tra questi, La casa dei doganieri (OC), che al primo verso reca lo stesso verbo («Tu non ricordi la casa dei doganieri») presente all’inizio della prosa. “Ricordare” è, del resto, parola di primaria valenza tematica nella Farfalla di Dinard. Da notare anche l’avverbio «forse», significativo per frequenza e rilievo negli Ossi di seppia, qui in posizione incipitaria come in «Forse un mattino andando…» (OS).←
2. Rivista di area cattolica stampata a Genova dal 1880 e proseguita a lungo, negli anni dell’adolescenza di Montale.←
3. È il primo dei riferimenti, di qui in poi numerosi nel brano e nel libro, alle consuetudini della famiglia, in gran parte corrispondenti alle tradizionali abitudini del ceto medio-borghese primonovecentesco dal quale Montale proviene. Tali riferimenti contribuiscono a creare una sorta di “colore” al tempo stesso temporale e sociale intorno alle figure e ai personaggi delle prose.←
4. Pietrasanta, in provincia di Lucca, è un centro di lavorazione del marmo (cfr. Donna Juanita, FD) ed è prossima alle località balneari della Versilia. Cfr. Realismo non magico (SA), vv. 24-}}: «le visite e la morte della zia / di Pietrasanta»; Una visitatrice (AV), vv. 1-3: «Quando spuntava in fondo al viale / la zia di Pietrasanta noi ragazzi / correvamo a nasconderci in soffitta».←
5. Il nome del solutore di enigmi si legge realmente sui giornali dell’epoca a cui fa riferimento Montale (Moffa ipotizza addirittura che si tratti di un maestro del giovane Montale presso il collegio dei Barnabiti). Il ricordo di padre Buganza riaffiora anche nel breve racconto Il commendatore (PNE). Buganza, al di là della sua consistenza reale, è un nome parlante: alla lettera, significa “gelone”. Il «trionfale annuncio» ricorda, per la somiglianza dei nomi, l’esclamazione “Buffalo” dell’omonima poesia nelle Occasioni. In quel componimento e in questa prosa, del resto, il nome ha una parte decisiva nel suscitare l’improvvisa associazione di pensieri – un’epifania o una rievocazione – da cui entrambi i testi traggono le proprie diverse ragioni.←
6. Compare qui, per la prima volta nel libro, una figura paterna evidentemente esemplata su quella di Domenico Montale (1855-1931), il padre dell’autore. Questi era a capo di una ben avviata azienda che commerciava in prodotti chimici, la G.G. Montale e C. La ditta aveva intrattenuto proficui rapporti anche con l’azienda presso cui Italo Svevo ricopriva ruoli dirigenziali. A quanto anzi racconta lo stesso poeta (in Poesia e società, 1946, ora in SM, I, pp. 661-64), il nome “Montale” era già noto allo scrittore triestino proprio per via di quelle relazioni commerciali, prima dell’uscita degli Ossi e indipendentemente dalla “scoperta” montaliana dei romanzi di Svevo. La figura del padre è presente anche nella coeva Bufera e altro: in Voce giunta con le folaghe, dove il ricordo assume però un’intonazione più lirica, e nella prosa Dov’era il tennis…, nella quale la rappresentazione appare più vicina a quella di Racconto d’uno sconosciuto.←
7. Giochi enigmistici. Il logogrifo, già noto nell’antichità, consiste nell’anagrammare le lettere di una parola per comporre parole diverse, anche con un minor numero di lettere rispetto al vocabolo di partenza. Il monoverbo è un tipo di rebus, la cui soluzione è formata da una sola parola.←
8. Il “filo”, presente in vari luoghi della poesia montaliana come immagine-simbolo della memoria, è qui più letteralmente il legame che unisce il narratore al padre.←
9. “Settimanale”, dal latino hebdomadarius, a sua volta dal greco hebdomàs, “settimana”.←
10. L’enigmistica, in particolare le parole incrociate, richiama per analogia l’enigma di un reale problematico, da decifrare attraverso i segni labili e improvvisi che offre: i barlumi o i «disguidi del possibile» (Carnevale di Gerti, OC, v. 58). L’assenza di enigmi è, per il narratore, la condizione di un’età ancora innocente. Cfr. Fine dell’infanzia (OS), vv. 69-70: «Eravamo nell’età verginale / in cui le nubi non sono cifre o sigle».←
11. Dei cambiamenti di Genova nel corso dell’ultimo secolo Montale scrive soprattutto nella recensione a «Genova com’era 1870-1915» di Luciana Frassati (1960, SM, I, pp. 2225-27), in Atmosfera di Genova (1963, SM, I, pp. 2547-49), in Genova nei ricordi di un esule (1968, SM, I, pp. 2872-79). La deriva della modernità, in una prospettiva di «conservatorismo apocalittico» (Luperini1), è descritta in termini simili in Mutazioni (1949): «Non esistevano le bibite eccitanti, i cocktails. All’alba del secolo i pochi che incominciarono a bere l’“americano” (deprecati viveurs in bombetta e stiffelius) erano additati al disprezzo generale» (SM, II, p. 88). Da accostare a questo è anche un passo da Il bello viene dopo (FD): «Alzò la mano accennando alle figure di un cartello pubblicitario: uomini e donne dai capelli giallo uovo, in abito da sera, distesi all’ombra di un grande albero e armati come di bombe a mano di tante bottigliette di gazosa: tutti sorridenti, felici».←
12. Sinonimo di redingote, abito maschile di origine inglese, simile alla finanziera, con giacca lunga al ginocchio. In uso nel XIX secolo, ha oggi un uso molto limitato (quasi esclusivamente come divisa per i portieri di alberghi di lusso). Il nome deriva forse dall’opera Stiffelio di Giuseppe Verdi (GDLI). Cfr. la lettera di Marianna Montale a Ida Zambaldi, a proposito dell’abbiglimento del fratello Ugo: «E porta lo stiffelius (sai cos’è?), io prima non lo sapevo; son quei paltò da uomo attillati, con quei due bottoni dietro, la mazza» (Casa Montale).←
13. Aperitivo amaro a base di vermut, scorza di limone o arancia e acqua gassata.←
14. Gran via è il titolo di una c...