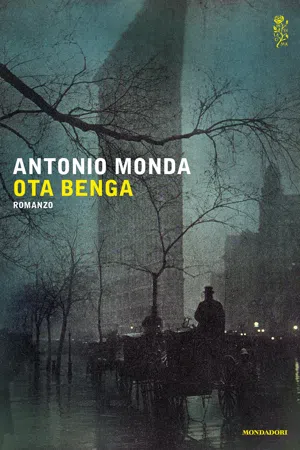![]()
Se vuoi vedere una sfida vera, mi aveva detto, devi vedere come combattono i negri. Un giorno uno di loro diventerà campione del mondo, aveva aggiunto, e il tono della voce si era fatto amaro. Mi guardava sempre negli occhi, quando parlava, e io credevo a quello che diceva, lui lo sapeva bene.
Era un giorno afoso, l’asfalto si squagliava sotto i piedi, e c’era un pugile che combatteva due volte di seguito, tanto era forte. Mi aveva portato sino a Filadelfia per vederlo, era anche un modo di allontanarci dai nostri pensieri. Dai miei, almeno.
Ricordo le camicie sudate e l’odore di zucchero filato che invadeva l’arena. Ricordo il legno cadente e scrostato e le corde usate sulle navi, all’epoca non erano fasciate dal velluto. Sul ring si mette in gioco la vita, diceva, la tranquillità è l’illusione dei mediocri. Poi mi toccava le gambe, non sapeva stare fermo, e il sudore sulla nuca lo rendeva ancora più attraente.
Non c’è nulla come un incontro di boxe, continuava a dire.
Ricordo poi l’arrivo del gigante di Galveston, così annunciavano Jack Johnson. Era calvo e aveva lo sguardo dolce, per questo faceva paura.
Il primo sfidante si chiamava Claude Brooks, ma sull’accappatoio c’era scritto Black Bill, era il suo modo di incutere timore. Il nome del secondo era Morris Harris, ma lui non lo aveva cambiato: sicurezza, orgoglio, chissà.
Johnson salì sul ring ignorando Black Bill, e rispose con un sorriso al pubblico che lo aveva accolto con un’ovazione. Mentre l’arbitro dava gli ultimi avvertimenti fissò negli occhi il rivale, che cercò di reggere lo sguardo, ma era spaventato, si vedeva. Poi, prima del gong alzò improvvisamente le braccia al cielo, gonfiando i muscoli, e il pubblico esplose in un applauso lunghissimo, la fine era già nota.
Raggiunse il centro del ring con due passi, e Black Bill indietreggiò subito sulle corde. Johnson lo aggredì con un gancio largo, ruotando tutto il corpo color tenebra, e il rivale riuscì a schivarlo solo in parte, perché il pugno gli lacerò le labbra e il sangue schizzò sul volto. Vidi gli occhi di Black Bill, bianchi di panico, aspettare pietrificati il secondo pugno, che gli spaccò il naso. Cadde di schiena come un peso morto, e il polso destro si piegò innaturalmente sul tappeto, spezzandosi. Sentii distintamente il rumore secco, e poi lo spasmo che il pugile non riuscì a trattenere.
Johnson fece un balzo in avanti e fissò gli occhi terrorizzati di Black Bill, poi si batté il petto e sorrise con scherno, con disprezzo, tendendo ancora una volta i muscoli da gigante. L’arbitro tentò di farlo arretrare, ma lui lo allontanò con stizza e rimase lì, a sovrastare il corpo di quel mediocre che aveva osato sfidarlo: sembrava volesse calpestarlo. E lanciò un urlo profondo, un ruggito, guardando il pubblico intorno a sé, che rispondeva con un boato e ululava di gioia, forse cantava, così mi parve.
In quel momento Black Bill trovò la forza di rialzarsi, ma non fece neanche in tempo a impostare la guardia che Johnson lo colpì con furia sul collo, e poi sul naso spaccato, una, due, tre volte, fin quando non cominciò a penzolare da un lato, mentre il volto era completamente coperto di sangue. Volle finirlo con un pugno sul mento, perché è il più spettacolare e umiliante: mise tutto il peso del corpo in un uppercut, che sollevò il rivale dal ring e lo fece stramazzare definitivamente a testa in giù. Erano passati meno di venti secondi e Johnson alzava nuovamente le braccia al cielo mentre Black Bill piangeva di dolore, e il suo sangue arrossava il tappeto.
Non rimanemmo a vedere il secondo incontro, Ruud mi immaginava già a letto, chissà in quale posizione, e io mi fissai di nuovo sul sudore sulla nuca. Sul suo odore.
Prima di tornare in albergo guardai per l’ultima volta quell’arena piena di negri, dove Morris Harris stava entrando senza speranza.
E pensai a quello che avevo lasciato a New York, dove io, Arianna Sarris, e Ruud Barron lavoravamo allo zoo del Bronx.
![]()
Il giorno in cui ce lo avevano lasciato in consegna ero rimasta colpita dai denti, aguzzi e gialli come quelli di una pantera. Li avevo immaginati coperti dal sangue di una preda sbranata senza gioia.
E avevo sentito l’alito forte, il respiro raschiato, l’odore della pelle che non conosceva indumenti. Ruud tratteneva a stento il disgusto, io invece pensavo che non avevo mai visto nessuno così piccolo: era un essere umano di un metro e venticinque centimetri, che guardava fisso il medico che lo stava visitando. Non aveva la più pallida idea di dove si trovasse, ma negli occhi non c’era smarrimento, rabbia semmai, e una violenza antica, eterna, pronta a esplodere in ogni momento.
Chissà quante ne aveva viste da quando era stato catturato dai mercanti di schiavi sulle rive del fiume Kasai. Chissà che idea si era fatta dell’America, quando era stato esibito nella fiera universale di St. Louis insieme a Geronimo, una coppia di eschimesi e un gruppo di Igorot, chissà cosa si erano detti.
Si chiamava Ota Benga, ci aveva spiegato un interprete, e probabilmente aveva ventotto anni, così sembrava dalle mani e dai lineamenti, ma lo sguardo era quello di un uomo vissuto già troppo. L’interprete aveva aggiunto che era un pigmeo Mbuti, goloso di formiche e di miele: intendeva che non era un cannibale, come avevano scritto a St. Louis.
Era arrivato in America con Samuel Phillips Verner, e il direttore dello zoo, William Hornaday, aveva dato disposizione di trattarlo con la massima attenzione. Non che amasse Verner, anzi, ma preferiva non averlo contro: quando aveva devoluto tutti i suoi beni ai poveri era diventato il beniamino degli stessi mecenati ai quali Hornaday ricorreva ogni volta che aveva bisogno di finanziamenti.
Verner aveva conosciuto Ota Benga in Congo, dove era andato a fare il missionario. «Bisogna conoscere gli ultimi» diceva, «capirne il dolore, le sofferenze, amarli.» Lo ripeteva con foga, rabbia, con commozione, perché quel prete presbiteriano era stato un uomo d’affari cinico e spregiudicato, ma poi un giorno aveva cominciato a dire che nessun uomo è un’isola, e quello che succede a ognuno di noi coinvolge sempre tutti. Il suo mondo aveva reagito con sconcerto e ironia: nessuno riusciva a capire cosa fosse stato a cambiarlo, sono rivoluzioni che scoppiano dentro l’anima, per chi ci crede.
In un viaggio nel territorio di Kwamouth, Verner era riuscito a liberare Ota Benga e altri sette pigmei dai mercanti di schiavi: li aveva comprati, perché con quella gente era l’unica cosa da fare, e poi aveva giurato a ognuno di loro che avrebbero avuto una nuova vita: «L’America è una promessa, e farò in modo che venga mantenuta».
Gli altri erano fuggiti appena sbarcati a New York, ma con Ota Benga era nato un rapporto profondo, basato sui silenzi e gli sguardi. E quando pure lui fuggì dal dormitorio della chiesa in cui gli aveva trovato alloggio, Verner capì che anche il suo affetto era una limitazione della libertà, il pigmeo non si fidava della promessa americana. Ne soffrì come fosse un tradimento, poi lo affidò al Signore nelle orazioni che recitava ogni giorno prima di sfidare questo mondo sazio e disperato.
Lo aveva ritrovato a St. Louis nella giornata inaugurale dei giochi olimpici, e si erano emozionati come due bambini: chissà come c’era arrivato, in quel posto, chissà quanti altri dolori, quante umiliazioni.
Lo aveva abbracciato sotto lo sguardo impassibile di Geronimo e gli aveva promesso che lo avrebbe liberato da quella nuova schiavitù.
«Dovreste vergognarvi tutti» urlò, «e dovrei vergognarmi anch’io» aggiunse tra le lacrime, e lo strinse forte, mentre gli Igorot borbottavano qualcosa nel loro dialetto di montagna.
Aveva tentato di riportarlo nel suo villaggio sul fiume Kasai, ma poi il destino – lui disse il Signore – li aveva fatti tornare nuovamente in America, dove gli aveva trovato alloggio presso il Museo di Storia Naturale di New York: un gruppo di antropologi avevano offerto ospitalità in cambio della possibilità di studiarlo. La vita è un mistero, mi disse quando cominciò a confidarsi: era una delle frasi che ripeteva più spesso, e solo in questi ultimi anni ha cominciato ad aggiungere “doloroso”. Ancora oggi, che è vecchio e malato, ritiene che essere ingenuo sia meno grave che perdere fiducia negli uomini, ma si pentì amaramente quando capì che gli antropologi consideravano Ota Benga alla stregua di un animale, che non aveva neanche la comodità di essere impagliato.
I primi tempi lo avevano lasciato girare liberamente nella sala della balenottera azzurra. I visitatori erano affascinati da quello strano bambino africano coperto solo da una pelle d’antilope che rimaneva a guardare per ore l’animale più grande del mondo. Ma un giorno Daniel Rockefeller aveva cercato di prenderlo in braccio, e per tutta risposta Ota Benga gli era saltato al collo digrignando i denti da pantera, voleva strangolarlo. C’erano volute tre guardie per salvare il miliardario, il quale aveva sospeso immediatamente le donazioni al museo, invitando l’alta società newyorkese a fare lo stesso, una vergogna del genere non era mai successa.
Il giorno successivo il Museo di Storia Naturale si era sbarazzato di Ota Benga, affidandolo a noi: Verner era già ripartito per l’Africa, e William Hornaday gli aveva scritto che allo zoo avrebbe trovato un alloggio comodo e il cibo di suo gradimento, anche il miele di cui era goloso. Si era dilungato in complimenti per la sua attività di missionario, “una scelta nobile e un esempio per tutti”, poi, dopo aver spedito la lettera, aveva cominciato a programmare una grande esibizione, dove avrebbe esposto Ota Benga nella gabbia delle scimmie.
«Passeremo alla storia» aveva spiegato a tutti noi, «questa creatura è la prova vivente delle teorie di Darwin, abbiamo il dovere di mostrarla al mondo.»
![]()
Era una città giovane, ma lo sarà sempre, questo l’ho capito da molti anni, e lo sa chiunque viva a New York. Ma in quei giorni era giovane anche l’energia dei vecchi, e chi era appena arrivato sembrava che non potesse mai perdere la propria storia. Le lingue provenienti da ogni parte del pianeta erano parlate con forza, con orgoglio, con musicalità, sembrava che venissero cantate: nelle strade, nei ristoranti, nelle case con le finestre aperte anche d’inverno. Sembrava che ogni abitante volesse dimostrare quanto fossero belle, quanto fossero diverse, e che non sarebbero mai cambiate, in quel mondo nuovo. E sembrava che fossero arrivati tutti il giorno prima, o quella mattina stessa, per onorare la promessa fatta dalla terra che li aveva accolti.
Ota Benga non l’aveva scelta, l’America, e la sua lingua non voleva farla sentire, non c’era nessuno con cui potesse condividerla: parlava con gli occhi e raccontava una storia antica come il mondo. Ruud diceva inevitabile, come la violenza. Io preferivo incerta, come la speranza.
Quegli occhi silenziosi avevano visto la moglie e i figli massacrati dai soldati di Leopoldo II, il re del Belgio. Non era neanche riuscito a distinguerli, da come ne avevano ridotti i corpi, ma non aveva pianto.
Avevano visto i mercanti che lo catturavano con le reti usate per i Bonobo, gli scimpanzé in miniatura venduti al suo stesso prezzo, tanto erano rari. Chissà di dove erano, quei mercanti dal volto stanco e ridanciano: mentre lo incatenavano parlavano una lingua misteriosa. Loro non portavano uniformi, e bevevano tanto.
Avevano la noia sul volto mentre uccidevano i compagni con cui aveva imparato a cacciare gli okapi e i leopardi. E l’odore effeminato di chi non si copre di pelli e foglie.
Un compagno gli aveva detto che venivano da un paese senza fiumi, e tradivano il loro Dio, che non voleva che bevessero. Si erano stabiliti in un’isola dalle acque turchesi e avevano costruito un forte, dove avevano venduto i re, le regine e i guerrieri catturati nelle loro razzie. Il compagno gli aveva spiegato che il capo si chiamava Tippu Tip, e il dottor Verner ne conosceva il nome intero: Hamad bin Muḥammad bin Jumah bin Rajab bin Muḥammad bin Sa’īd al-Murghabī. Era l’uomo più ricco di Zanzibar, e forse dell’Africa orientale: aveva diecimila schiavi, sette piantagioni di chiodi di garofano, e un harem nel quale potevano deliziarsi anche i bianchi con cui faceva affari. Verner mi raccontò che era amico anche di Henry Morton Stanley, e fu proprio l’esploratore, con la benedizione di Leopoldo II, che lo fece diventare governatore del distretto delle Cascate Boyoma. Così va il mondo, aveva aggiunto.
Ota Benga queste cose non le seppe mai, ma non ne aveva certo bisogno per conoscere il cuore degli uomini.
Il giorno che venne catturato, i suoi occhi silenziosi avevano visto uno degli aguzzini diventare bianco dal terrore: il mercante era stato così idiota da bagnarsi nell’ansa del fiume Kasai in cui riposano gli ippopotami, e prima di scomparire sott’acqua aveva lanciato un urlo straziato ai compagni che non potevano far nulla. Forse non volevano neanche, una quota in meno da dividere. Ne ritrovarono solo il berretto e il pezzo di una mano, amputata di tutte le dita.
Ota Benga non aveva parlato neanche in quel momento: trovarsi incatenato da uomini senza coraggio e saggezza era la peggiore di tutte le ingiurie. Ma non avrebbero mai conquistato la sua anima, quella solo la foresta madre potrà pretenderla, un giorno.
![]()
Geronimo era stato l’unico a tentare di parlargli, a St. Louis li esibivano insieme: voleva conoscere la storia di quell’uomo piccolo come non aveva mai visto nessuno. L’onta dell’esposizione pubblica non era l’unica esperienza che avevano in comune: di ritorno da una battuta di caccia, anche il guerriero Apache aveva trovato la famiglia sterminata. Era stato un gruppo di banditi messicani, che avevano razziato il suo villaggio per rubare qualche pelliccia ed un po...