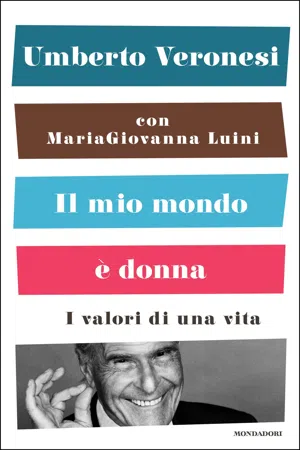Nella mia vita ho incontrato tante donne che meriterebbero di essere raccontate in interi capitoli. Donne che hanno cambiato la storia e donne che apparentemente sono state protagoniste di vite silenziose, di cui non hanno lasciato traccia; donne che con la voce bassa hanno incarnato il proprio ruolo nella storia grande e piccola, che sono state capaci di affrontare situazioni enormi, drammi e difficoltà con la forza impressionante dell’amore e di un sorriso che non si è mai spento. Donne volitive e schiette, intelligenti, sagge; donne creative e appassionate. Donne decise e intraprendenti; donne timide e solitarie. Quante me ne vengono in mente ora, a quante vorrei dedicare spazio in questo libro…
In verità sono sempre stato affascinato da quelle donne che non hanno una storia particolare da menzionare nei libri. Anche se, a ben vedere, ogni storia femminile meriterebbe che qualcuno vi si soffermasse per coglierne nelle pieghe la forza dell’amore e gli insegnamenti che potrebbero condizionare decine di altre vite.
Credo che per trasmettere un messaggio importante l’esempio valga più di tante parole: con i bambini e con i ragazzi siamo tanto più efficaci nell’educazione e nell’insegnamento quanto più rendiamo reale il concetto che vogliamo spiegare. E nulla è più reale dell’esempio.
Anche per quel che riguarda le mie idee sulla pace, ho sempre scelto di manifestare ciò che pensavo attraverso il mio comportamento piuttosto che con discorsi troppo lunghi. I discorsi aiutano, ma difficilmente hanno l’impatto vivido e indelebile delle immagini, dei ricordi di una persona che ci ha colpito. Chi è non violento lascia traccia nella storia e sa formare intere generazioni.
Ad ogni modo, ecco di seguito alcune figure femminili della storia, il cui esempio ritengo sia particolarmente significativo.
Ipazia di Alessandria
Di lei sappiamo pochissimo. Nacque in Egitto, ad Alessandria, intorno al 370, ed era figlia di Teone Alessandrino (filosofo, matematico e scienziato, autore di opere matematiche), di cui divenne allieva e collaboratrice. Non si mosse mai da Alessandria e della sua opera purtroppo non è rimasto quasi nulla, anche se sappiamo che fu la principale esponente alessandrina della scuola neoplatonica e si dedicò a studi matematici, alla filosofia e all’astronomia. Era una grande insegnante, e per questo divenne famosa in tutta la città. Una testimonianza preziosa arriva da Sinesio, vescovo di Cirene, che fu suo allievo nonostante lei non fosse cristiana.
Intorno al 375 ad Alessandria nacque Cirillo, che crebbe all’ombra dello zio Teofilo cui succedette sul seggio episcopale nel 412. Come lo zio, Cirillo era un uomo dalla personalità decisa e spregiudicata: per favorire la Chiesa cercò invano l’alleanza del prefetto imperiale Oreste, assai poco propenso a schierarsi con i cristiani. Pare che Oreste fosse un ammiratore di Ipazia e avesse preso l’abitudine di consultarla sui problemi della città. Alcune fonti raccontano che un giorno Cirillo, da vescovo, si trovò a passare nei pressi della casa di Ipazia e notò un assembramento di carri, lettighe e guardie: si rese conto che da Ipazia, donna famosa in città, si recava anche il medesimo prefetto che a lui invece aveva negato l’alleanza.
Mancano informazioni sulle cause di ciò che accadde, le ipotesi alludono a una persecuzione religiosa nei confronti di una donna che aveva osato diventare filosofa e matematica e, peggio ancora, si permetteva di insegnare; altre ipotesi attribuiscono a ragioni politiche, vista la vicinanza al prefetto imperiale, la fine di Ipazia. Un giorno del marzo 415 un gruppo di parabolani (una confraternita cristiana che, tra le altre cose, fungeva anche da guardia del corpo del vescovo), guidati da un certo Pietro il Lettore, sequestrò Ipazia e la portò in una chiesa dove prima fu barbaramente torturata e poi uccisa, impiegando strumenti taglienti, pezzi di vetro o di conchiglia. I suoi resti furono bruciati in una località, il Cinarone, forse assegnata allo smaltimento di materiale di scarto.
Ipazia aveva autorevolezza, cultura, superiorità morale e intellettuale. Era una donna che, per il solo fatto di esistere e insegnare con successo, aveva attirato su di sé le invidie e l’insicurezza di alcuni uomini. Ma soprattutto Ipazia usava la razionalità, la cultura e la pace – che cos’è l’insegnamento della scienza e della filosofia se non pace? – in opposizione all’aggressività della lotta politica, dei contrasti tra religione e Stato, delle logiche del potere.
In apparenza la sua fu una sconfitta: Ipazia perse la vita in modo brutale e di lei restano poche tracce. Tuttavia non sono certo che possa definirsi una sconfitta l’avere attraversato i secoli ed essere diventata, oggi più che mai, un esempio di quanto una donna sia in grado di fare grazie all’amore per lo studio, per la filosofia, per la scienza.
Il filosofo neoplatonico Damascio ne scrisse la biografia, dove si legge:
Ipazia fu di natura più nobile del padre, non si accontentò del sapere che viene dalle scienze matematiche alle quali lui l’aveva introdotta, ma non senza altezza d’animo si dedicò anche alle altre scienze filosofiche.
Damascio attribuì chiaramente al vescovo Cirillo la responsabilità dell’omicidio di Ipazia:
Accadde che il vescovo, vedendo la gran quantità di persone che frequentava la casa di Ipazia, si rose a tal punto nell’anima che tramò la sua uccisione, in modo che avvenisse il più presto possibile.
Di Ipazia hanno scritto anche Voltaire, Diderot, Proust, Péguy, Leopardi, Pascal; nel 2009 il film Ágora di Alejandro Amenábar ne ha ricostruito la vicenda storica e umana.
Maria Gaetana Agnesi
Nata il 16 maggio 1718, Maria Gaetana Agnesi è ricordata per la straordinaria intelligenza e gli studi inusuali per una donna in quel periodo storico. Crebbe in un ambiente favorevole, perché il padre, commerciante, aprì la propria casa a intellettuali di alto livello e ne fu mecenate: Maria Gaetana ebbe così eccellenti insegnanti, che frequentava con regolarità; cultura, studio e religione furono le sue più grandi e costanti passioni.
Scrisse molto, avendo soprattutto la matematica come principale ambito di studio; nel 1738 pubblicò una raccolta di Propositiones philosophicae, 191 tesi dove le scienze venivano presentate secondo una prospettiva in cui solo quelle matematiche consentivano una «conoscenza certa» e una «contemplazione intellettuale» infusa di spirito religioso.
Le sue pubblicazioni avevano un intento divulgativo e didattico: con uno stile chiaro e semplice erano l’espressione dell’appartenenza al cattolicesimo illuminato e della volontà di comunicare a un più vasto numero di persone, abbattendo ogni barriera culturale. Socia di varie accademie scientifiche, nel 1748 fu accolta all’Accademia delle scienze di Bologna. Papa Benedetto XIV le assegnò l’incarico di lettrice onoraria di matematica all’università di Bologna (negli stessi anni tra i docenti a Bologna vi furono altre donne celebri come Laura Bassi): Maria Gaetana accettò ma non svolse il proprio incarico, dedicando sempre più tempo alla contemplazione e alla vita spirituale e prestando assistenza nel reparto femminile dell’Ospedale Maggiore di Milano, fino ad abbandonare l’attività scientifica poco dopo la morte del padre, nel 1752. Si trasferì all’Ospedale Maggiore e successivamente diresse il reparto femminile del Pio Albergo Trivulzio, diventando nel 1768 «priora della dottrina cristiana». Morì nel 1799.
Maria Gaetana Agnesi fu un esempio di vivacità intellettuale, di estrema curiosità (pare che già da bambina dilettasse i frequentatori del salotto del padre con dissertazioni e traduzioni dal latino) e di voglia inesauribile di andare incontro agli altri. I suoi studi, e ancora di più i numerosi scritti, si ponevano l’obiettivo evidente di coinvolgere chi non aveva una formazione scientifica, indirizzandosi alle fasce di popolazione meno fortunate: rendendo facile ciò che nella lingua latina appariva incomprensibile, optando per uno stile narrativo molto semplice, Maria Gaetana porgeva i contenuti della scienza, della matematica, della fisica a chi diversamente non avrebbe potuto comprenderli. E il desiderio di avvicinarsi al prossimo si rese poi ancor più evidente con la scelta di dedicare tutta se stessa all’aiuto dei bisognosi e dei sofferenti.
Non è raro che chi ha la capacità di comunicare con semplicità anche i contenuti più difficili si dedichi ad aiutare concretamente coloro che soffrono. Scrittura e comunicazione, infatti, possono essere canali straordinari per donare sollievo e speranza, per sollevare chi ancora è vittima dell’ignoranza, coniugandosi con un sano impegno nell’assistenza ai malati, ai bisognosi, ai sofferenti.
Sono convinto che la cultura sia uno strumento di pace, indispensabile per reagire nel modo giusto alle avversità: è dovere di ognuno di noi condividere ciò che sa e ha acquisito con l’esperienza, per sottrarre all’ignoranza e al disagio chi ancora non ha avuto la fortuna di evolvere. La cultura è e deve essere sempre di più uno strumento di pace.
Nell’ottica di una risposta positiva alle provocazioni, nei modi in cui si reagisce ai dolori e ai traumi della vita, avere cultura e condividerla con gli altri significa abbandonare una parte del proprio egocentrismo e capire che il senso di sé sta nell’aiuto, nell’andare verso il mondo senza rimanere fermi in una realtà piccola con confini rigidi e limitati.
Frida Kahlo
Che l’amore sia la massima forma di pace credo non sia in dubbio. Amare con passionalità e totale dono di sé, amare senza coinvolgimento del corpo e in modo spirituale, amare con l’attenzione al bene dell’altro; amare, insomma, non proiettare un bisogno oppure inventarsi una forma di sentimento perché così vuole la società o così ci hanno abituati a fare: l’amore si riconosce da quella spinta inarrestabile verso il bene e dalla totale gratuità. L’amore è pace, l’amore è il motivo primo e unico per la pace.
Forse sembra strano che un uomo parli di amore e ne sottolinei l’importanza, ma questo è uno dei doni più grandi che ho ricevuto dagli esempi femminili. Dalle mie pazienti, prima di tutto, che così spesso mi hanno mostrato quanto la loro vita avesse senso, durante e dopo una malattia tumorale, proprio grazie all’amore: non necessariamente l’amore all’interno di una coppia, ma l’amore in sé, a priori. Per i figli, per un’idea, per una passione, per un talento, per persone al di fuori del piccolo nucleo familiare, per un lavoro, per animali da accudire… Negli ammalati l’amore stimola la ripresa fisica e psichica, e l’accettazione di condizioni di vita forse non ottimali, sufficienti però per sopravvivere e per dare libero corso a relazioni e impegni fondamentali per la persona.
Ricordo la donna che per amore dei tre figli adottivi (lei era da sola, abbandonata dal marito poco dopo la diagnosi di tumore al seno) volle che «mi impegnassi al massimo» per guarirla in fretta e bene, e mi chiese di farlo per loro, per i tre bambini che amava con tutta se stessa. Traeva gioia e benessere psichico da questo amore; nonostante le difficoltà era ciò che la teneva in piedi e le dava significato, e mentre ne parlava lo si percepiva chiarissimo nelle sue parole e nella luce del suo volto. È ovvio che non fosse necessario chiedermi di impegnarmi al massimo, lo faccio sempre, ma ciò mi commosse in modo speciale. Oggi quella donna è sana e i figli sono grandi: ancora me ne parla con lo stesso amore e ne è ricambiata di cuore. Adesso che sono adulti, sono i figli che fanno a gara per coccolarla, per non farle mancare le gratificazioni che a lungo non ha avuto.
Sono storie piccole, semplici, che hanno riempito la mia memoria e mi hanno rafforzato ogni giorno di più nella decisione di andare avanti nonostante le difficoltà, nonostante a volte ci fossero ostacoli da superare. Di fronte alle provocazioni, davanti a persone che non comprendevano il senso della mia battaglia per la salute e la qualità della vita delle donne con tumore al seno, non ho mai reagito. Di fronte agli sgambetti professionali – che come tutti ho ricevuto qua e là – ho preferito tacere (ma non dimenticare), fare tesoro dell’esperienza andando avanti ostinato. Perché? Perché credo che la nostra mente sia capace di tanto, anche di cogliere i dettagli di una frustrazione, rielaborandoli e condizionando il nostro comportamento successivo in senso positivo, ma anche perché amavo e amo ciò che faccio. Anche per me, uomo, l’amore è dunque la risposta giusta.
Frida Kahlo fu una donna capace di amare con tutta se stessa. Sfogliando per l’ennesima volta il suo diario, mi sono intenerito e commosso di fronte alle pagine che gridano l’amore per Diego Rivera; mi sono sentito coinvolto nei ringraziamenti continui a tutto: grazie alle persone, grazie alla vita, grazie alla scelta politica, grazie alla Terra, grazie al Sole… Sono le parole di una donna che ama ed è grata, nonostante la sorte non sempre sia stata generosa con lei. Parla dell’imminente amputazione della gamba destra e si dice preoccupata, ma quell’amputazione sarà per lei anche una liberazione; scrive il diario e disegna, dipinge, lo riempie di sé e delle emozioni, dei sentimenti che prova. Lo rende vivo oggi, a distanza di anni, rivelandoci che si può essere pieni di luce anche quando si sta per morire, anche quando si scopre un tradimento del proprio compagno, anche quando i nostri ideali non trovano una realizzazione concreta. Si può essere vivi e dare vita perché si ama in modo appassionato.
C’è un altro motivo, più difficile da spiegare ma altrettanto forte, per cui Frida Kahlo mi pare un ottimo esempio di come si possa reagire in modo pacifico e positivo alle avversità: lei, che aderì a tredici anni alla Gioventù comunista ricordando lo «straordinario suono delle pallottole» della Rivoluzione messicana (la lotta contadina di Zapata contro le forze di Carranza), che cambiò il proprio nome in Frida e tentò addirittura di spostare la propria data di nascita al 1910, affrontò gli eventi della vita con una straordinaria capacità di remissione, di pace, di adattamento. Accettò, pur protestando in maniera evidente nelle sue opere, il proprio destino e la società in cui viveva.
Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón nacque il 6 luglio 1907 a Coyoacán, in Messico, e nel 1913 fu colpita da poliomielite: la gamba destra ne fu irrimediabilmente compromessa e da lì iniziò per lei il calvario delle lunghe immobilità a letto, spesso ingabbiata in tutori che limitavano quasi del tutto i suoi movimenti. Nel 1922 incontrò Diego Rivera, l’amore della sua vita, e lo affascinò con il carisma che successivamente le attribuirono tutti coloro che la conobbero anche una sola volta; la loro storia d’amore, però, non nacque subito. Ci furono per Frida anni di formazione artistica: benché rifiutasse l’idea di una propria vocazione letteraria, pubblicò un componimento poetico, mentre l’interesse per le arti figurative crebbe con una velocità incredibile. Nel 1925 fu vittima di un gravissimo incidente stradale: mentre viaggiava su un autobus, questo fu investito da un tram e lei venne trafitta da un’asta metallica. Le numerose fratture alla colonna vertebrale, alla pelvi e alla gamba sinistra la costrinsero al ricovero per tre mesi, immobilizzata nella sede della Croce Rossa e in condizioni assai precarie, dato che la Croce Rossa era molto povera. Anni dopo, ricordando l’incidente e i danni subiti da un corpo già provato dalla poliomielite, Frida disse: «Amo molto le cose, la vita, la gente. Non voglio che la gente muoia. Non ho paura della morte, però voglio vivere».
Sposò Diego Rivera nel 1929: lei aveva ventidue anni, lui quarantatré. Diego fu espulso dal Partito comunista perché accusato di collaborare con il governo messicano dipingendo le scale del Palazzo Nazionale, e anche Frida lasciò il partito. Nel 1930 si trasferirono per quattro anni negli Stati Uniti: in questo periodo per Frida le prove furono tremende, perché ebbe due gravidanze che non riuscì a portare avanti a causa delle precarie condizioni del bacino e ne soffrì enormemente, ma patì anche per l’incontro-scontro con la società americana (che chiamava «Gringolandia») e per le incomprensioni nei confronti dell’arte di Diego, cui fu addirittura chiesto di cancellare la raffigurazione di Lenin dal murale realizzato per il Rockefeller Center. Diego rifiutò e la commissione gli fu revocata; pochi giorni dopo perse anche un’altra commissione già ottenuta per un murale all’Esposizione universale di Chicago. Frida si batté per suo marito, voleva che la sua arte venisse riconosciuta e che nessun ostacolo gli impedisse di dimostrare al mondo il proprio valore; non si aspettava certo che nel frattempo Diego avesse intrecciato l’ennesima relazione con un’altra donna (questa volta si trattava dell’assistente Louise).
Le opere di Frida raccontano gli aborti, il corpo straziato, l’amore per Diego e il grande mistero della relazione con la società americana, attraverso i toni vividi e il tratto del sogno, con i colori tipici della sua arte. In particolare, nei suoi disegni e nei suoi dipinti mi ha sempre impressionato l’ostinazione sui dettagli anatomici che riprendono l’ossessione dell’aborto e della gravidanza: il corpo e il suo funzionamento, il corpo deturpato eppure così desideroso di donare vita, di riempirsi di vita, di distribuire amore ed esistere. Nonostante tutto, nonostante la malattia, il dolore e le deformazioni che nel tempo provocavano una sofferenza che si faceva sempre più pesante.
Nel 1934 Frida e Diego tornarono in Messico. Le relazioni di Diego con le sue modelle continuavano, e per Frida fu un colpo molto duro scoprire che la nuova passione era per sua sorella Cristina (la sorella prediletta). Si allontanò per un periodo, poi tornò da lui: non potevano fare a meno di amarsi, si sentiva legata per la vita all’uomo che per lei era così importante. Negli anni successivi anche Frida ebbe alcune relazi...