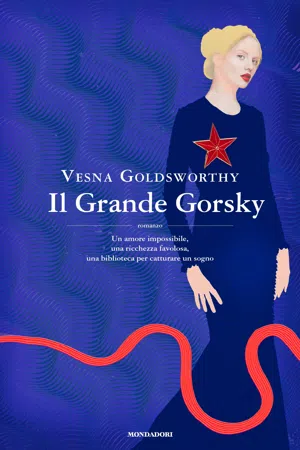Era uno di quegli affari che capitano una volta nella vita, se si è fortunati.
E fu accompagnato da un anno di ricevimenti elettrizzanti: un anno inatteso, immeritato, differente da quel che avevo vissuto in precedenza. Poi tutto finì e io dovetti tornare a essere quello che ero stato, in un luogo diverso, dove si parlava una lingua diversa. Fu Gorsky a cambiarmi la vita.
Ricordo la sua prima visita in libreria. Era impossibile non notarlo, persino in una città come Londra, in cui milioni di persone fanno di tutto per attirare l’attenzione e la gente rivela il suo esibizionismo anche quando cammina, come se fosse sempre sul punto di essere immortalata in un video per Youtube. Lui era speciale, ma in un suo modo quieto: era straniero, abituato al lusso, sembrava fermo anche quando si muoveva e teneva il suo volume personale perennemente abbassato. Il viso era equino e aristocratico, vagamente malinconico, e i suoi abiti di lana pettinata, confezionati su misura, erano così inglesi da farmi pensare, all’inizio, che fosse prussiano.
Sono molti i principi tedeschi che si dilettano di antichità e di arte nelle zone di Knightsbridge e Chelsea, e capita spesso che questi von Questo e von Quello oltrepassino i limiti stabiliti dalle loro magre finanze quando si tratta di abbigliamento. Lui possedeva miliardi, più di quanti chiunque sarebbe riuscito a spendere nel corso di una vita e ben oltre il necessario. Impersonava alla perfezione il suo personaggio, ma bisognava essere particolarmente attenti per accorgersene. I suoi soldi non gridavano, ma sussurravano, in sintonia con il fruscio del miglior cotone egiziano, del cachemire più raffinato, del cuoio più morbido, del ticchettio dell’orologio in platino dotato del meccanismo più preciso esistente al mondo. Aveva un tale numero di vestiti pressoché identici, tutti confezionati a Savile Row, che poteva permettersi di eliminarli come fazzolettini usati. Non me lo immaginavo a ordinare che venissero portati in tintoria. E nonostante trascorressi gran parte delle mie giornate a guardare fuori dalla vetrina, cercando di indovinare da dove venissero i viandanti occasionali che mi vedevo passare davanti, non mi sfiorò mai il sospetto che il suo paese d’origine fosse la Russia. Non tanto perché la sua bellezza iperborea mal si adattava alle paludi ghiacciate dell’estuario della Neva. Qualcosa di più indecifrabile nell’insieme dei suoi lineamenti mi indirizzava verso la vecchia Königsberg. Sottile e cesellato come un alto vaso di cristallo, con gli occhi azzurri un po’ troppo vicini al lungo naso dritto, il suo viso lo faceva sembrare più alto di quanto non fosse, una creatura appartenente a un’altra epoca – il migliore amico di Ernst Jünger, un baltico errante, o il tedesco con cui Byron aveva avuto un intenso scambio epistolare, dipinto da Caspar Friedrich mentre si volta lentamente verso chi guarda, ancora immerso in qualche profonda riflessione sul mare gelato che era rimasto a scrutare fino a un attimo prima.
I russi erano più solidi, muscolosi, grezzi, anche quando erano attraenti. Non mi riferisco ai russi in generale, naturalmente, ma a quelli che vivono, in una sorta di aggregazione spontanea, nella manciata di quartieri londinesi caratterizzati dalla presenza di grandi ricchezze e che appartengono alla generazione dei baby boomer, come viene definita in Occidente. In Russia il tracciato delle loro vite aveva percorso un cerchio. Erano cresciuti in appartamenti condivisi con altre famiglie, avevano fatto miliardi grazie al petrolio o a truffe sofisticate, li avevano spesi in case, cavalli e puttane, di tanto in tanto anche per pagare un killer, e alla fine erano tornati a giocare a carte insieme, esattamente come succedeva nei tempi bui del comunismo, solo che ora erano circondati da plotoni di guardie del corpo. Avrei dovuto indovinare che era ebreo. Ma questo particolare importava più a lui e a Natalia Summerscale di quanto importasse a me. Loro erano russi, io no.
Io provengo da una nazione piccola e insignificante, situata in un angolo altrettanto insignificante d’Europa, e la cosa non mi dispiace affatto. All’interno di questa storia la mia nazionalità è del tutto irrilevante, perché non sono né inglese né russo, e se ha qualche importanza è solo perché, dopo i fatti accaduti, era l’unico elemento che si presentava di continuo nelle didascalie che accompagnavano le foto sgranate in cui eravamo ritratti insieme, e anche quelle in cui figuravo da solo, come se fosse la mia caratteristica più rilevante, mentre era quella a cui non ricorrevo mai per descrivermi. La verità è che potrei essere definito un rotolacampo, una di quelle piante che, giunte a maturità, si staccano dalle proprie radici e rotolano via, sospinte dal vento. La condizione dell’esiliato, che avevo volontariamente scelto, non era del tutto spiacevole.
Ora mi sembra che tutti quei mesi, a Londra, siano stati freddi come un interminabile novembre. I miei ricordi sono vivi, ma si rifiutano di obbedire al calendario. L’Inghilterra non offriva delle differenze stagionali a cui uno potesse ancorare la memoria. I pochi squarci di azzurro avrebbero potuto appartenere a un quadro di Constable o di Turner; spesso si andava alle mostre per sfuggire all’acquerugiola incessante. Pioveva di continuo e gli unici cambiamenti climatici si verificavano quando la pioggia si trasformava in nevischio. C’erano volte in cui, andando al lavoro, alzavo gli occhi sulle nuvole che incombevano basse sopra i giardini inzuppati d’acqua e dietro vi intravedevo una sfera: un sole precoce o una luna tardiva, impossibile dirlo, appesa lì, come una falsa promessa. Anche la primavera sembrava l’“inizio anticipato dell’inverno”, come tutti dicevano scherzando. In quell’anno privo di stagioni la gente entrò più del solito in negozio. Entrava, rabbrividiva, faceva qualche commento sul tempo, poi si metteva a fissare i dorsi dei libri sugli scaffali finché non si era scaldata o finché non trovava un titolo che le interessava. A questo punto sfogliava il libro, prendendo nota mentalmente di ordinarlo online. Nonostante costasse ottomila sterline al mese solo di affitto, la libreria di Fynch fungeva essenzialmente da showroom per il mercato digitale. Erano in pochi ad acquistare qualcosa, forse spinti dal senso di colpa, prima di rituffarsi sotto la pioggia. Spesso quei pochi si limitavano a una cartolina oppure, se si sentivano in vena di spendere, a uno di quei volumetti smilzi di poesia, la cui tiratura è così modesta che le librerie online non si curano nemmeno di scontarne il prezzo. Nonostante il magro raccolto gli affari prosperavano, anche se di poco e solo se paragonati ai nostri abituali risultati estivi che, per essere franchi, erano tutt’altro che entusiasmanti.
Fynch non è il genere di libreria dove la gente va a rifornirsi di romanzi da leggere in spiaggia, a meno che non si tratti di una spiaggia privata. Senza contare che è fuori dai sentieri battuti, visto che è situata in una di quelle viuzze laterali dove non esistono altri negozi e il passaggio è pressoché inesistente. Solo qualcuno che non avesse alcun interesse a vendere seppellirebbe una libreria in una fila di case che un tempo erano state scuderie, collocate in quella terra di nessuno che sta tra Chelsea e Knightsbridge, regno di arredatori e di abitazioni raffinate, all’interno delle quali la quantità di volumi patinati lasciati in esposizione sui tavolini supera di molto quella degli altri libri. E si tratta di dati reali, non sparati a caso.
Ovviamente nella “vecchia Chelsea” ci sono delle eccezioni. Per inciso, la “vecchia Knightsbridge” non esiste più, a meno di non includervi la prima ondata di kuwaitiani, che tuttavia sono stati estromessi dal tipo di persone per cui il sorbetto al limone è ora un prodotto più interessante del petrolio. La “vecchia Chelsea”, invece, di cui fanno parte i clienti abituali di Christopher Fynch, è inglese fin nella biancheria intima, rigorosamente acquistata da Mark & Spencer. I suoi componenti impiegano le ultime monetine rimaste nel fondo per le piccole spese, residuo dei tempi d’oro dell’impero, in cose che di tanto in tanto includono anche l’acquisto di un libro. Non che io preferisca la “vecchia Chelsea” alla nuova, dove la signorilità è stata usurpata da europei e nordamericani, ma sono etnicamente predisposto a un certo sentimentalismo nei confronti di una collettività così stupida da farsi cacciare dalla sua terra. È una razza in via d’estinzione, la “vecchia Chelsea”, e si estinguerà ben presto, così come, nella nostra libreria, si esauriranno gli ordini riguardanti le biografie del visconte Tale o del cardinale Talaltro, o le conversazioni su Martin Amis, visto come un giovane scrittore osé. Già da ora, i figli della “vecchia Chelsea” preferiscono avere l’aria degli arricchiti, anche se non hanno il becco di un quattrino.
La mattina in cui mi aveva chiesto per la prima volta se non mi dispiaceva scambiare due parole – se non mi dispiaceva?! – l’avevo guardato emergere da una lunga Bentley argentata o da un veicolo simile, il tipo di macchina sufficientemente corazzata per resistere a un attacco sferrato con granate anticarro. Non avevo previsto che si dirigesse verso la libreria. Era rigido ed esitante, un occhio parzialmente chiuso mentre ispezionava l’insegna, come se sull’altro portasse un monocolo. Nonostante dovesse aver fatto più acquisti di chiunque avessi mai incontrato, non riuscivo a immaginarlo alle prese con lo shopping. Rimasi a osservarlo, senza riuscire a credere che stesse per entrare, attraverso la vetrina rigata di pioggia dietro la quale stavo seduto per ore al mio tavolo, ingombro di ricevute scritte a mano come piaceva alla “vecchia Chelsea” e piazzato sotto un manifesto che chiedeva ai clienti di sostenere la loro libreria di zona, che per giunta era una libreria indipendente. Indipendenti eravamo, e anche un po’ troppo diligenti perché, nonostante il disordine che faceva pensare a una frenetica attività, riuscivo a leggere un paio di libri al giorno, anche nelle giornate più impegnate. Non mi sarei mai aspettato di avere a che fare con i cosiddetti poteri forti, ma tutto in quest’uomo – da come era sceso dall’automobile, dando rapide istruzioni all’autista impeccabilmente vestito che gli teneva aperta la portiera, al suo indugiare incerto tra gli scaffali mentre terminavo una transazione di poco conto, conversando con uno dei nostri affezionati clienti del mattino, fino al modo in cui mi aveva rivolto quel “se non le dispiace” – tutto in lui parlava di potere e denaro.
I clienti del mattino erano essenzialmente signore che sfoggiavano acconciature di un candore abbagliante simili a caschi, che si svegliavano alle cinque e che amavano leggere romanzi su zitelle acculturate scritti da persone come Anita Brookner o Salley Vickers, con cui si identificavano interamente, anche se loro zitelle non erano. Solo la moglie di un banchiere poteva permettersi di vivere da sola in questa zona della città e alcune di queste vecchie cornacchie erano rimaste vedove più di una volta, sempre di un banchiere. Si divertivano a parlare con me, ingannando una mezz’ora prima di prendere l’ascensore che le avrebbe portate al caffè all’ultimo piano di Peter Jones, dove avrebbero trascorso il resto della mattinata. Il fatto che fossi straniero rappresentava un vantaggio ai loro occhi, perché le autorizzava a indottrinarmi sulle abitudini degli inglesi, nonostante nell’Inghilterra odierna si sentissero sperdute quanto me. Erano le mie migliori clienti. Non acquistavano mai i libri online, non perché avessero qualcosa contro Internet, ma perché ignoravano che fosse possibile farlo.
Non ero certo un libraio di nobile stirpe, nonostante facessi molti sforzi per accreditare l’idea. Ero arrivato in Inghilterra all’inizio degli anni Novanta per evitare il servizio militare. Avevo un dottorato in letteratura inglese, conseguenza di una forma di anglofilia platonica contratta quando avevo vent’anni, un virus portatore di inganni, perché la mia mediocre tesi di dottorato su William Hazlitt era stata priva di utilità persino nel mio paese, figurarsi a bordo della “nave scuola britannica” dove i dottorati in letteratura inglese si sprecavano e Hazlitt non era che un vecchio arnese, travolto dalla moda degli studi postletterari infarciti di “ismi” e di teoria. Ero arrivato a Londra in qualità di rifugiato con un mare di altri rifugiati, un’ondata che partiva dai Balcani lacerati dalla guerra per andare a infrangersi sulle bianche e porose scogliere di Dover. Quelli che alludono a una generazione perduta quando parlano di Hemingway o di Fitzgerald non hanno chiaro il significato di “perduto”.
Il mio passaggio da là (il bilocale dove vivevo con la mia famiglia in un mostro di cemento alla periferia della capitale, e soprattutto il momento in cui il postino aveva suonato alla porta per consegnare i documenti con cui venivo richiamato al servizio di leva, fissato per sempre dalla Polaroid della mia memoria) a qui (la libreria di Christopher Fynch a Chelsea in una deprimente e piovosa mattina) aveva comportato un certo numero di bugie, la prima, ma non ultima, delle quali era stata detta da mia madre, quando aveva sostenuto che ero già fuggito. La bugia aveva accompagnato il suo rifiuto deciso, e ripetuto per ben tre volte, in stile biblico, a firmare le carte in mia vece.
Chi avrebbe mai pensato che sarebbe stata capace di disobbedire allo Stato? Sembrava fragile come una foglia al vento e non sapeva nemmeno che il cancro la stava divorando quando mi aveva accompagnato in macchina al confine con l’Ungheria, la notte successiva. Molti di quelli che erano rimasti a combattere disprezzavano la gente come me. Ci chiamavano le “spose fuggite”. Mia madre, dimostrando un coraggio da leone, disse che avrebbe preferito non vedermi più che vedermi con un’arma in mano. Il suo desiderio fu soddisfatto.
Ora che ci ripenso, il tragitto fino a Londra fu relativamente semplice. La morte dei miei genitori, avvenuta poco dopo, e la conseguente vendita della loro modesta abitazione in cambio della somma principesca di diecimila euro – l’unico capitale che ho mai posseduto – non fecero che rafforzare la mia capacità di liberarmi dalle pastoie dei sentimenti, un talento altrettanto utile quanto quello di sganciarsi dalle proprie radici. Da questo punto di vista ho sempre avuto un gran culo, se mi passate l’espressione.
Dopo aver dilazionato la fine degli studi il più a lungo possibile per rimandare la sfida di un impiego retribuito e la conseguente disciplina a cui avrei dovuto assoggettarmi, scoprii di avere poche ambizioni. Che si ridussero ulteriormente durante il viaggio in traghetto dall’Olanda, dove avevo soggiornato per un paio di giorni nella casa di un compagno di scuola, che a Belgrado aveva fatto il pittore di murales e in Olanda era diventato imbianchino. Amsterdam era piena di renitenti alla leva provenienti dai Balcani, perennemente strafatti di fumo legalizzato e dipendenti dalla reciproca compagnia. Se avessi avuto una qualsivoglia abilità manuale, anch’io sarei rimasto sul Continente.
Quando ottenni il permesso di lavoro, approdai al commercio dei libri del tutto casualmente, così come – prima dell’esito scontato della richiesta di permesso – ero approdato a Eaton Square, in un appartamento su due piani appartenente alla moglie inglese di un banchiere americano che voleva un ragazzo alla pari per i suoi tre gemelli, frutto della fecondazione in vitro. Gli au pair di sesso maschile erano molto in voga al momento. Il lavoro non richiedeva alcuna qualifica, ma lei era convinta che il mio dottorato sarebbe stato un ottimo complemento alle cure che venivano già fornite da una tata filippina, molto devota ma del tutto incompetente sul piano linguistico. Io accompagnavo i ragazzi a scuola e li portavo a giocare a calcio a Hyde Park. Ci piacevamo reciprocamente, ma senza alcun attaccamento. Alla fine del mio incarico, continuai a vederli di tanto in tanto, quando venivano a trovare i loro genitori da Oxford, da Princeton o da Brown. Amavano leggere, a differenza di mamma e papà. Capitavano in negozio e mi si rivolgevano con effusioni cameratesche tipicamente americane. Tutti i ragazzi inglesi vorrebbero essere americani, di questi tempi, e i tre, comunque, preferivano il padre alla madre.
Cominciai a lavorare per Christopher Fynch nel 1995. Christopher era un libraio gentiluomo. Un gentiluomo sempre e un libraio per quelle due o tre ore in cui si faceva vivo per vedere come me la cavavo. Mi pagava un’inezia, ma era tutto quello che poteva permettersi e in seguito divenne persino troppo. Andavamo d’accordo. Era rimasto vedovo nel 1987 e non aveva figli, a parte una figliastra poco più giovane di lui che viveva a West Hampstead. Una volta mi spiegò che “era tutta colpa degli orecchioni”, ma dubito che avesse mai provato il desiderio di fare figli, così come non so dire, nonostante il matrimonio con una donna che aveva diciotto anni più di lui, se fosse omosessuale o eterosessuale. Senza essere ascetico (il tavolo riservato al Poule au Pot e la sua mezza bottiglia di Bordeaux ne erano la prova), per tutto ciò che riguardava anche lontanamente il sesso era quel tipo di uomo un po’ fuori dal mondo per cui era stata formulata l’idea stessa di celibato. Io gli piacevo e lui piaceva a me, ma non mi sfiorò mai l’idea che avrebbe potuto nominarmi suo erede. Non ho un animo mercenario e comunque c’era poco da ereditare.
Il nostro sodalizio rimase sempre incerto, come il tempo in Inghilterra, fino al giorno in cui comparve Gorsky con la sua proposta. C’era qualcosa di così ovvio nel suo aspetto, in quella sua aria solitaria e taciturna che, sin dal primo giorno, lo chiamai con l’appellativo di “Grande Gorsky”, un accostamento ideale al Grande Gatsby, nelle e-mail che scambiavo con Fynch. Il mio capo era un appassionato scrittore di e-mail, nonostante il suo atteggiamento tecnofobico da vecchio studente di Eaton. Le e-mail, o e-pistole, come le defin...