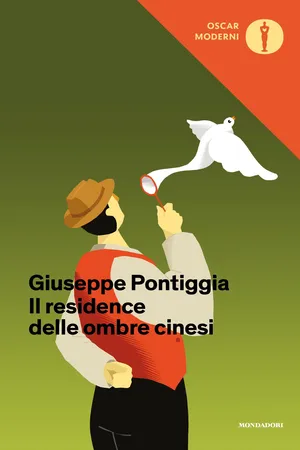Definire significava originariamente, nel lessico prevalentemente agricolo dei Romani, porre dei confini (fines), delimitare un campo, stabilire una separazione tra quello che stava dentro e quello che stava fuori. La parola passò presto dall’uso letterale a quello metaforico e, come tutti i termini che indicavano dapprima attività materiali, si prestò ottimamente a essere impiegata per quelle mentali. Essa ha però conservato, anche negli usi traslati della critica letteraria, soprattutto di quella “militante”, una certa connotazione di pericolosità, una sfumatura vagamente minacciosa e limitativa, anzi questa aura, al di là degli impieghi ovviamente legittimi, è quella che assicura non solo la fortuna del termine, ma la fortuna dell’operazione che esso designa: che è di circoscrivere il testo con una formula, sottrarlo al suo limbo inquietante e riportarlo nell’alveo del già noto. In definitiva, aggirare, rimuovere e superare. Esagero, naturalmente, ma non troppo. Basterà pensare, come argomento a contrario, al destino tormentato di quegli scrittori che, per origine, formazione o anche puro talento, non si prestano a essere immediatamente deposti nei colombari e nei loculi dei cimiteri della critica e sono costretti a vagare, come l’ombra di Patroclo, intorno alla dimora di Ade, in attesa di una regolare sepoltura (è stata la sorte di alcuni tra i nostri migliori, da Svevo a Pea, da Tozzi a Delfini a Savinio).
Il caso di Porta è piuttosto complesso e singolare. La “definizione” (novissimo, sperimentale, Gruppo 63, neoavanguardia) ha favorito sin dall’inizio la sua affermazione, soddisfacendo in via diretta quel bisogno classificatorio che in Italia è primario; anzi, per qualche aspetto, si può dire che l’abbia addirittura soddisfatto in anticipo, prima che esso si manifestasse: la notorietà di Porta risale infatti al ’61, quando suoi testi poetici e critici, insieme con quelli di Pagliarani, Giuliani, Sanguineti e Balestrini, appaiono nei Novissimi, quella raccolta di “poesie per gli anni ’60” nella quale Giuliani proponeva ed esemplificava un nuovo modo di sentire e di fare poesia, operando una riduzione dell’io lirico e attuando – mediante quell’attraversamento critico delle avanguardie storiche europee di cui aveva parlato Sanguineti – un rinnovamento radicale dei mezzi linguistici e espressivi. La presentazione da parte di Giuliani del “caso” Porta (linguaggio di eventi, tensione oggettuale dietro cui si cela un soggettivismo lacerato, cattolico indocile ossessionato dalla vista di un “male” che non riesce ad accettare) delineava con taglio sicuro una prima immagine critica. Anche gli interventi di Curi e di Sanguineti, che sottolineavano il primo il “felice errore” di Porta (la continua interrogazione di eventi e oggetti, per ottenerne una risposta impossibile), il secondo la dimensione psicanalitica (la cecità di Edipo, che coincide con la conoscenza), offrirono contributi preziosi e tempestivi all’approfondimento del ritratto. L’attività e le polemiche del Gruppo 63 caratterizzarono ulteriormente il territorio di Porta, anche se il suo apporto, più che teoretico, fu essenzialmente di testi, che inviò a Palermo nel ’63 e lesse a Reggio Emilia nel ’64 e a La Spezia nel ’66. Ora l’ideologia della neoavanguardia, la sua volontà di rompere gli istituti di una lingua mercificata per promuovere o accelerare lo sfacelo della società che la produce, trova certamente nel lavoro di Porta una sua esemplificazione: però, nel tempo, specie se acriticamente ripetuta, essa rischia di suggerire una interpretazione troppo univoca e uniforme. La stessa nozione di “sperimentale” va intesa, nel caso di Porta, come continua sollecitazione del linguaggio e dei ritmi secondo una precisa intenzione espressiva. Ma il termine si presta facilmente a ritorsioni da parte degli avversari e a ricatti da parte degli amici più radicali: di tali fraintendimenti ha subito il contraccolpo – sia detto tra parentesi – l’unico romanzo che Porta ha scritto, Partita, pubblicato nel ’67 e non adeguatamente apprezzato, in quanto o “troppo” o “troppo poco” sperimentale, mentre si tratta, a mio avviso, di uno dei suoi testi più felicemente realizzati e, in assoluto, di uno dei romanzi più vivi e intensi del decennio. Il risultato di queste reazioni e combinazioni è stata, negli anni successivi, una certa ripetitività della chiave interpretativa, che solo in tempi più recenti si è andata modificando, anche per una più mobile e articolata attenzione rivolta al suo lavoro sul piano del linguaggio da parte di lettori come Gramigna, Zanzotto, Agosti e Maria Corti, alla quale si deve una penetrante introduzione a Week-end. La pubblicazione di tutte le sue poesie assume quindi un rilievo particolare, consentendo di valutare, nella sua complessità, una delle esperienze poetiche più dense e ricche degli ultimi vent’anni, e non solo in Italia, e, al tempo stesso, di integrare certe prospettive e immagini critiche che, stimolanti all’epoca in cui vennero proposte – e rimangono del resto punti fermi di riferimento – andavano confrontate sia con l’evolversi della poesia di Porta (e alla luce che essa gettava anche retrospettivamente) sia con il modificarsi inevitabile della situazione storico-sociale e di quella critica.
La formazione di Porta avviene essenzialmente nell’ambito del “Verri”, la rivista milanese fondata da Anceschi nel ’56 che costituiva un polo di attrazione, un punto d’incontro decisivo per stimoli, contatti, verifiche. Non si può capire veramente l’uscita dei Novissimi senza porla in rapporto con un tessuto fitto di esperienze culturali, che si lasciano inquadrare entro coordinate abbastanza individuabili: sul piano filosofico la “riduzione dell’io” aveva una indiretta corrispondenza con la prospettiva fenomenologica di Husserl mediata dalla linea Banfi-Anceschi e trasposta da quest’ultimo in una ricchissima coscienza della lirica del Novecento, arretrata fino a Pascoli; sul piano della poetica la Linea Lombarda tracciata da Anceschi nel ’52, e che aveva il suo esponente più prestigioso in Sereni, suggeriva una “poetica degli oggetti” che si allargava alle esperienze di Pound e di Eliot e alla teoria del correlativo oggettivo. Porta raccoglie e pubblica nella Palpebra rovesciata (1960) le poesie da lui scritte in quegli anni. La violenza vi appariva calata nella cronaca quotidiana attraverso un montaggio espressionistico che ricorda tecniche di Grosz e di Beckmann, con connotazioni politiche:
Brucia cartucce in piazza, furente
l’auto del partito: sollevata la mano
dalla tasca videro forata.
Tra i giardini sterili si alza,
altissimo angelo, in pochi
l’afferrano e il resto è niente.
e razziali:
Cani azzannano i passanti, uomini
raccomandabili guidano l’assassino,
fuori, presto, scivoli.
Negri annusano il vento.
Già il titolo, La palpebra rovesciata, suggerisce uno stravolgimento della visione, l’atrocità di una offesa patita dallo sguardo. In Porta però questa offesa è priva di allusioni personali e autobiografiche. La soppressione dell’io, effettuata in nome della necessità eliotiana del poeta-oggettivo, lo conduce, secondo le sue stesse parole del ’61, alla “creazione del personaggio, del protagonista che, muovendosi tra le parole, si muove come noi idealmente ci muoviamo nella sfera della realtà, come vediamo che tutti si muovono, consapevoli o meno”. L’io dunque si trasforma in una specie di controfigura, di presenza anonima, di occhio dilatato, punto di vista e insieme figurazione. C’è, in tutta l’opera poetica di Porta, una continua connessione tra il vedere, il conoscere e l’angoscia. Per qualche aspetto essa può essere messa in rapporto con l’esigenza di superare, attraverso una visività impersonale, i residui dello psicologismo (il “Verri” pubblicava in quegli anni, oltre a Beckett, autore decisivo per Porta, i testi della scuola dello sguardo) ed è stata anche interpretata psicanaliticamente come regressione edipica. Tuttavia si ha sempre la sensazione di rimanere al perimetro del problema e non al suo centro. Il senso del tragico, che Porta stesso indicava, nel ’64, essere alla base di ogni sua operazione poetica, può infatti trovare in Edipo, “l’uomo sapiente, che si acceca”, una sorta di reincarnazione mitica e retrospettiva, purché però non se ne sottolinei tanto la matrice psicologica, quanto lo scacco teoretico finale, la cecità dopo la conoscenza, la disperazione di una conoscenza ulteriore cui si è volti continuamente. Questa tensione si rivela in maniera diretta nelle prime poesie:
Ma scoprire, almeno, è il fine dell’arte
l’immagine di uomo, noi
con dilatazioni febbrili e visionarie:
Al limite nuvole soffiano sugli alberi,
stridendo ruotano montagne; aggrappati
uomini dormono tra le rocce. Luci,
abetaie verso
Rimuovendo una educazione profondamente cattolica, Porta si converte all’immanente, agli eventi e agli oggetti, posti su un unico piano orizzontale. Non cessa però in lui quella interrogazione totale, alla quale la religione ha sempre offerto una sua risposta. Quella fisicità ossessiva, di cui hanno parlato Curi e Spatola, gli si rappresenta come “un muro da sbrecciare”, al di là del quale possono rivelarsi segreti. Il problema a questo punto non è di prospettare interpretazioni spiritualistiche o mistiche, che appaiono estranee o, per meglio dire, preliminari al mondo poetico di Porta. E neanche di considerare il suo interrogare un autoinganno, una contraddizione fertile, perché esso appare connaturato a tutto il suo lavoro, fino a oggi, seppure in forme continuamente diverse, ed è intrinseco anche alla suggestione che la sua poesia suscita nel lettore. Si tratta invece di accettarlo e di avvicinarne il significato. Forse può aiutare a capirlo l’esigenza di una autenticità totale, la nozione stessa di autenticità in quel senso particolare di cui parla Heidegger: non quella di cui chiacchierano la curiosità e l’equivoco, ma quella che si costituisce come radicale consapevolezza di sé e della propria morte – possibilità assolutamente certa e propria – e che quindi scopre l’orizzonte del mondo come angoscia; ma con pari intensità, proprio dalla certezza dei limiti temporali e dalla compresenza della morte, perviene a un riattivamento estremo delle energie vitali e all’acquisizione della libertà di scelta. Per questa via si può allora capire il fondamento della connessione tra vedere, conoscere e angoscia e anche le iterazioni agghiaccianti di certe immagini di Porta (Heidegger ci ha lasciato in Essere e tempo una straordinaria fenomenologia delle gradazioni dell’angoscia, dalla paura al terrore al raccapriccio). Porta proietta l’angoscia nella sofferenza più inesplicabile e irriducibile alla ragione teologica, la sofferenza degli animali:
Quel topo gli occhi aghiformi affilò
una veloce nuvola fissando che gonfiava salendo,
esplodeva sibilando nell’aria violenti pennacchi:
allo scoperto rimasto, topo del deserto, dall’attento
falco fu squarciato.
Alla indifferenza della natura l’uomo aggiunge un suo contributo peculiare, quello della crudeltà:
L’uccello il folto
dei cespugli obliò, un lunghissimo verme
succhiò dalle zolle: due amici monelli
appostati gli occhi riuscirono a forargli
sulla gola inchiodandogli la preda dal becco
metà dentro e metà fuori.
L’evocazione delle attività predatorie dell’uomo mette in luce la loro efferata violenza. Così lo scuoiamento del castoro:
In gola penetra scuotendo
le anche l’animale impellicciato,
dilata la bocca dell’esofago,
lo stomaco si distende, pronto
per essere venduto e lavorato
come pelle per guanti.
e la cattura della balena:
la gola
si torce, rigagnoli scendono sulle gambe,
la schiena del cetaceo splende
all’improvviso, incalziamo con gli arpioni
e primi si bucano i seni, seconde
le cosce lucide, e rovescia
il ventre, le braccia
allunga all’indietro: “Issiamola
a bordo, divoriamo!”
Questo indugio sulla crudeltà può essere certo ricondotto a pulsioni psicologiche, ma la sua tensione conoscitiva è appunto rivolta a quell’orizzonte di angoscia, insieme personale e di tutti, cui si richiama l’autenticità di Heidegger. Questo può contribuire a spiegare come la traumatica ed esasperata autenticità di Porta “cerchi” l’impassibilità per lasciare che gli eventi si svelino nella loro essenza atroce. La sua fuga dall’io è l’unico modo per ricuperarlo nella sua verità e la sua poesia adempie, per lui e per gli altri, questa funzione vitale. Il processo è tormentoso, avviene per straniamenti, allucinazioni, metamorfosi in animali:
Fui preso dal terrore divenendo lepre
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scivolo nuotando tra alghe pericolose.
Affondo in fitte vegetazioni, ricoperto
di formiche e di foglie. Mastico piume,
è quasi la conoscenza
Questo progetto di autenticità, che concepisce la poesia come modo di essere dentro il mondo, tiene sempre lontano il limite, in fondo ovvio, della impraticabilità e interroga ora gli eventi e le cose ora il linguaggio (secondo una divaricazione e una convergenza che la Corti ha messo lucidamente in evidenza nella sua introduzione a Week-end). Il fine però rimane identico ed è quello di vivere in un universo verbale che si possa riconoscere come assolutamente proprio, nel senso della autenticità, e che proprio per questo sia anche l’unico veramente partecipabile agli altri. Così in Zero all’azzeramento del discorso corrisponde l’azzeramento di un mondo falso e quindi soffocante, inabitabile, a cui l’autore vuole sostituirne un altro, che però è ancora indecifrabile, impensabile, costruibile solo per tentativi, spesso disperati, sarcastici, segmenti di frasi, tronconi, da cui si sprigiona un dinamismo tragico:
calo, vola per un istante, vola lungo il crinale, sopra la foresta, perde
nale, è scomparso sott’acqua, lo sentono nuotare, a piombo, ascoltano le
c’è, ora lo stanno ungendo, leccando, vogliono amarlo, dice, desiderano ve
eccolo, ferito ad una gamba, come si è ferito, ride, ricomincia, rifiuta
È la stessa via tentata in Aprire, del 1967, che nel suo cupo martellare su pochi elementi temat...