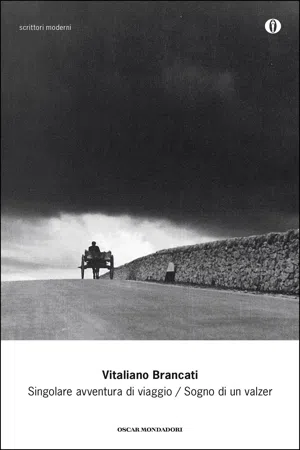I. Di un ballo, si sentiva veramente il bisogno. I forestieri, che soggiornavano a Nissa, per la più parte professori di scuole medie, magistrati e dirigenti sindacali, quando, alle dodici e tre quarti, con l’affrettata colazione mugolante nello stomaco, vedevano partire dalla stazioncina uno dei loro colleghi, finalmente trasferito a Palermo o a Catania, quando vedevano ristabilirsi, dietro l’ultimo convoglio, il nero del prossimo traforo, come la porta di un carcere che si richiudesse alle spalle di un liberato, di quali parole facevan vibrare lo stecchino che tenevan fra i denti? Su per giù di queste: «Dobbiamo organizzare un ballo!». Anche i giudici di tribunale che, le sere d’inverno, scendevano nel ristorante dell’albergo Villa Agonia con uno scialle da donna sulle spalle e lo zucchetto in testa, il che non impediva loro di baciare la mano alle signore, i giudici e il presidente e il pubblico ministero confessavano agli amici: «Un ballo ci metterebbe a contatto con le famiglie del luogo, che sono molto ospitali, ma non trovano mai l’occasione d’invitarci a casa. Le signore poi sono assai intelligenti!». E non s’ingannavano. Le signore e signorine di Nissa, quelle che a ogni principio di stagione si recavano a Palermo per scegliere gli abiti, talune pilotando di persona una macchina da corsa erano singolarmente intelligenti. Queste signore non erano molte, ma non erano nemmeno poche, come non sono molte né poche le famiglie benestanti delle piccole città siciliane. Non v’è dubbio, però, che, in altri luoghi, queste signore sarebbero state soltanto eleganti, e a Nissa erano anche intelligenti e colte. Le loro case, arredate con mobili di cui esse stesse avevano fornito il disegno, possedevano tutte una grande biblioteca. Era qui che le signore passavano una buona parte della giornata. Il telefono, quello col ricevitore verde e piccolo al pari di un giocattolo, derivato dal più grosso apparecchio nel quale parlava il marito, trillava tra i libri; la signora conversava con le amiche, accarezzando il dorso dei volumi, e talvolta aprendone uno e leggendo qualche pagina.
Lisa Martoglio, la più intelligente e colta fra le intelligenti e colte, aveva fatto portare un letto entro la biblioteca, si era chiusa per una settimana fra le scansie dei libri e, giorno e notte, aveva studiato e recitato, sola davanti a uno specchio, la parte dell’attrice in Trovarsi di Pirandello. Le signore e signorine adoravano Pirandello. Era da lui che avevano capito perché spesso si sentissero non una, ma due; era da lui che Anna Rosali, dopo una notte di rimorsi per essersi lasciata baciare da un amico del marito, aveva appreso, piangendo di tenerezza, di non essere colpevole, perché l’atto del giorno avanti ella lo aveva compiuto “come in sogno”. Era infine Pirandello che confortava queste care ragazze (giovanissime, le più) della maldicenza che le perseguitava, anche quando esse correvano lontano da Nissa, sole e scapigliate con la loro piccola fuoriserie. La maldicenza, dopo lo studio di Pirandello, veniva spiegata così: un cicaleccio di quel pauroso mistero che circonda gli uomini e per il quale ciascuno è mille, e anche centomila: dissimile da sé e quale l’altro lo crede. E le stesse lettere anonime al marito, ciascuna con un giudizio sul conto della signora, allineate sul tavolo, erano come una serie di specchi concavi e convessi, entro i quali la donna pensosa vedesse il proprio viso sfigurato in cento modi diversi.
Amica fidata di Lisa Martoglio era Maria Carnevale, una piccola signora, sulle cui labbra, serrate e sporgenti, si riversava, dalla fronte e dagli occhi, un’aria fra pensosa e assonnata. Amiche, ma non fidate, erano Giovanna Roccaraso, che guardava sempre con meraviglia, entro lo specchio della borsetta, le lunghissime e solenni sopracciglia sotto le quali aveva sempre dimenticato di avere gli occhi; Valentina Morello, che suonava il violino, lasciandolo, alla fine del concerto, bagnato di lacrime; la giovane dottoressa Elena Caruso, che aveva acquistato un cane a Parigi e che, in una stanza semibuia, alla presenza di due forestieri, aveva eseguito, senza scarpe, una danza classica.
In inverno, le amiche si riunivano nel salotto e, in estate, nella terrazza di Lisa Martoglio. Talvolta a queste riunioni partecipavano i mariti e i fratelli, ma essi erano più che altro tollerati, avendo poco prima le donne parlato del mistero della vita umana e, insieme, del pessimo carattere degli uomini. “I mariti che alzano troppo la voce”, e “il non sapere chi siamo”, erano i due tormenti principali di quelle giovani fronti.
Molto onorato era invece Carlo Cannata, professore di filosofia, un piccolo uomo sfinito dalle lezioni private e dalla conversazione con gli amici, con la moglie e coi figli. Egli leggeva di notte e parlava di giorno. Le idee non gli lasciavano il minimo fiato in petto, pretendendo, non appena nate, di esser pronunciate a voce alta. Cannata, per non parlare, avrebbe dovuto non pensare, ma questo non gli riusciva possibile. Un metodo ferrato gl’impediva poi di trattare la qualsivoglia cosa con leggerezza. Se la vita voleva esser futile, egli la costringeva a riprendere la profondità che Dio le ha dato. La moglie, una donna robustissima ed elegante, sulle cui spalle andavano a finire, in forma di pellicce, i fogli da cento che gli alunni privati deponevano con impaccio sul tavolo del professore; la moglie gridava, dall’altra stanza: «Carlo, bisogna invitare Cesarino, questa sera?». Il marito si alzava e, seguendo, per la casa, coi suoi corti i lunghi passi della moglie, poneva la questione così: «Dio dice: o per te, o con te, o contro di te!». Non si esce da questi tre casi! In essi, infatti, è l’origine di ogni morale. Per te significa: amore. Con te significa: amicizia. Contro di te significa: inimicizia. Nei riguardi di Cesarino, si poteva scartare il “per te”, non essendo il caso di amare un giovane così poco pensoso, ma non si poteva scartare il “con te” senza cadere nel “contro di te”, vale a dire nell’odio, che Cesarino non meritava. Dunque, invitarlo, e passare una sera “con te”, con Cesarino. Ma la moglie opponeva che, oltre quelli citati dal marito, esisteva un quarto caso: senza di te, senza Cesarino. Per un momento il professore rimaneva interdetto, coprendosi con le palpebre le pupille che s’erano del tutto spente; ma poi riapriva gli occhi e, accompagnato dal loro scintillio, dimostrava che “senza di te” equivale a “contro di te”. Io dico: posso vivere senza di te. Cioè dico: posso vivere senza che tu viva. Cioè dico: si può vivere senza che tu viva. In fondo, il mio sentimento è questo: tu puoi morire! Il “senza di te” è una delle forme più sottili del “contro di te”. Cesarino, la sera, ignorando di quale discussione fosse stato l’oggetto, comandava in pessimo francese la controdanza in casa del professore.
Amico, anzi “fratello d’oro” di Cannata, era il giovane avvocato Edoardo Lorena, discendente di una famiglia di uomini politici molto rinomati nell’Isola, già tenente di cavalleria e anche lui, come il nonno e lo zio, “uomo di sinistra”. Violento e buono nello stesso tempo, dopo aver condannato l’universo a una totale distruzione, venendo ai particolari, non sapeva più trovare, nemmeno fra i nemici più accaniti, un solo uomo non degno di ammirazione. Per una intesa, che tutti ormai conoscevano, le persone ammirevoli eran chiamate da lui “belle”, e le più ammirevoli fra le ammirevoli addirittura “zii” e “zie”. C’era zio Mazzini; poi c’era zio De Sanctis; e giù giù si arrivava a zio Luigi e zio Corrado, che erano il farmacista e il medico condotto di Nissa, “belli” anche loro perché sapevano ripetere correttamente a memoria talune frasi di testamenti politici.
Cannata e Lorena credevano di somigliarsi, e si abbracciavano ogni momento per questo. Ma in realtà erano assai diversi. L’uno non sapeva pensar nulla senza la premessa: “Dio dice…”. Ed era un cervello del tutto metafisico. L’altro, invece, non sapeva veder nulla, nemmeno il tacco lasciato da una scarpa vecchia per la strada, senza unirlo con la mente a tutti i tacchi e le scarpe del mondo, e questi a tutto il commercio e il lavoro del mondo, e questi ultimi a “tutta l’organizzazione del lavoro e del commercio del mondo”. Era, insomma, un cervello del tutto politico. Parlavano ambedue di continuo, ma Cannata non pronunciava a voce alta che pensieri filosofici, lasciando nel più perfetto silenzio i bisogni della sua vita intima (aveva passato un inverno intero col desiderio, non mai espresso, di un’altra coperta sul letto), mentre Lorena non aveva vita intima, perché tutto gli scappava dalla bocca con gran rumore. Quando leggeva, leggeva a voce alta; quando a un amico non aveva più nulla da dire, lo chiamava continuamente per nome; e quando era solo nella sua camera, e non aveva un libro da recitare, accompagnava con parole i minimi atti del suo corpo, e li descriveva a se stesso. «Tossisco”, diceva un po’ prima di tossire, o un po’ dopo aver tossito. «Mi volto”, quando sul letto muta fianco. E perfino: «Mi addormento”, nell’istante in cui perdeva la conoscenza. La mattina, dopo aver detto: «Mi sono svegliato!», saltava ad abbracciare i fratelli, il padre, il cane, la cameriera e, per un minuto, rimaneva come paralizzato dinnanzi al telefono, tanti erano i numeri che facevano ressa alle sue dita e tale il desiderio di parlare con tutta la città in una volta. Poi si accontentava di salutare gli “zii”, i “belli”.
In ogni modo, Cannata scambiando Lorena per un filosofo, e Lorena scambiando Cannata per un politico, i due uomini si credevano simili come due gocce d’acqua e, chiamandosi fratello, zio e bello, si premiavano a vicenda con baci e con abbracci.
Quando il loro bisogno di parlare si sentiva inappagato dal fatto che nessuno dei due provava il bisogno di ascoltare, cercavano un terzo amico, l’ex prete Ottavio Carrubba, “zio, bello e poeta assai fine”, la persona più rispettabile di Nissa, per la sua cultura profonda, per i paramenti della sua vita, per lo strano sorriso con cui ascoltava tutti i discorsi, e nel quale ognuno vedeva un misterioso e ineluttabile “Sì!” che, invece della forma delle parole, avesse preso quella di un barlume. Come leggeva bene, figlio di Dio! Tolte le lenti, il lungo collo si torceva in giù e portava il viso sul libro, come una lanterna fioca che dovesse rasentare le cose per illuminarle. Con la bocca a un millimetro dalla pagina, egli cominciava a recitare le prime parole; poi il collo, con uno scatto, risollevava in aria quel viso; ed egli, tenendo fissi in un punto gli occhi che, privi di lenti, erano ciechi, recitava il resto del periodo. Ma che tono! Che gusto! Vestite di una voce così misteriosa, le cose belle diventavano bellissime! E le brutte rendevano la bruttezza impercettibile come la maggior parte delle loro sillabe! Se c’era un aggettivo che non andava, egli lo spegneva dolcemente; se invece ce n’era uno che andava bene, egli lo lanciava, come un uccello trillante, per la stanza. E proprio come un uccello vivo e reale! Perché, terminata la lettura, l’aggettivo rimaneva a gorgheggiare fra le quattro pareti coperte di quadri. Né mancava a Carrubba lo spirito. Anzi ne aveva uno quasi fanciullesco, dal quale pareva che solo il giorno avanti fossero caduti di mano i giocattoli. Dai frivoli, come accade alle cose veramente profonde, gli scherzi di Carrubba erano giudicati frivoli. E quale prova migliore che essi non lo erano? Carrubba, nei momenti di riposo, faceva lo zoppo e, irrigidendo la gamba sinistra, riempiva la stanza di quel rumore fatale che manda una gamba rigida. Deliziose scenette di zoppi, eseguiva e faceva eseguire dai suoi amici; e altre ne immaginava, come quella di un esercito di zoppi che s’avanzasse di notte, e mettesse il gelo nel petto del nemico col solo rumore del passo lento e a martello. Egli aveva scritto anche una farsa intitolata: Gli zoppi vogliono la guerra! Deliziosa opera, solo paragonabile, per semplicità e forza comica, a un melodramma di Rossini. Del resto, il sospetto che qualcosa di serio si nascondesse sotto quegli scherzi, aveva conquistato anche il presidente del Tribunale. Carrubba era in ogni caso un uomo profondo e rispettabile, ma specialmente quando somigliava a un bambino. Scavando nell’uomo, a una certa profondità, si ritrova sempre l’innocenza, come l’acqua nella terra. Quello, da cui si riaffacciavano i giuochi della fanciullezza, in Ottavio Carrubba, era un pozzo di sapienza. Il presidente non aveva battuto ciglio, la sera in cui Carrubba, dopo la lettura di un filosofo moderno, pregò gli amici d’inventare ciascuno un ballo. Al piano Greta, la figlia dell’ospite, suonava un valzer. Cannata, lo ballò come una scimmia tarda, piena di sonno e sempre nel timore di ricevere un colpo di frusta; e fu molto applaudito. Il presidente si dichiarò inabile a questo giuoco di fantasia, ma dichiarò insieme ch’egli lo apprezzava. Ed era vero. Tanto lo apprezzava che, l’indomani mattina, nell’aula del Tribunale, ne parlò a bassa voce al cancelliere; e la sera, inginocchiato nella piccola chiesa madre, ne parlò, sempre a bassa voce, ad alcune signore che avevano poggiato i gomiti sullo stesso leggio.
Sicché il giorno che fu deciso di preparare quel ballo tanto agognato, una voce concorde scelse Ottavio Carrubba per presidente del comitato.
Si voleva una festa lieta, piena di scherzi e d’invenzioni, buona musica di antichi valzer, costumi e truccature, ma anche intelligenza e profondità. La Gioia doveva sorridere al Pensiero, e il Pensiero doveva tenere i fili della Gioia. Chi, meglio di Carrubba, era atto a far questo?
I giovanotti si fregavano le mani al pensiero che, intelligenza o meno (questo non li interessava), ci sarebbe stato un ballo, e le parole, ch’essi mormoravano di notte sul cuscino, avrebbero finalmente trovato un’orecchia dal lobo roseo...