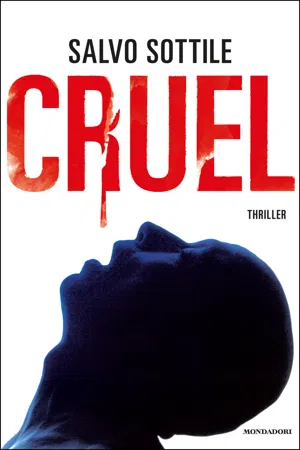Un lampo squarciò il buio svelando per un attimo una visione maligna, un teatro spoglio e decaduto, fatto di muri scrostati e di ombre che si muovono svelte.
Piove. La pioggia lava i peccati del mondo.
Sotto lo scrosciare del temporale estivo, i passi risuonavano in un lungo corridoio cosparso di detriti. Sotto i piedi scricchiolavano pezzi d’intonaco, schegge di vetro, resti di finestre frantumate.
In una notte come quella, anche i muri sembravano vibrare.
Dalle pareti riecheggiavano le urla, le risate stridule e folli di chi aveva popolato le sale devastate dal tempo, maschere di uomini e donne senza nome, senza volto, che quel luogo sembrava aver voluto imprigionare lì, non concedendo a nessuno la pietà dell’oblio.
Ecco le voci... quanti anni...
Il peso da trasportare era nulla a confronto del significato del gesto. In quel luogo, a quel modo.
I simboli erano tutto.
Un ampio locale in fondo alla corsia. La sala d’aspetto per i visitatori. File di sedie schiantate, tavoli rovesciati, porte divelte. Tubi al neon penzolanti nel vuoto.
Ecco, qui.
Pioveva che Dio la mandava.
La fitta cortina d’acqua, improvvisa, provvidenziale, avrebbe coperto ogni cosa. Avrebbe impedito a eventuali curiosi di notare luci e movimenti dove non dovevano esserci.
Nessuno doveva sentire, nessuno doveva vedere.
Le uniche presenze tollerate erano quelle degli oscuri esseri che abitavano quel luogo: i topi, coi loro scalpiccii nervosi, gli insetti e tutti gli altri predatori notturni che avevano fatto di quell’edificio il loro territorio di caccia.
Ora, deporre il fardello sul pavimento sudicio...
Ogni singola azione, che fino a quel momento era stata lasciata al caso, ora stava per trovare un senso, un ordine, in una sequenza perfetta di comandi che erano la promessa di un viaggio, l’attesa di un profondo godimento.
Estrarre le corde.
Uno sguardo al soffitto.
La trave lassù sarebbe andata alla perfezione.
Afferrare un polpaccio della cosa a terra...
La carne era fredda e viscida, sgusciava quasi come gelatina tra le dita guantate.
Avvolgere un capo della fune intorno alla caviglia, stringendo forte...
Nessuno sbiancamento, nessun deflusso di sangue per effetto della compressione. Non c’era sangue, in quel corpo. Non più.
L’altra gamba, ora, con la seconda fune.
Cordame ruvido, che raschiava via lembi di pelle liscia.
Fatto.
Trascinare fin sotto la trave uno dei tavoli di ferro ricoperti di calcinacci.
Salire, far passare le due corde sopra la trave.
Fatto.
Un tuono rimbombò sordo, facendo vibrare i monconi di vetro delle finestre sfondate.
Tirare le funi, ora.
Le gambe della ragazza presero a innalzarsi dal suolo, come animate di energia propria. Le corde sfrigolavano sulla superficie della trave, ma reggevano bene il peso del corpo nudo.
Anche il busto saliva lentamente, adesso, e la testa si staccava da terra, poi le braccia, rilasciate come fiori appassiti. Un’assurda creatura che sorgeva dall’abisso nei riflessi lividi della città martoriata dal temporale.
L’intera figura sospesa ondeggiò per qualche momento. Il segno tracciato sull’addome era un sigillo nero sulla pelle bianca, immacolata.
Morte e trasfigurazione. Il cerchio si stava chiudendo, la visione stava diventando materia che gradualmente prendeva forma.
Assicurare l’estremità delle funi, ora, al corrimano murato nella parete più vicina.
Lo usavano i pazienti con difficoltà motorie per spostarsi nella sala, in un’epoca lontana, quando l’ospedale era... vivo.
Accostarsi al simulacro per ammirarlo un’ultima volta.
Non restava che contemplare la cosa adesso, quel pendolo inerte che già scandiva il tempo di un’altra dimensione.
La massa di capelli si muoveva ancora, quasi impercettibilmente, lo rivelava l’ombra sul pavimento.
Toccare quei capelli, lasciar scorrere le dita tra le ciocche scivolose e lucenti...
Una violenta raffica di lampi trasformò la notte in giorno per qualche istante, come in un negativo.
Ciò che era chiaro divenne oscuro, e ciò che era oscuro divenne chiaro.
Tutto era compiuto.
Andare via, ora.
Forse, grazie a quel sacrificio, il dolore nella mente sarebbe cessato.
Sì, era così.
Ora le voci potranno tacere.
La tangenziale est era un tappeto di macchine. Solo la corsia di emergenza era sgombra.
Dopo il temporale notturno, una cappa di umidità gravava su Roma come un sudario. Meglio sprofondare all’inferno che finire lì, intrappolato nel traffico della capitale, immobile e impotente sopra a un motorino, con la gola secca e lo smog che cercava di impadronirsi, come un veleno, di ogni molecola del suo corpo.
Sì, Mauro non aveva dubbi.
L’inferno tutta la vita!
Con l’aria sofferente di chi affronta un calvario, era fermo col suo cinquantino, un SH sgangherato blu elettrico, all’altezza della stazione Tiburtina.
Il Verano era a una manciata di chilometri, ma sembrava lontanissimo.
Era successo qualcosa da quelle parti, probabilmente un omicidio, comunque roba grossa. Dalla redazione non gli avevano detto altro quando gli avevano telefonato tirandolo giù dal letto. Solo che il posto era un vecchio ospedale psichiatrico dismesso nella zona del cimitero monumentale di Roma.
Mauro aveva capito più o meno dove si trovava. C’era passato qualche volta, a tarda sera, quando frequentava un pub nei dintorni, e ne era rimasto affascinato. L’ospedale sembrava una di quelle palazzine fatiscenti che avevano resistito ai bombardamenti della guerra, una costruzione con i muri scrostati, il tetto sfondato, le finestre senza vetri. Doveva arrivarci prima che fosse preso d’assalto dai colleghi di altre testate.
I suoi tempi di reazione erano stati lunghi, ci aveva messo un po’ a carburare e a fare mente locale. Dopo aver di nuovo posato sul comodino il cellulare, che teneva sempre acceso, anche la notte, era rimasto seduto sul bordo del letto a chiedersi per una frazione di secondo chi fosse la ragazza che gli dormiva accanto...
Michela, Manuela, qualcosa del genere.
Conosciuta qualche giorno prima alla presentazione di un libro. Si erano scambiati il numero e si erano rivisti: se l’era portata a cena e poi a letto, quella stessa notte. Sesso e basta. Ci aveva anche discusso un po’, per qualche stronzata che nemmeno ricordava più.
Uscendo di corsa, l’aveva lasciata dormire. Chissà se l’avrebbe ritrovata lì, al suo ritorno. Non gli interessava, comunque. La storia si sarebbe ripetuta, lo sapeva. Era già venuto il momento di chiudere con Manuela, o Michela. Ventiquattr’ore. Tanto duravano le sue vicende sentimentali dopo il lungo regno di Sonia I, la madre di suo figlio,...