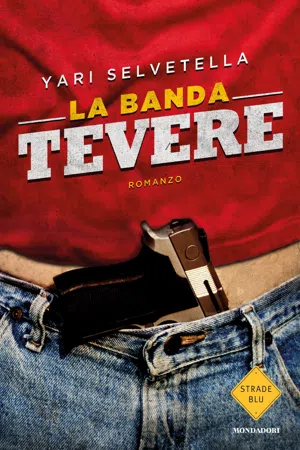Era più forte il rumore dei clacson, lì fuori. Perfino gli insulti tra gli automobilisti della via Tiburtina si capivano bene, oltre i torrioni e il filo spinato. Ecco, pensò Mauro Urbani, detto Tevere, manco esco dal gabbio e già piovono i vaffanculo.
Non era la prima volta che si ritrovava con quelle mura alle spalle, lungo lo stradone desolato su cui si addossava, sempre più ordinata e residenziale, la vecchia borgata di Rebibbia. Non era nemmeno la seconda, né la terza. Era una volta tra le altre. Non la più grave, ma di sicuro la più stupida: s’era fatto cinque anni per evasione dai domiciliari, dove scontava un vecchio residuo di pena. Una mattina si era svegliato con un gran rodimento e il pacchetto di sigarette vuoto, così s’era vestito e se l’era andate a comprare. Poi però aveva litigato col tabaccaio. Era volato uno sganassone. Il tabaccaio non l’aveva presa bene e ai carabinieri aveva dichiarato che la questione, in realtà, nasceva da un tentativo di rapina. Insomma, tra equivoci, vecchie pendenze e una fedina lunga una quaresima, Tevere era finito dentro un’altra volta. Adesso, a più di cinquant’anni, era di nuovo libero.
Ha un sapore strano il primo passo oltre quel portone. Gli sembrava che il tempo ritornasse a scorrere nella precisa consegna del suo corpo dalla cattività al mondo libero, nella sensazione di essere perduti per sempre davanti al sole, al cielo circolare, al profumo di milioni di donne in file interminabili di palazzi. Proprio lì, nel suo sentirsi minuscolo di fronte a tanta gloria, come una mosca che scopre la differenza tra l’aria e il vetro, gli capitava di invecchiare.
Era ancora lui, certo, un uomo che dà l’impressione di essere grande e grosso anche se non arriva al metro e ottanta. Quel giorno la sua faccia piena di controsensi gli calzava a pennello. Le mascelle squadrate e il largo naso schiacciato parevano fatti apposta per resistere alle botte. Negli occhi, invece, tagliati a mandorla e piuttosto piccoli, albergava una furbizia innocua e persino una qualche grazia femminile, sottolineata da lunghe ciglia lucide e sempre accese da un largo sorriso che pareva inghiottirlo tutto, quel volto, dal mento sfuggente alla fronte, quando una battuta tirata fuori al punto giusto o uno scherzo ben fatto lo liberavano da ogni pena. Sembrava impensabile che quegli stessi occhi fossero capaci di svuotarsi e incutere terrore.
Era una volta tra le altre, quella, ma certo era particolare. Sollevò il braccio a cui era legato un bustone di plastica nera con vecchi vestiti dentro, si strinse la fronte con la mano come se avesse la febbre. Usò il manico del grosso trolley che trascinava con l’altra per appoggiarsi un attimo.
Il sole batteva sulle nocche, tutte le ossa erano spesse. Allora si accorse che stava accadendo. Chiuse gli occhi, tornò a vedere se stesso: l’attaccatura dei capelli sempre più arretrata, quei ciuffi appiccicati alla nuca con l’ultima presa di un barattolo di gommina; la pancia, un cuscino, la panza. Non in lunghi anni, ma adesso, a contatto col mondo, iniziava a ingobbirsi e gli calava la vista dietro ai vecchi Ray-Ban.
Non c’era nessuno ad aspettarlo, perché questi erano i piani e così doveva essere.
Sono io, pensò. Io. Ho rubato a me stesso anni della mia vita, da domani andrò a pulire i giardinetti con una cooperativa di ex detenuti e falliti vari. Da domani. Adesso sono libero e felice. Sono tutto quello che non si può spiegare.
Si ricordò del trolley, del perché quella volta era uguale alle altre ma anche così diversa. Gli venne da ridere pensando all’impresa che stava per compiere. Fece un passo e se lo tirò dietro. Pesava molto.
Non per caso Tevere aveva messo tutte le sue cose in un bustone e intanto trascinava quel trolley da viaggio intercontinentale. Il motivo c’era e si chiamava “Cocco”. Non era un soprannome quel cocco, tipo cocco bello, cocco di mamma, cocco di cocaina. Era uno in poca carne e molte ossa, che si chiamava proprio così. Tevere sussurrò:
«Ahó, Cocco.»
Niente.
«Mi senti, Cocco?»
Per fortuna non c’era nessuno nei paraggi, sennò lo avrebbero preso per matto, uno che chiama “Cocco” così, da solo, per la strada.
Dal trolley partì un soffio.
«Com’è?»
«Com’è che?»
«Com’è? Come va? Vedi qualcuno?»
Macché qualcuno, non c’era anima viva lì, a rimirare la scena di un avanzo di galera e del suo trolley parlante.
Cocco era un ragazzo che veniva da un paese della Barbagia dal nome impronunciabile. Doveva uscire proprio lo stesso giorno di Tevere. Il fatto è che Cocco aveva una questione aperta con certa gente del paese suo. Era sicuro che lo avrebbero aspettato fuori dal collegio, perciò aveva proposto a Tevere quella sceneggiata. Dice: tu le cose tue te le porti in una busta, io mi infilo nella valigia e quando arriviamo sulla Tiburtina, al primo bar io prendo e me ne scappo.
«E la roba tua?»
«Io non ho niente. Cinquanta euro, ho. E te li pigli tu se mi aiuti. Per il resto solo la pellaccia mi devo conservare.»
Non si faticava a credere che Cocco ci sarebbe entrato, nel grande trolley di Tevere. A parte che era un Samsonite, la robetta fine che Tevere comprava quando ancora stava in grana, e poi questo Cocco era tutto nervi, pareva un serpente. Tevere accettò. Aveva pure forato la base per far passare l’aria. Stava così a pezzi che i cinquanta euro gli facevano gola. Come s’era ridotto.
Prima dell’ultimo portone un poliziotto, guardando quei due, non ci poteva credere.
«Ma che combinate?»
«Niente, principale. Dobbiamo fare uno scherzo agli amici.»
Cocco s’era rannicchiato come un gatto nella valigia, là davanti ai secondini. E s’era pure tirato la zip da solo.
«Anvedi questo. Ma che sei del circo Togni?»
Le rotelle del trolley tenevano, era tutto perfetto. Cocco diede un colpetto da dentro e Tevere capì che si poteva andare.
A malapena arrivava a cinquanta chili. Due saccocce di cemento di queste nuove. Che sarà mai, pensava Tevere mentre il portone si apriva e gli si ficcavano nel cuore il veleno del tempo che passa e tutte le menate sulla vecchiaia.
Poi, grazie all’avventura da compiere, gli tornò il buon umore. Metro dopo metro, però, la valigia iniziava a pesare sul serio e le ruote a cigolare. Tevere aveva l’affanno, la Tiburtina era lontanissima, la maglietta che indossava sotto la vecchia tuta acetata della Sergio Tacchini, zuppa di sudore. Era già primavera, il tepore stupendo e almeno i piedi, nelle vecchie Lotto, stavano una favola. Biascicò insulti a se stesso, imprecò, ma ce la fece.
Proprio all’incrocio con la consolare vide un’utilitaria parcheggiata, boh, una di queste nuove giapponesi, con dentro tre pischelli dall’aria seria seria. Ma guarda questi, pensò, si credono di essere qualcuno. Lo notarono, lo guardarono. Tevere provò a dissimulare la fatica, ma non per paura. È che ci sformava a farsi vedere così, un uomo ingrassato, in tuta, sudato, con un valigione in una mano e una busta nell’altra, mentre quelli facevano gli splendidi coi vetri fumé e l’arbre magique.
Ricambiò gli sguardi. Si avvicinò senza abbassare mai il capo, sfidandoli. ’Mbè? Solo pochi metri di distanza. Lui spizzava, le ombre nell’automobile ricambiavano.
Li superò e se li lasciò alle spalle, la valigia quasi insopportabile. Il traffico era ormai prossimo. Quanta gente. Gli girava la testa. Migliaia tutti insieme, inconsapevoli di ciò che è prezioso, come capita sempre finché non te le tolgono, le cose. I chilometri, sotto le insegne dei cartelloni abusivi, i prati fino ai borghi lontani sulle colline e dietro ancora strade e altre colline, tutte a disposizione.
Mancavano solo una decina di passi per arrivare al bar, sentiva il fiato sul collo di quei tre scemi, immaginava da un momento all’altro il clac dello sportello che si chiude. Invece no. Non scese nessuno. Ci volle un ultimo sforzo per sollevare la valigia sul gradino d’ingresso al bar. Forse la busta all’altra mano stava per rompersi, gocce di sudore gli scendevano dagli zigomi larghi. Entrò. Il locale era vuoto. Il barista, un ragazzo con la pelata imbrunita dalla crema abbronzante, era di spalle.
«Il bagno?»
Il barista non rispose.
«Oh, Kojak, il bagno.»
Allora il barista si voltò.
«Chi?»
«Il bagno.»
«Come m’hai chiamato?»
«Kojak. Dài, Kojak. Non lo sai Kojak?»
«No, mai sentito.»
Avrà avuto vent’anni. Con l’aria scocciata gli porse la chiave della toilette, a cui era attaccato un pendaglio di plexiglass con su scritto WC. La porta era accanto al bancone e apriva su un retrobottega.
Tevere aprì la zip della valigia. Il groviglio di Cocco si sciolse e ne uscì il ragazzo. Era livido.
«C’erano?»
«Sì, credo.»
«Lo sapevo.»
Cocco vide Tevere, stravolto com’era, con i respiri che gli gonfiavano la pancia. Sorrise.
«Gli avrai fatto paura.»
Cocco sembrava sentirsi al sicuro in quel cesso, davanti alle mattonelle d’un bianco bisunto e un cubitale numero di telefono scritto a pennarello sotto l’annuncio “lecco piedi”. Ansimava leggermente. Il suo torace di serpente si allargava. Dalla tasca dei jeans tirò fuori un rotoletto. Erano banconote da dieci euro. Aprendole le stirò, le accarezzò. Gliele contò ad alta voce. Uno, due, tre... Che miseria, pensò Tevere, così in basso non c’ero mai arrivato.
Quattro, cinque. Tevere ne tenne due e tre gliele ridiede indietro. Cocco esitò un istante, anche meno. Se le acchiappò mormorando un grazie.
Si guardarono intorno. La finestra era proprio lì, accanto alle scale buie che portavano giù al bagno. Dava su un cortile interno, un ritaglio di rete da gallinaio faceva da grata. Era minuscola, ma Cocco ci sarebbe passato di sicuro.
«E poi, da lì?»
«E poi da lì non tornerò mai. Non le voglio più vedere le facce da cazzo come la tua.»
Tevere sorrise.
Non riuscì manco a dirgli in bocca al lupo, perché Cocco s’era già intrufolato nella finestrella, come se fosse la cosa più facile del mondo.
Tevere sentì il sudore che gli si freddava sulla schiena.
Quando uscì per strada, con la sua vecchia roba infilata nel trolley, il rumore del traffico gli pareva già attutito, normale. Uno dei tre ragazzi gli veniva incontro e così fece lui, di nuovo veloce, di nuovo grande e grosso. Il nemico aveva gambe sottili, occhiali a specchio, gioventù, tutto. Lui una valigia con quattro stracci e addosso una tuta sudata. Quello già a un metro sapeva di dopobarba sportivo, lui puzzava. Si sfiorarono appena. Il ragazzo non osò fiatare, anzi abbassò lo sguardo andando oltre, verso il bar. Chissà se Cocco era già in salvo.
Adesso, con la valigia leggera, camminare era più facile, persino bello. Non riusciva a fermarsi. Il rumore delle rotelle sull’asfalto copriva gli altri, perciò il mondo era muto e immenso. Alla fermata della metropolitana c’erano tutti quegli autobus, tutta quell’aria. Tevere si sedette sotto una pensilina e gli parve un gran guadagno, respirare.