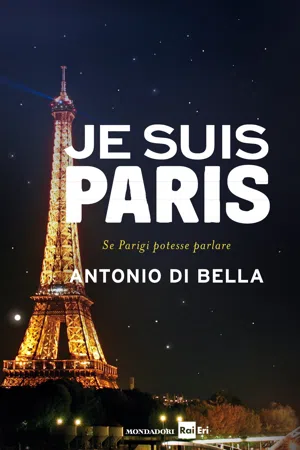Se i muri del palazzo al numero 10 di rue Nicolas Appert, XI arrondissement, potessero parlare, racconterebbero la più terribile delle vicende accadute a Parigi dal secondo dopoguerra. Il 7 gennaio 2015 è una data che difficilmente potrà essere cancellata dalla memoria collettiva dei francesi. Era una mattinata come le altre, il cielo era grigio e nella redazione di “Charlie Hebdo”, il più corrosivo e irriverente dei giornali di satira francesi, si stava tenendo una riunione. Più volte, in passato, “Charlie”, spirito anarchico ma forti sentimenti di sinistra, aveva pagato caro per la sua libertà di satira: c’erano state minacce ripetute e anche un incendio doloso. Ma senza vittime. Fino al 7 gennaio. Quando due uomini a volto coperto, forse con giubbotti antiproiettile, di sicuro armati di fucili kalashnikov AK-47, si presentano davanti alla redazione del giornale. Entrano al numero 6. Si rendono conto però di aver sbagliato edificio, così si spostano al numero 10, dove sono situati gli uffici di “Charlie Hebdo”, al secondo piano. I due uomini si fanno indicare come trovarli e sparano all’addetto alla portineria, Frédéric Boisseau.
Poi fermano la prima persona in cui si imbattono, Corinne Rey, la vignettista conosciuta anche con il nome di Coco. La donna era appena stata ad accompagnare la figlia all’asilo e proprio in quegli attimi stava rientrando in ufficio. Sotto la minaccia delle armi, i due terroristi la obbligano a digitare il codice di sicurezza che consente di aprire la porta d’ingresso. Al giornale ci sono tutti, anche perché, come accennato, proprio quella mattina è in corso una riunione di redazione (circostanza di cui i killer, forse, sono bene informati?).
I terroristi sparano a bruciapelo e uccidono nove persone: Stéphane Charbonnier, alias Charb, 47 anni, vignettista e direttore; Georges Wolinski, 80 anni, vignettista; Jean Cabut, detto Cabu, 76 anni, vignettista; Bernard Verlhac, detto Tignous, 57 anni, vignettista; Philippe Honoré, 73 anni, vignettista; Bernard Maris, 68 anni, economista e editorialista che aveva una rubrica personale su “Charlie Hebdo” con lo pseudonimo di Oncle Bernard; Elsa Cayat, 54 anni, psicologa e giornalista; Michel Renaud, 69 anni, ex capo di gabinetto del sindaco di Clermont-Ferrand; Mustapha Ourrad, 60 anni, correttore di bozze musulmano a cui mancava un mese di tempo per diventare a tutti gli effetti cittadino francese. Uccidono anche un poliziotto, Franck Brinsolaro, 49 anni, che si trova lì avendo il compito di proteggere Charbonnier, più volte oggetto di minacce in passato.
Poi fuggono a bordo di una Citroën C3 nera, ma vengono intercettati da un’auto della polizia con due agenti a bordo, che tentano di fermarli. I due crivellano di colpi la macchina, i poliziotti sono costretti a indietreggiare ma rimangono illesi. È a quel punto che si avvicina in bicicletta, lungo il boulevard Richard Lenoir, Ahmed Merabet, 42 anni, un altro agente di polizia. Con una raffica di mitra lo feriscono: il poliziotto, colpito a una gamba, si accascia al suolo. Sembra immobile, poi però si volta, compie un gesto come di implorazione ma i terroristi gli si avvicinano. Lui, da terra, grida, alzando le mani: «Mi arrendo, cosa volete fare, uccidermi?». La risposta è fulminea: «Sì, capo», seguita da un colpo di kalashnikov a distanza ravvicinata che non lascia scampo. La scena è ripresa con il telefonino da qualcuno che abita in una casa di fronte e in pochi minuti fa il giro del mondo.
Quando arrivo in rue Appert poco dopo la fuga dei terroristi, sembra di essere in una zona di guerra: poliziotti a ogni angolo mentre i tetti dei palazzi brulicano di persone armate di telefonini: quello di “Charlie Hebdo” diventerà uno degli attentati più “mediatici” della storia recente, ripreso in vari momenti dai cellulari degli abitanti della zona. Alcuni di loro si pentiranno di aver messo in Rete le immagini più crude (in particolare quelle dell’omicidio a sangue freddo dell’agente di polizia) e chiederanno scusa alla famiglia, rinunciando a qualsiasi pagamento.
I due terroristi si chiamano Saïd e Cherif Kouachi, due fratelli franco-algerini di 34 e 32 anni, residenti a Parigi. Si risale in breve tempo alla loro identità per un evento casuale quanto assurdo: a bordo della Citroën, abbandonata vicino a Porte de Pantin dagli attentatori durante la fuga, la polizia trova la carta d’identità di uno dei terroristi. Secondo altre fonti il documento appartiene ad Hamyd Mourad, diciottenne, cognato di uno dei due, che avrebbe fatto loro da autista. Sta di fatto che quello “strano” ritrovamento permette agli immancabili professionisti della dietrologia di gettare ombre e sospetti, di ipotizzare che possa trattarsi di una montatura, fabbricata a tavolino dai servizi segreti o dalla solita CIA. Una sciocchezza che varrebbe il tempo di una risata, se non riguardasse una vicenda così drammatica.
La verità è che i fratelli Kouachi sono tornati da poco tempo dalla Siria – dove dal 2012 è in corso una terribile guerra civile – e hanno precedenti per collaborazioni con la rete jihadista yemenita. La notizia provoca subito reazioni stizzite negli ambienti politici, si accusano i servizi di intelligence di avere gravemente sottovalutato i loro dossier.
Saranno catturati due giorni dopo, al termine di una caccia all’uomo tanto frenetica quanto caotica. Di minuto in minuto, i media facevano sapere che i terroristi erano stati individuati, isolati, circondati... poi, no, che erano riusciti a fuggire, che la zona delle ricerche sarebbe diventata un’altra. Decine di migliaia di poliziotti mobilitati, un’intera città (ma sarebbe meglio dire un’intera nazione) paralizzata, in corso “la battaglia di Parigi”, come è stata subito definita dai media. Uomini e mezzi corazzati presidiavano la capitale per timore di altri attentati. Decine di falsi allarmi, poi l’ennesimo, purtroppo vero. A Porte de Vincennes nell’emporio alimentare Hyper Cacher, un supermercato ebraico di prodotti kosher, faceva irruzione un altro terrorista, Amedy Coulibaly, con kalashnikov e giubbotto antiproiettile.
Il giorno prima, l’8 gennaio, lo stesso Coulibaly aveva ucciso Clarissa Jean-Philippe, un’agente della polizia municipale francese di vent’anni (in servizio da appena quindici giorni), avvicinatasi per un controllo dopo un banale incidente stradale fatto dall’uomo durante una manovra di parcheggio nei pressi della scuola ebraica di rue Gabriel, nel quartiere di Montrouge, banlieue di Parigi. Secondo alcune testimonianze, il vero obiettivo di Coulibaly era proprio l’asilo ebraico. Intendeva fare una strage. L’uccisione non preventivata della giovane vigilessa lo costringe però a cambiare piano. Ecco perché lo ritroviamo a Porte de Vincennes.
Appena entrato nel piccolo supermercato, Coulibaly spara a sangue freddo su quattro clienti e li uccide. Poi si barrica all’interno, tenendo in ostaggio un’altra dozzina di persone. I due fratelli Kouachi, intanto, vengono bloccati a Dammartin-en-Goële, quaranta chilometri a nord di Parigi. Si sono rifugiati dentro una stamperia. All’interno sembra esserci soltanto il proprietario, Michel Catalano. I terroristi non lo uccidono. Anzi, gli suggeriscono di telefonare alle forze dell’ordine per segnalare la loro presenza, poi viene rilasciato. Ma Catalano sa una cosa che i fratelli Kouachi ignorano. Al secondo piano della fabbrica c’è un suo dipendente, Lilian Lepère, che non solo riesce a nascondersi per molte ore dentro un mobiletto situato sotto un lavabo, senza quasi potersi muovere, ma addirittura si mette in contatto tramite il cellulare con la polizia, comunica via SMS su tutto ciò che sente accadere, fornisce informazioni decisive.
Si tratta, insomma, di due assedi contemporanei. I terroristi sono collegati fra loro. «Io ho il compito di ammazzare più poliziotti possibile» dichiara Coulibaly in una telefonata in diretta alla BFM-TV, «loro [intende i fratelli Kouachi] dovevano occuparsi di “Charlie Hebdo”.» La polizia isola tutti i telefoni nei due luoghi dell’assedio. Poi il presidente Hollande ordina il blitz: bombe accecanti e assordanti prima, raffiche di mitra poi. I fratelli Kouachi e anche Coulibaly trovano la stessa morte: escono all’aperto sparando contro la polizia, che risponde al fuoco e li uccide.
Sono quaranta ore che cambiano profondamente la Francia. Nel giro di poco tempo, migliaia di francesi scendono spontaneamente in piazza, ognuno deciso a esprimere il proprio dolore e la propria vicinanza alle tante vittime di un attacco così forsennato alla libertà. Non sono pochi i volti rigati dalle lacrime. Quasi tutti hanno in mano dei cartelli colorati che riportano una scritta, di colore bianco su fondo nero: JE SUIS CHARLIE. Con le braccia li alzano sopra la testa, perché la si legga meglio. Insieme si alza anche un grido, che ha le stesse parole del cartello: JE SUIS CHARLIE, JE SUIS CHARLIE. È un coro che risuona per le strade di Parigi, dell’intera Francia e ben presto del mondo. Quella scritta la si vede comparire sulle vetrine dei negozi, alle finestre delle case, sui profili Facebook e Twitter di personaggi famosi e di cittadini qualunque. È la prima, istintiva e massiccia risposta al terrore. La testimonianza di una forte resistenza all’oscurantismo che culmina nella grande manifestazione dell’11 gennaio in place de la République.
C’è da dire che neanche avvenimenti così tragici come quelli accaduti, riescono a cambiare lo spirito di chi lavora a “Charlie Hebdo”. «Anche nel 2002 ci fu un’enorme manifestazione contro il Fronte nazionale» tiene a precisare il Luz, storico disegnatore del settimanale, dalla redazione di “Libération”, che ospita per comprensibili motivi logistici e di sicurezza i superstiti del massacro avvenuto in rue Nicolas Appert. «Poi non è successo più niente e il Fronte ha continuato ad avanzare. Il problema è che la gente non deve solo manifestare ma “manifestarsi”. Cioè esprimere valori contro l’oscurantismo religioso, politico, economico. Perché “Charlie Hebdo” non cerca l’unità nazionale, lotta semplicemente contro l’imbecillità. Forse l’unica unità nazionale che noi auspichiamo è che ognuno possa prendere in giro il prossimo.» Il giudizio più tranchant è di un redattore di origine italiana, Antonio Fischetti: «I francesi sono seri, razionali, amano la gravità».
Strano che marcino tutti uniti intorno a un clown come “Charlie Hebdo”, un giornale che, dicono i maligni, non era poi così osannato e amato in Francia. Il mercoledì successivo ai fatti, “Charlie Hebdo” è uscito in edizione speciale, con una tiratura record che ha superato la cifra astronomica di sette milioni di copie (a fronte delle sessantamila abituali).
In copertina, una nuova vignetta satirica sull’Islam, anzi, su Maometto. Si vede il profeta con una lacrimuccia che regge un cartello con la scritta: JE SUIS CHARLIE. Sulla sua testa campeggia la frase: “Tout est pardonné” (È tutto perdonato).
I francesi si mettono in coda fin dalle prime ore del mattino, quando sulle strade di Parigi ci sono ancora i lampioni accesi. Tutti vogliono una copia di “Charlie Hebdo”, per testimoniare la propria adesione a un sentimento collettivo che mischia rabbia, dolore, costernazione, paura, ansia di riscatto. Televisioni e quotidiani non parlano d’altro, il giornale “irresponsabile” va a ruba anche in Italia, dove viene venduto in allegato a “Il Fatto Quotidiano”. Il giorno dopo è necessaria una ristampa per accontentare le tante richieste. A Roma, a Milano, a Firenze si girano due, tre, quattro edicole, alla ricerca di quello che potrebbe anche tramutarsi in un feticcio. Ammesso che non lo sia già diventato. Sarebbe forse la cosa più spiacevole per Cabu, Wolinski e tutte le altre vittime dell’attentato. Diventare strumento diretto di lotta politica, arma ideologica di qualche “imbecille” (lo definirebbe Luz...) che punta a esasperare gli animi, a gettare benzina sul fuoco, a fare di “Charlie Hebdo” la bandiera di chissà cosa.
Se però vogliamo raccontare la vera storia del giornale che ha fatto della provocazione e della rivendicazione ostinata della libertà di stampa – venata di irriverenze e sfottò – la sua cifra assoluta, bisogna ricordare che le polemiche, i contrasti accesi e i tentativi di censura affondano lontano nel tempo, addirittura da quando il giornale (allora un mensile) era stato fondato, nel 1960, e portava in copertina il titolo di “Hara-Kiri”.
Un caso celebre di pressione politica fu quello del 1970 quando, in occasione della morte del presidente Charles de Gaulle, uno dei padri della Francia del dopoguerra e fondatore della Quinta Repubblica, “L’hebdo hara-kiri” (diventando settimanale, l’anno prima era stato modificato il nome della testata) titolò Ballo tragico a Colombey: un morto (Colombey era la residenza del generale, poi diventata anche luogo della sua sepoltura). Il riferimento “funebre”, caustico e pungente, era a un episodio di cronaca di dieci giorni prima, un incendio in una discoteca che aveva causato decine e decine di vittime.
Il ministero dell’Interno francese ordinò uno stop alle pubblicazioni ma una parte dei giornalisti e vignettisti che componevano la redazione schivò il divieto, dando vita proprio a “Charlie Hebdo”, in omaggio al celebre personaggio dei Peanuts, Charlie Brown.
È tuttavia in anni più recenti che il giornale satirico fondato da Georges Bernier e François Cavanna ingaggia le battaglie più dure e coraggiose, in difesa non soltanto, o non più, della libertà di satira genericamente intesa, ma di uno spirito fortemente antireligioso che comincia però a suscitare le prime reazioni violente. Che destano allarme e preoccupazione. Il mondo, insomma, è profondamente cambiato dopo la tragedia dell’11 settembre 2001 e le guerre scatenate dagli USA contro il terrorismo di matrice islamica in Afghanistan e in Iraq. Il contesto geopolitico, diventato ormai globale, contempla nuove sfide e nuovi equilibri. C’è già chi, a sproposito o profeticamente (le opinioni tuttora non convergono...), parla di uno scontro di civiltà in atto. Molti, in Italia, riecheggiano gli articoli e i libri di Oriana Fallaci dei primi anni Duemila, nei quali si accusava un’Europa pavida e inerme di trattare da “amico” il proprio “nemico”. Un’Europa che si sarebbe tramutata ben presto, sotto la spinta del fondamentalismo islamico, in Eurabia.
Quella di “Charlie Hebdo” diventa dunque una lotta all’oscurantismo, e netta è la posizione contro ogni forma di intimidazione e sottomissione. Già, sottomissione. Un termine denso di significati e rimandi che dopo il massacro del 7 gennaio riempie le pagine dei giornali e i palinsesti delle TV. Sì, perché Soumission è il titolo del nuovo romanzo dello scrittore francese Michel Houellebecq – uscito lo stesso giorno dell’assalto terroristico alla redazione di “Charlie Hebdo” – in cui si prefigura, nientemeno, una Francia a guida politica musulmana nel 2022.
E proprio a Houellebecq, amico di Bernard Maris, lo scrittore ed economista rimasto ucciso nell’attentato, era stata dedicata l’ultima, dissacrante copertina di “Charlie Hebdo”. Raffigurato nelle vesti di mago Merlino, l’eterna sigaretta in mano, ironizzando sulla sua dentatura tutt’altro che impeccabile, il più celebre scrittore di Francia prevedeva che nel 2015 gli sarebbero caduti i denti e che nel 2022 avrebbe fatto “ramadan”. Dopo aver annullato i tour di promozione del libro (già balzato in testa a tutte le classifiche di vendita, anche in Italia), ha deciso di comparire comunque alla TV (trattenendo spesso le lacrime...) in un’intervista a Canal Plus e di concederne alcune altre ai giornali. Adesso Houellebecq vive lontano da Parigi, protetto dalla polizia per motivi di sicurezza. Per i più pessimisti si tratta, dopo quella che aveva colpito Salman Rushdie a fine anni Ottanta del secolo scorso, di una nuova fatwa. A rimanerne vittima è ancora una volta un libero pensatore, uno scrittore, un cittadino europeo e del mondo.
È curioso, e naturalmente drammatico, rammentare che Submission (traduzione inglese del termine “islam”) era anche il titolo del cortometraggio girato nel 2004 dal regista e attore olandese Theo van Gogh, assassinato brutalmente da un estremista islamico come ritorsione contro alcune immagini mostrate nel film, che affrontava il problema delle donne picchiate e maltrattate in famiglie musulmane (a un certo punto, sulla schiena di una donna, van Gogh fece scrivere alcuni versetti del Corano).
Come si può notare, siamo di fronte a una trama di episodi che si rincorrono negli anni. Messi insieme, acquistano il significato di precisi “avvertimenti”, tappe di un’inevitabile escalation che è sotto i nostri occhi.
Sono in molti, per esempio, a ritenere che le pagine di Houellebecq – accusato, a torto, di islamofobia – abbiano toccato alcuni nervi scoperti della contemporaneità: il crescente e diffuso clima di intolleranza che aleggia in Europa verso certe forme di immigrazione, il conflitto tra una civiltà occidentale sempre più chiusa nel suo cinico e sterile egoismo, e la pressione demografica, culturale e politica che giunge da quelle zone del mondo rimaste per troppi secoli nell’ombra. Non si dibatte certo da ora di assimilazione e multiculturalismo, di laicità, di clericalismo, di uguaglianza dei diritti senza distinzione di origine o di appartenenza. Spetterà all’Europa, culla dell’illuminismo e della democrazia, gestire nei prossimi decenni questa difficile convivenza di opposti, e i fatti di Parigi rappresentano il sintomo più preoccupante di una realtà in continuo mutamento, che ha smarrito il proprio rassicurante baricentro.
Houellebecq, del resto, non è stato l’unico intellettuale ad aver fatto salire, e di parecchio, la temperatura del dibattito politico e culturale in Francia negli ultimi tempi. Un altro scrittore, Éric Zemmour, editorialista del “Figaro”, polemista televisivo, ha pubblicato un ponderoso saggio di cinquecento pagine dal titolo inequivocabile, Le Suicide français, in cui prende di mira le “cattive” eredità della lunga stagione libertaria del ’68 – il femminismo, la globalizzazione, l’immigrazione, il matrimonio gay – diventate vere e proprie parole d’ordine di un’ideologia cosmopolita e totalitaria, quella che governerebbe la Francia contemporanea.
Ma Zemmour non si è fermato a questo. ...