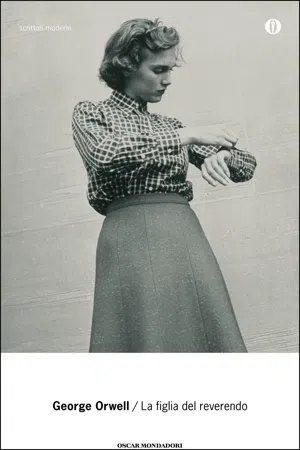Mentre la sveglia sul cassettone esplodeva come un’orrenda, minuscola bomba di bronzo da campane, strappata agli abissi d’un sogno complesso e conturbante, Dorothy si destò di soprassalto e giacque supina, sbarrando gli occhi nel buio, in preda a un estremo sfinimento.
La sveglia continuò il suo rumore bisbetico, femmineo, che durava press’a poco cinque minuti se non veniva interrotto. Dorothy era indolenzita in tutte le membra, e un’autocommiserazione insidiosa e spregevole, che per lo più l’assaliva ogni mattina al momento di alzarsi, la indusse a cacciare la testa sotto le coperte nel tentativo di risparmiare agli orecchi l’aborrito fracasso. Lottò contro la stanchezza, nondimeno, e secondo la lunga consuetudine si rivolse un aspro ammonimento nella seconda persona plurale. Orsù, Dorothy, alzatevi! Fino a quando, o pigri, dormirete? Proverbi, VI, 9. Poi si ricordò che qualora il rumore si fosse protratto, avrebbe destato suo padre e con mossa frettolosa balzò in piedi, e afferrata la sveglia dal piano del cassettone, fermò la soneria. Teneva l’arnese a quella distanza apposta per esser costretta a scendere dal letto se voleva farlo tacere. Sempre al buio, la ragazza s’inginocchiò accanto al capezzale e recitò il paternostro, ma con una certa distrazione, giacché il freddo le intormentiva le estremità.
Erano le cinque e mezzo precise, e il freddo pungeva un po’ troppo per una mattina d’agosto. Dorothy (si chiamava Dorothy Hare ed era figlia unica del reverendo Charles Hare, rettore della parrocchia di St Athelstan a Knype Hill, nella contea del Suffolk) indossò l’annosa vestaglia di flanella e scese le scale a tastoni. Impregnava l’aria un gelido odore mattutino di polvere, d’intonaco umido e di pesce fritto della sera prima, e d’ambo i lati del corridoio al secondo piano Dorothy udì il ronfare antifonale del padre e di Ellen, la loro domestica a tutto servizio. Brancolando con somma cautela – perché il tavolo di cucina soleva giocare il tiro mancino di emergere dalla tenebra e di colpirti all’anca – Dorothy entrò in quella stanza, accese la candela sulla mensola del camino e, ancora dolorante per la spossatezza, s’inginocchiò a raschiare la cenere per farla cader giù dal fornello.
Accendere il fuoco in cucina era una fatica improba. La canna fumaria era storta e quindi perennemente semiostruita, e il fuoco, prima di prendere, esigeva che gli si somministrasse una tazza di cherosene, proprio come l’ubriacone inizia la giornata con il debito sorso di gin. Dopo aver messo a bollire il bricco dell’acqua che sarebbe servita a suo padre per farsi la barba, Dorothy risalì di sopra e aprì il rubinetto nel bagno. Ellen russava sempre, con pesanti sfiatate giovanili. Era una buona domestica e una dura lavoratrice, una volta sveglia, ma una di quelle ragazze che neanche il diavolo e tutti i suoi angeli riescono a tirar fuori dal letto prima delle sette.
Dorothy empì il bagno il più adagio possibile – se apriva troppo il rubinetto, lo scroscio dell’acqua svegliava sempre suo padre – e indugiò un momento a osservare la pallida, repellente massa d’acqua. Le era venuta la pelle d’oca su tutto il corpo. Detestava il bagno freddo, e appunto per questo motivo si era imposta la regola di fare quei bagni freddi da aprile a novembre. Messa una mano nell’acqua in via d’assaggio – era orribilmente fredda – la ragazza si spronò a procedere mediante le esortazioni consuete. Animo, Dorothy, entrate! Basta con questa fifa, per carità! Quindi si cacciò risolutamente nella tinozza, sedette e lasciò che la gelida fascia liquida le guizzasse su per il corpo e la sommergesse tutta fino ai capelli, che aveva raccolto in una treccia e appuntato sopra la nuca. Dopo un momento risalì alla superficie ansimando e contorcendosi, e non appena ebbe ripreso fiato, le venne in mente il suo “memorandum” che si era portata dietro nella tasca della vestaglia con l’intenzione di leggerlo. Allungò la mano per tirarlo fuori, lo prese, e sporgendosi dall’orlo della vasca, con l’acqua ghiaccia che le arrivava al petto, lesse da cima a fondo l’elenco delle “cose da fare” alla luce della candela posata su una sedia.
Il memorandum diceva:
Ore 7 S.C.
Bambino sig.ra T.? devo passare da lei.
Prima colaz. Pancetta. Bisogna chiedere soldi al babbo. (Penit.)
Domandare Ellen cosa manca in cucina tonico babbo N.B. informarsi stoffa p. tende da Solepipe.
Visita sig.ra P. ritaglio giorn. decotto angelica indic. p. reumatismi callifugo sig.ra L.
Ore 12 Prova recita Carlo I. N.B. ordinare 1/2 libbra colla 1 barattolo vernice alluminio.
Pranzo [scancellato] Colazione …?
Distribuire rivista parrocchiale. N.B. Sig.ra F. deve 3 scellini e mezzo.
Ore 4,30 pm. Tè Unione delle madri non dimenticare 2 metri e 1/2 cotone p. tende finestre.
Fiori p. chiesa. N.B. 1 lattina lucido metalli.
Cena. Uova strapazzate.
Copiare sermone babbo e il nastro nuovo p. la macchina?
N.B. Sarchiare tra piselli convolvoli disastrosi.
Dorothy uscì dal bagno, e mentre si passava sul corpo un asciugamano appena più grande d’un tovagliolo – al rettorato non potevano permettersi asciugamani di dimensioni decenti – le si sciolsero i capelli e ricaddero sulle spalle in due trecce voluminose. Quei capelli erano copiosi, fini, di un biondo eccessivamente slavato, e forse non era male che suo padre le avesse proibito di tagliarli a zazzera perché formavano la sua unica, effettiva bellezza. Quanto agli altri suoi connotati, era una ragazza di media statura, piuttosto magra ma forte e ben fatta, e il suo punto debole consisteva nel viso: un viso sottile, chiaro, scialbo, dagli occhi pallidi e dal naso appena troppo lungo; a guardarlo da vicino, si scoprivano le zampe di gallina sotto le palpebre, e la bocca, quando stava ferma, appariva stanca. Per il momento, il viso non era decisamente quello d’una zitellona, ma lo sarebbe diventato senza fallo di lì a qualche anno. Ciò nonostante, in genere, gli estranei giudicavano Dorothy parecchio più giovane di quanto non fosse (non aveva ancora compiuto ventott’anni) a causa dell’espressione degli occhi, d’un fervore quasi infantile. Il suo avambraccio sinistro era costellato di minuscoli segni rossi, simili a punture d’insetto.
Dorothy si rimise la camicia da notte e si lavò i denti: con acqua pura, s’intende; meglio non adoprare il dentifricio prima della santa comunione. Dopotutto, si è digiuni sul serio o non lo si è affatto; su questo punto hanno pienamente ragione i cattolici romani… e, pur mentre era così occupata, barcollò all’improvviso e s’interruppe. Posò lo spazzolino. Una fitta mortale, una fitta genuina del fisico, le aveva trapassato le viscere.
Con l’orribile choc con cui rammentiamo qualcosa di sgradevole per la prima volta nel corso della mattina, si era ricordata del conto di Cargill, il macellaio, che rimaneva in sospeso da sette mesi, nientemeno. Quel conto pauroso – poteva ammontare a diciannove o perfino a venti sterline, e non si profilava la più remota speranza di saldarlo – costituiva uno dei precipui tormenti della sua vita. A tutte le ore del giorno o della notte si teneva in agguato dietro un cantuccio della coscienza, pronto a balzarle addosso e ad angosciarla; e lo scortava il ricordo d’una ventina di altri conti minori, che assommavano a un totale cui Dorothy non osava neppur pensare. Quasi involontariamente cominciò una preghiera: «Ti supplico, Dio, fa’ che oggi Cargill non rimandi il conto!». Ma l’attimo seguente decise che questa preghiera era mondana e blasfema, e ne chiese perdono. Quindi infilò la vestaglia e corse giù in cucina, nella speranza di distogliere la mente dal conto del macellaio.
Il fuoco si era spento, secondo il solito. Dorothy tornò ad allestirlo, insudiciandosi le mani di polvere di carbone, lo alimentò daccapo di cherosene e poi rimase inoperosa lì davanti, nell’attesa impaziente che il bricco alzasse il bollore. Suo padre esigeva che l’acqua per la barba fosse pronta alle sei e un quarto. Con sette minuti esatti di ritardo, Dorothy portò il recipiente di sopra e bussò alla porta.
«Avanti, avanti!» disse una voce velata, irascibile.
La camera da letto, tappezzata di pesanti tendaggi, sapeva di rinchiuso misto a un afrore mascolino. Il reverendo Hare aveva acceso la candela sul comodino da notte e stava a giacere su un fianco, guardando l’orologio d’oro che aveva appena tolto da sotto il guanciale. I suoi capelli erano bianchi e spessi come lanugine del cardo. La testa si girò sulla spalla, un occhio nero sfavillante sbirciò irosamente Dorothy.
«Buongiorno, babbo.»
«Ti sarei grato, Dorothy,» disse confusamente il rettore – la sua voce suonava sempre smorzata e senile finché non si era messo la dentiera – «se al mattino tu facessi un minimo sforzo per tirare Ellen giù dal letto; o altrimenti, per essere un po’ più puntuale a tua volta.»
«Scusami tanto, babbo. Il fuoco in cucina non ha fatto altro che spegnersi.»
«Benone! Posa il bricco sulla toletta. Posalo, svelta, e tira quelle tende.»
Adesso era spuntata la luce, ma il giorno si annunciava fosco e nuvoloso. Dorothy risalì in fretta in camera sua e cominciò a vestirsi con la rapidità fulminea con cui si trovava obbligata ad agire sei mattine su sette. Nella stanza c’era soltanto un quadratino di vetro in funzione di specchio, ma lei non adoperò neanche quello. Si limitò semplicemente ad attaccarsi al collo la croce d’oro – una crocetta d’oro disadorna: niente crocifissi, per carità! – e strinse i capelli in una crocchia bassa nella quale inserì un gran numero di forcine piuttosto a casaccio, quindi s’infilò gli indumenti (maglioncino grigio, giacca e sottana di logoro tweed irlandese, calze che non s’intonavano esattamente né alla giacca né alla sottana, e scarpe marrone parecchio consunte) nel lasso di circa tre minuti. Le toccava “sbrigare la pulizia” in stanza da pranzo e nello studio di suo padre prima di andare in chiesa, oltre a recitar le preghiere per prepararsi alla santa comunione, che le prendevano venti minuti come minimo.
Quando Dorothy varcò il cancello del giardino spingendo la bicicletta per il manubrio, il cielo era ancora coperto e l’erba intrisa d’uno spesso strato di rugiada. Attraverso la foschia che fasciava la collina, la chiesa di St Athelstan campeggiava opaca, simile a una sfinge di piombo, con l’unica sua campana che emetteva rintocchi funerei: bum! bum! bum! Una sola delle campane, infatti, era in uso attualmente; le altre sette erano state rimosse dall’armatura e giacevano mute da tre anni a quella parte, spaccando a poco a poco l’impiantito della cella campanaria sotto il loro peso. Di lontano, oltre le nebbie sul fondovalle, giungeva lo squillo stridente di un’altra campana, quella della chiesa cattolica romana: un vile, minuscolo arnese di risonanza metallica, che il rettore di St Athelstan soleva paragonare al campanello d’un venditore ambulante di dolciumi.
Inforcata la bicicletta, Dorothy attaccò la salita del colle sporgendosi sul manubrio. Il dorso del suo naso sottile era arrossato dal freddo di prima mattina. Un beccaccino fischiò dall’alto, invisibile sullo sfondo del cielo nuvoloso. Allo spuntar del giorno il mio canto salirà a Te! Dorothy appoggiò la bicicletta al portico antistante il cimitero, e accortasi di avere le mani ancor grigie di polvere di carbone, s’inginocchiò e si mise a fregarle nell’erba alta bagnata in mezzo alle tombe finché non le vide pulite. Poi, quando la campana tacque, saltò in piedi e si affrettò a entrare in chiesa proprio nel momento in cui Proggett, il sagrestano, in tonaca sbrindellata e grossi stivaloni da bracciante, risaliva pesticciando la navata per prendere il suo posto all’altare laterale.
La chiesa era freddissima e impregnata di odor di cera e di polvere antica. Era grande, fin troppo grande per la congregazione che ospitava, e cadente e più che semivuota. Le tre sottili isolette dei banchi coprivano a mala pena la prima metà della navata, e occupavano lo spazio rimanente ampie distese di nudo pavimento di pietra, nel quale poche iscrizioni consunte contrassegnavano il luogo di tombe vetuste. Al di sopra del coro il tetto pendeva visibilmente; accanto alla cassetta delle offerte per la manutenzione della chiesa due frammenti d’una trave bucherellata spiegavano tacitamente come quel guaio fosse dovuto al nemico mortale della cristianità ch’è il cosiddetto orologio della morte. La luce filtrava pallida attraverso finestre di vetro anemico. Dalla porta a sud, ch’era aperta, si scorgevano un cipresso intristito e i rami d’un tiglio, grigiastri nell’aria senza sole, che oscillavano debolmente.
Secondo il solito, c’era un’altra sola persona in attesa di comunicarsi: la vecchia signorina Mayfill, proprietaria della villa La Masseria. Le presenze alla santa comunione erano talmente rare che il rettore non riusciva nemmeno a procurarsi dei ragazzini che lo servissero, salvo la domenica mattina, quando piace ai fanciulli esibirsi in tonaca e in cotta al cospetto della congregazione. Dorothy entrò nel banco dietro alla signorina Mayfill, e per penitenza di qualche peccato commesso la vigilia, allontanò il cuscino e si genuflesse sulla nuda pietra. L’ufficio divino stava cominciando allora. Il rettore, che indossava la veste talare e la cotta di lino, recitava le preghiere con voce rapida, pratica, abbastanza nitida adesso che aveva la dentiera, e curiosamente scostante. Sul volto anziano, schifiltoso, pallido come una moneta d’argento, gli si leggeva un’espressione di distacco, quasi di disdegno. “Questo è un sacramento valido,” pareva egli dicesse “ed è mio dovere amministrarvelo. Ma ricordate ch’io sono soltanto il vostro sacerdote, non già il vostro amico. In quanto essere umano, vi ho in antipatia e vi disprezzo.” Il sagrestano Proggett, ch’era sulla quarantina e aveva i capelli grigi ricciuti e la faccia rossa, angustiata, gli stava pazientemente al fianco con aria stolida ma riverente, gingillandosi con il campanello della comunione che si perdeva tra le sue grosse mani paonazze.
Dorothy si premette le dita sopra gli occhi. Non era ancora riuscita a concentrare il pensiero… anzi, il ricordo del conto di Cargill la tormentava sempre a frequenti intervalli. Le preghiere, che sapeva a memoria, le passavano inosservate per la testa. Alzò un momento lo sguardo che subito incominciò a smarrirsi; prima verso l’alto, sugli angeli decapitati scolpiti nella volta, sul collo dei quali si potevano vedere ancora gli sfregi inferti dalle spade dei soldati puritani, poi giù, davanti a sé, sul cappello nero della signorina Mayfill dalla cupola piatta e la tesa rialzata, che ricordava un timballo di maiale, e sui suoi tremuli orecchini di giaietto. La signorina Mayfill indossava un lungo cappotto nero, ammuffito, con un colletto di astrakan dall’aria bisunta, ch’era sempre lo stesso cappotto fin dal tempo più remoto di cui Dorothy serbasse memoria. Era di una stoffa davvero singolare, una specie di seta marezzata ma più ruvida, con certi rivoletti di cordoncino che vi scorrevano sopra in lungo e in largo senza che si potesse distinguervi alcun disegno. Forse si trattava perfino di quel tessuto leggendario e proverbiale, la cosiddetta bambagina nera. La signorina Mayfill era vecchissima, così vecchia che nessuno ricordava di averla mai vista diversa. Dalla sua persona emanava un debole profumo: un’essenza eterea, analizzabile in acqua di colonia, naftalina e un vago effluvio di gin.
Dal risvolto della giacca Dorothy estrasse uno spillone con la capocchia di vetro e furtivamente, al riparo del dorso della signorina Mayfill, ne premette la punta sull’avambraccio. La carne si aggricciò in un fremito di apprensione. Ogni volta che si sorprendeva a non por mente alle preghiere, Dorothy osservava la regola di pungersi il braccio con forza sufficiente a farne uscire il sangue. Era la sua forma prescelta di autodisciplina, la salvaguardia contro l’irriverenza e i pensieri sacrileghi.
Tenendo lo spillo pronto fra le di...