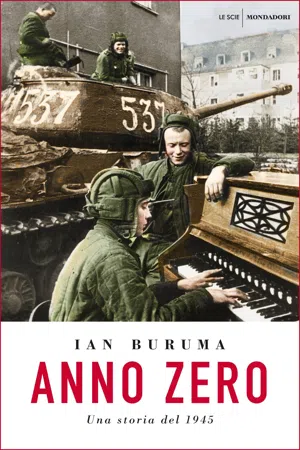Quando in Germania le truppe alleate liberarono dai campi di concentramento, dai campi di lavoro forzato e da quelli per prigionieri di guerra milioni di reclusi del Reich hitleriano caduto, si aspettavano di trovarli docili, debitamente riconoscenti e felici di collaborare in ogni modo possibile con i liberatori. A volte, le cose andarono indubbiamente così. Spesso, invece, si trovarono di fronte a quello che divenne noto come il «complesso della liberazione». Nelle parole vagamente burocratiche di un testimone: «Esso era costituito da desiderio di vendetta, fame ed euforia, tre elementi che, combinati, rendevano gli ex prigionieri, appena liberati, un problema per il loro comportamento, oltre che per la necessità di curarli, nutrirli, disinfettarli e rimpatriarli».1
Il complesso della liberazione non riguardava solo gli ex prigionieri rinchiusi nei campi, ma descriveva anche la situazione di interi paesi liberati, e per qualche aspetto delle nazioni sconfitte.
Io sono nato troppo tardi e in un paese troppo prospero per potere osservare gli effetti della fame. Ma qualche debole eco di desiderio di vendetta e di euforia ho potuto coglierla. Di chi aveva collaborato con il nemico o, peggio, era andato a letto con lui, ci si continuava a vendicare silenziosamente, quasi surrettiziamente, per lo più a livelli molto bassi. Non si andava a fare la spesa in un certo negozio, o a comprare le sigarette in un altro, perché «tutti» sapevano che i loro proprietari si erano «comportati male» durante la guerra.
Quanto all’euforia, in Olanda fu istituzionalizzata attraverso la sua trasformazione in un rito annuale: il 5 maggio, giorno della Liberazione.
Per quello che ricordo dall’infanzia, il 5 maggio splendeva sempre il sole, le campane delle chiese suonavano, e bandiere rosse, bianche e blu fremevano alla leggera brezza primaverile. Il 5 dicembre, giorno di San Nicola, è una festa familiare forse più importante, ma il giorno della Liberazione è un grande spettacolo di gioia patriottica, o almeno lo era negli anni Cinquanta e Sessanta, quelli della mia infanzia e adolescenza. Considerando che gli olandesi, il 5 maggio 1945, non si liberarono dall’occupazione tedesca da sé ma furono liberati da truppe canadesi, britanniche, americane e polacche, l’annuale ostentazione di orgoglio patriottico è un po’ curiosa. E tuttavia, siccome agli olandesi, come agli americani e ai britannici, piace credere che a definire l’identità nazionale sia la libertà, si può anche capire che la sconfitta della Germania si sia confusa nella coscienza nazionale con la memoria collettiva della sconfitta della corona spagnola nella guerra degli Ottant’anni,a a cavallo fra il XVI e il XVII secolo.
A quelli della mia generazione, nati appena sei anni dopo la guerra, spuntano facilmente agli occhi lacrime sentimentali di fronte a immagini di zampognari scozzesi che marciano sotto il fuoco delle mitragliatrici su una spiaggia della Normandia o di cittadini francesi che cantano la Marsigliese, di cui, ovviamente, non hanno alcun ricordo personale, se non attraverso le scene dei film di Hollywood. Qualcosa della vecchia euforia tuttavia la vidi di persona, esattamente cinquant’anni dopo il 5 maggio 1945, quando per celebrare l’anniversario fu rimesso in scena l’arrivo dei soldati dell’esercito canadese ad Amsterdam. Che le truppe alleate non vi fossero arrivate che l’8 maggio non conta. L’evento originale dovette essere straordinario. Lo racconta così un corrispondente di guerra britannico che vi assistette: «Ci baciano, piangono sulle nostre spalle, ci abbracciano, ci danno manate, ci urlano e strillano in faccia fino a lasciarci pieni di lividi ed esausti. Gli olandesi hanno messo a sacco i loro giardini, e la pioggia di fiori che cade sui veicoli alleati è interminabile».2
Cinquant’anni più tardi, anziani canadesi, in strette e sbiadite uniformi da battaglia, coperte di medaglie, rifecero il loro ingresso in città su vecchie jeep e autoblindo, salutando la folla con le lacrime agli occhi, ricordando i giorni in cui erano i re, giorni che i loro nipoti dovevano essere da tempo stufi di sentirsi raccontare, giorni di euforia in cui quegli eroi di guerra non si erano ancora stabiliti a Calgary o Winnipeg a fare i dentisti o i ragionieri.
Più di quei vecchi che rivivevano i loro giorni migliori, a colpirmi fu il comportamento delle anziane donne olandesi, vestite da rispettabili matrone quali indubbiamente erano. In preda a una sorta di estasi adolescenziale, smaniavano, strillavano come ragazzine a un concerto rock, tendendo le braccia verso gli uomini sulle jeep, cercando di toccare le loro uniformi: «Thank you! Thank you! Thank you!». Non riuscivano a contenersi. Stavano rivivendo quelle ore di euforia, anche loro. Fu una delle scene più stranamente erotiche cui avessi mai assistito.
* * *
In realtà, come ho già osservato, i canadesi non giunsero ad Amsterdam il 5 maggio, né la guerra finì ufficialmente quel giorno. Il 4 maggio, è vero, il grande ammiraglio Hans-Georg von Friedeburg e il generale Eberhard Hans Kinzel si recarono alla tenda del feldmaresciallo Bernard Montgomery («Monty») nella Lüneburger Heide a dichiarare la resa di tutte le forze tedesche nel Nordovest della Germania, in Olanda e in Danimarca. Un giovane ufficiale dell’esercito britannico, Brian Urquhart, vide le Mercedes-Benz dei tedeschi correre su una strada di campagna verso il quartier generale di Monty. Erano passate poco più di due settimane da quando era entrato, fra i primi ufficiali alleati, nel vicino campo di concentramento di Bergen-Belsen, dove la maggior parte dei prigionieri liberati «sembrava non essere in grado di capire alcun linguaggio articolato, anche ammesso che ne avessimo trovato uno in comune». Quelli che da lontano gli parvero tronchi erano cumuli di cadaveri che si stendevano «fin dove giungeva lo sguardo».3 Quando pochi giorni dopo l’ammiraglio von Friedeburg, ancora avvolto in uno splendido cappotto di pelle, fu posto di fronte a un rapporto statunitense sulle atrocità tedesche, lo prese come un insulto al suo paese e andò su tutte le furie.
Il 6 maggio, in una fattoria semidistrutta presso Wageningen, si svolse un’altra cerimonia: il generale Johannes Blaskowitz dichiarò la resa delle sue truppe al tenente generale canadese Charles Foulkes. Di Arnhem era rimasto ben poco, a quel punto. Era stata ridotta in macerie nel settembre 1944, quando britannici, americani e polacchi avevano cercato di aprirsi la strada attraverso l’Olanda nella catastrofica campagna militare nota come operazione Market Garden. Fra coloro che avevano visto il disastro avvicinarsi c’era Brian Urquhart, allora ufficiale dell’intelligence agli ordini di uno dei principali strateghi dell’operazione, il generale Frederick Arthur Montague «Boy» Browning, uomo pieno di fascino dalle mani grondanti di sangue. Quando Urquhart mostrò al suo superiore le prove fotografiche delle brigate corazzate tedesche, che attendevano, intorno ad Arnhem, di spazzare via gli Alleati, si sentì invitare a prendersi una licenza per malattia. A nessuno, certamente non a un umile ufficiale dell’intelligence, poteva essere permesso di rovinare la «festa»b di Monty.
Ma la guerra non era ancora finita, nemmeno in Olanda. Il 7 maggio, in previsione dell’imminente arrivo delle truppe britanniche e canadesi trionfanti, una folla si radunò nel Dam, la piazza principale di Amsterdam, di fronte al Palazzo Reale, lanciando grida di giubilo, ballando, cantando e sventolando la bandiera arancione della famiglia reale olandese. Vedendo quello spettacolo festoso, dalle finestre di un circolo esclusivo, gli ufficiali di marina tedeschi, in un ultimo accesso di rabbia, decisero di sparare sulla folla con una mitragliatrice montata sul tetto. Morirono ventidue persone e oltre un centinaio rimasero gravemente ferite.
Non fu neppure questo, comunque, l’ultimo episodio di violenza della guerra. Il 13 maggio, oltre una settimana dopo il giorno della Liberazione, vennero giustiziati due uomini, due tedeschi antinazisti che avevano disertato dall’esercito del Reich e si erano nascosti fra gli olandesi. La madre di uno di loro era ebrea. Il 5 maggio erano usciti dai loro nascondigli e si erano uniti alla resistenza olandese, che li aveva consegnati ai canadesi. Dopodiché caddero vittime di un tipico pasticcio da tempo di guerra. Quando Montgomery, il 4 maggio, aveva accettato la resa nazista, non c’erano abbastanza truppe alleate in Olanda per disarmare i tedeschi, né per dare da mangiare ai prigionieri di guerra. In quella primissima fase agli ufficiali del Reich era stato concesso di rimanere al comando dei loro uomini. I due sfortunati disertori furono portati insieme con altri soldati tedeschi in un impianto di assemblaggio in disuso della Ford fuori Amsterdam. Gli ufficiali tedeschi, ansiosi di affermare per l’ultima volta la propria autorità, misero in piedi in tutta fretta una corte marziale e i due vennero condannati a morte. Le armi per l’esecuzione dei «traditori» furono chieste ai canadesi i quali, incerti sulle regole al riguardo e desiderosi di non turbare il temporaneo accordo, acconsentirono alla richiesta. Subito dopo, i due uomini vennero giustiziati. Altri, sembra, andarono incontro a un destino simile, finché i canadesi, un po’ troppo tardi, posero fine a quelle pratiche.4
La data ufficiale della fine della guerra in Europa, la Giornata della Vittoria, fu l’8 maggio. Anche se la resa incondizionata di tutte le truppe tedesche venne firmata nell’edificio di una scuola di Reims la sera del 6 maggio, le celebrazioni dovettero attendere. Stalin era infuriato con il generale Eisenhower, che aveva avuto la presunzione di accettare la resa tedesca sul fronte orientale oltre che su quello occidentale, un privilegio che, a suo avviso, spettava solo ai sovietici a Berlino. Pretese quindi di rinviare la Giornata della Vittoria al 9 maggio, il che, a sua volta, irritò Churchill.
In tutta la Gran Bretagna la gente era già indaffarata a cuocere il pane per i sandwich celebrativi, erano già stati preparati striscioni e bandiere, e le campane delle chiese erano in attesa di essere suonate. Nella confusione generale, furono i tedeschi ad annunciare per primi la fine della guerra in una trasmissione radio da Flensburg, dove l’ammiraglio Karl Dönitz era ancora nominalmente a capo di ciò che restava del Reich tedesco a pezzi. L’annuncio fu ripreso dalla BBC e, ben presto, vennero strillate per le strade edizioni straordinarie dei quotidiani francesi, britannici e statunitensi. A Londra, una grande folla si raccolse attorno a Piccadilly Circus e Trafalgar Square in attesa che Churchill annunciasse la vittoria e la più grande festa della storia potesse finalmente avere inizio. Sulle vie di New York iniziarono a piovere striscioline di carta, alla maniera di coriandoli e stelle filanti. Ma nessun leader alleato aveva ancora annunciato ufficialmente che la guerra con la Germania era finita.
Finché l’8 maggio, poco prima di mezzanotte, nel quartier generale sovietico di Karlshorst, vicino al vecchio campo di lavoro di mio padre, il maresciallo Georgij Žukov, lo spietato genio militare, accettò finalmente la resa tedesca. Ancora una volta, l’ammiraglio von Friedeberg pose la propria firma sotto la dichiarazione della sconfitta nazista. Il feldmaresciallo Wilhelm Keitel, rigido e inespressivo militare prussiano dalla testa ai piedi, manifestò ai sovietici il suo orrore per l’entità delle distruzioni inflitte alla capitale della Germania, al che un ufficiale russo gli chiese se avesse provato altrettanto orrore quando, su suo ordine, migliaia di paesi e città dell’Unione Sovietica erano stati cancellati dalla faccia della terra e milioni di persone, fra cui un gran numero di bambini, erano rimasti sepolti sotto le macerie. Keitel si strinse nelle spalle e non rispose.5
Poi Žukov chiese ai tedeschi di uscire, e i sovietici, insieme con gli alleati americani, inglesi e francesi, festeggiarono in grande stile con discorsi strappalacrime ed enormi quantità di vino, cognac e vodka. Il giorno seguente in quella stessa stanza si tenne un banchetto, durante il quale Žukov brindò a Eisenhower come a uno dei più grandi generali di tutti i tempi. I brindisi si ripeterono a non finire e i generali russi, fra cui lo stesso Žukov, ballarono, fino a quando non rimasero che pochi uomini in grado di reggersi sulle proprie gambe.
L’8 maggio, a New York, la folla era impazzita. E anche a Londra uomini e donne si stavano riversando per le strade, ma tra i britannici regnava ancora uno strano silenzio, come se per dare inizio ai festeggiamenti si stesse aspettando la voce di Churchill. Questi, che aveva deciso di ignorare il desiderio di Stalin di rinviare la Giornata della Vittoria al 9, avrebbe parlato alle tre di pomeriggio. A quell’ora il presidente americano Truman aveva già annunciato la vittoria. Il generale Charles de Gaulle, non volendo essere messo in ombra da Churchill, insistette per fare il proprio annuncio ai francesi nello stesso preciso momento del leader britannico.
Il discorso di Churchill alla BBC giunse per radio in tutto il mondo. Parliament Square, davanti a Westminster, dov’erano stati installati degli altoparlanti, era piena all’inverosimile. Per la pressione, la gente era schiacciata contro i cancelli di Buckingham Palace. Nel West End le auto non riuscivano più ad aprirsi un varco tra la folla. Il Big Ben suonò tre volte. Tutti tacquero, e finalmente dagli altoparlanti tuonò la voce di Churchill: «La guerra tedesca è dunque alla fine. … Quasi l’intero mondo s’è unito contro i malvagi, che sono ora prostrati davanti a noi. … Adesso dobbiamo consacrare tutte le nostre forze e risorse a portare a termine il nostro compito, in patria e all’estero». Qui la sua voce si ruppe: «Avanti, Britannia! Viva la causa della libertà! Dio salvi il Re». Poco dopo, dal balcone del ministero della Sanità, fece il segno V di vittoria. «Dio vi benedica tutti. Questa è la vostra vittoria!» La folla rispose urlando: «No! È la tua!».
Il «Daily Herald» riferì: «Il centro cittadino ha visto straordinarie scene di tripudio. La folla era irrefrenabile. Si lanciava in ovazioni, ballava, rideva, assaliva gli autobus, saltava sui tetti delle macchine. Un cartellone è stato divelto per accendere falò in strada. La gente baciava i poliziotti e li trascinava nei balli. … Gli automobilisti salutavano la vittoria pigiando sul clacson. Sul fiume è echeggiato per tutta la notte l’ululato delle sirene di rimorchiatori e battelli».
Da qualche parte, in quella folla, c’era mia madre diciottenne, cui il collegio aveva concesso un giorno libero, e suo fratello minore. Mia nonna, Winifred Schlesinger, figlia d’immigrati ebrei tedeschi, aveva tutte le ragioni per essere felice, e la sua idolatria per Churchill non conosceva limiti. Ma era preoccupata che in quella folla «eccitata, ubriaca, specie gli yankee», i suoi figli potessero perdersi.
A New York, per le strade festeggiarono 500.000 persone. Il coprifuoco fu tolto. I club – il Copacabana, il Versailles, il Latin Quarter, il Diamond Horseshoe, El Morocco – furono presi d’assalto e rimasero aperti fino alle prime ore del mattino. Lionel Hampton suonò allo Zanzibar, Eddie Stone all’Hotel Roosevelt Grill, e al ristorante Jack Dempsey’s furono servite «porzioni gigantesche».
A Parigi, in Place de la République, un giornalista del quotidiano «Libération» vide «una massa di gente in movimento da cui spuntava un’infinità di bandiere alleate. Un soldato americano barcollava sulle sue lunghe gambe e, facendo strani sforzi per non perdere l’equilibrio, cercava di scattare fotografie; dalle tasche kaki gli spuntavano due bottiglie di cognac, una vuota e una ancora pi...