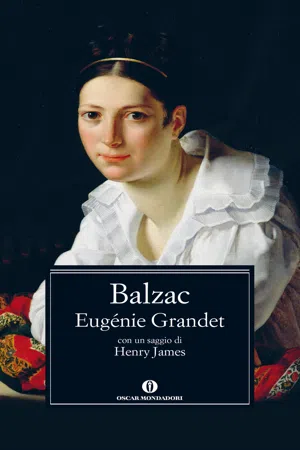Esistono in talune città di provincia case la cui vista suscita una malinconia simile a quella che provocano i più cupi chiostri, le più squallide lande, le più tristi rovine. E forse in queste case ci sono insieme il silenzio dei chiostri, l’aridità delle lande, l’ossame delle rovine. Così sommessi vi sono la vita e il movimento che un estraneo le crederebbe disabitate se non gli accadesse d’un tratto di incrociare lo sguardo morto e freddo di un essere immobile, il cui volto quasi monacale si sporge dalla finestra al rumore di un passo sconosciuto. Questi tratti malinconici si trovano in una casa di Saumur,2 situata al termine della salita che passando per la parte alta della città conduce al castello. La strada, oggi poco frequentata, calda d’estate, fredda in inverno, in certi punti buia, si distingue per la sonorità del fondo acciottolato, sempre pulito e asciutto, per la strettezza della carreggiata tortuosa, per il silenzio delle case che fanno parte della città vecchia e sulle quali incombono i bastioni. Vi si osservano dimore vecchie di tre secoli, ancora solide benché costruite in legno, che con le loro diverse caratteristiche contribuiscono all’originalità di questa parte di Saumur, e la rendono interessante per antiquari e artisti. È difficile passare davanti a queste case senza ammirarne le enormi travi intagliate alle estremità a formare figure bizzarre, bassorilievi scuri incornicianti la maggior parte dei piani terreni. Qui assi trasversali coperte di ardesia tracciano linee blu sui fragili muri di una casa sormontata da un tetto a colombage incurvato dagli anni, le cui assicelle marce si sono imbarcate per l’azione alterna della pioggia e del sole. Là si vedono davanzali consunti e anneriti, che si direbbero troppo fragili per reggere il vaso di terracotta da cui spuntano i garofani o il rosaio di una povera operaia. Più in là, ecco porte con borchie enormi su cui l’inventiva dei nostri avi ha tracciato geroglifici domestici, di cui nessuno riuscirà mai più a decifrare il significato. Un protestante vi ha proclamato la sua fede, un membro della Ligue vi ha maledetto Enrico IV,3 un borghese vi ha inciso le insegne della sua nobiltà di carica, la gloria del suo obliato scabinato.4 C’è lì, tutta intera, la Storia di Francia. Accanto alla casa malferma le cui intercapedini sono riempite di brecciame, dove l’artigiano ha dato prova di sublime perizia nell’uso della pialla, si erge la dimora di un gentiluomo che reca ancora sull’arco del portale di pietra qualche traccia del suo stemma, spezzato dalle varie rivoluzioni che dal 1789 hanno scosso il paese. In questa strada, i piani terreni adibiti ad attività commerciali non sono né negozi né magazzini: gli amanti del Medio Evo vi ritroverebbero il laboratorio bottega dei nostri padri in tutta la sua ingenua semplicità. Questi locali bassi, senza esposizioni né vetrine, sono profondi, bui, disadorni all’interno e all’esterno. La porta è a due battenti con rozzi serramenti: quello superiore si piega verso l’interno, quello inferiore, fornito di un campanello a molla, è sempre in moto. L’aria e la luce penetrano in questa specie di antro umido o dall’alto della porta o dall’apertura fra la volta, il piancito e il basso muretto nel quale si incastrano solide imposte tolte il mattino, rimesse la sera e assicurate con spranghe di ferro bullonate. Il muretto serve per esporre le mercanzie del negoziante. Nessun allettamento ciarlatanesco. Secondo il tipo di commercio, il campionario consta di due o tre barilotti di sale e di merluzzo, di qualche pacco di tela per vele, di corda, di filo d’ottone appeso ai travetti del soffitto, di cerchioni appoggiati alle pareti, di qualche pezza di stoffa sistemata su scaffali. Entrate e una ragazza linda, fresca, con uno scialletto bianco, con le braccia arrossate, interromperà il lavoro a maglia e chiamerà il padre o la madre, che verranno a vendervi, con flemma, garbo o arroganza, secondo il loro carattere, quel che vorrete, due soldi o ventimila franchi di merce. Vedrete un commerciante di doghe seduto sull’uscio a girare i pollici chiacchierando con un vicino: sembra possedere solo dei brutti scaffali per bottiglie e due o tre fasci di doghe, ma nel porto il suo magazzino zeppo di merce fornisce tutti i bottai dell’Anjou.5 Tavola più tavola meno, egli è in grado di prevedere quante botti potrà fare se l’annata è buona. Un colpo di sole lo arricchisce, una pioggia lo rovina. In una mattinata il barile può passare da undici a sei franchi. In questo paese, come in Touraine, le vicende atmosferiche condizionano il commercio. Vignaiuoli, proprietari, commercianti di legname, bottai, albergatori, marinai sono tutti lì a spiare un raggio di sole, vanno a letto la sera con la paura di apprendere l’indomani mattina che durante la notte c’è stata una gelata, temono la pioggia, il vento, la siccità, e vorrebbero l’acqua, il caldo, le nubi secondo le loro esigenze. C’è fra il cielo e gli interessi terreni una lotta costante. Il barometro rende i visi di volta in volta tristi, sereni, allegri. Da un capo all’altro di questa via, che è l’antica Grand-Rue-de-Saumur, di porta in porta si sente ripetere: «È un tempo d’oro!». E al vicino si risponde: «Piovono luigi» sapendo quanti gliene porteranno un raggio di sole o una pioggia al momento giusto. Nella bella stagione, di sabato verso mezzogiorno, non riuscireste ad avere da questi bravi commercianti neanche un soldo di merce. Ciascuno ha la sua vigna, il suo poderetto e va a passare due giorni in campagna. Poiché là tutto è previsto, acquisti, vendite, profitti, i commercianti si trovano a disporre di dieci ore su dodici, da impiegare in allegri trattenimenti, in un continuo osservare, commentare, spiare. Una massaia non può comprare una pernice senza che i vicini domandino poi al marito se è stata cucinata bene. Una ragazza non può mettere il capo alla finestra senza farsi notare da tutti i crocchi di sfaccendati. Le coscienze sono libri aperti, non hanno segreti, come non ne hanno quelle case impenetrabili, nere e silenziose. Si vive quasi sempre all’aria aperta: le famiglie siedono davanti alla porta, vi pranzano, vi cenano, litigano. Nessuno può passare per strada senza essere attentamente esaminato. È proprio come un tempo, quando un forestiero, se capitava in una città di provincia, veniva fatto oggetto di porta in porta di commenti beffardi. Da ciò gli aneddoti ameni, e l’appellativo di tagliapanni dato agli abitanti di Angers,6 che eccellevano in queste mordacità cittadine. Gli antichi palazzi della città vecchia sono situati nella parte alta di questa strada, abitata un tempo dai gentiluomini del paese. La malinconica casa dove accadde ciò che questa storia racconta era appunto una di queste dimore, sopravvivenze venerabili di un secolo in cui le cose e la gente avevano quella semplicità che il costume francese va via via perdendo. Dopo avere seguito le curve di questa pittoresca strada, le cui più piccole irregolarità richiamano ricordi, e il cui effetto generale è quello di suscitare una sorta di fantasticheria, si scorge una rientranza alquanto buia, al cui centro si trova, nascosta, la porta della casa di monsieur Grandet. Impossibile capire il valore di questa espressione provinciale senza conoscere la biografia del personaggio in questione.
A Saumur Grandet7 godeva di una reputazione le cui radici e i cui effetti non possono essere compresi appieno da chi non abbia vissuto per poco o per molto in provincia. Nel 1789 monsieur Grandet, o, come alcuni vegliardi, che andavano però diminuendo sensibilmente di numero, ancora lo chiamavano, papà Grandet, era un mastro bottaio molto agiato, che sapeva leggere, scrivere e far di conto. Quando la Repubblica mise in vendita nel distretto di Saumur i beni del clero,8 il bottaio, che aveva allora quarant’anni, si era appena sposato con la figlia di un ricco commerciante di legname. Con in tasca duemila luigi d’oro, il denaro liquido che possedeva e la dote della moglie, Grandet si recò al distretto e grazie a duecento doppi luigi, offerti dal suocero al grintoso repubblicano che sovraintendeva alla vendita dei beni nazionali, si prese per un pezzo di pane, legalmente se non legittimamente, i più bei vigneti del circondario, una vecchia abbazia e alcune fattorie. Gli abitanti di Saumur non erano dei grandi rivoluzionari, sicché papà Grandet fu giudicato un uomo audace, repubblicano, patriota, uno spirito che tendeva alle idee nuove, mentre, molto semplicemente, tendeva alle vigne. Fu chiamato a far parte dell’amministrazione del distretto, e il suo spirito conciliante esercitò una certa influenza sul piano politico e commerciale. Politicamente, protesse gli aristocratici e si oppose con tutte le sue forze alla vendita dei beni degli emigrati; commercialmente, fornì agli eserciti repubblicani un migliaio o due di botti di vino bianco, facendosi pagare con bellissimi prati che facevano parte dei possedimenti di una comunità religiosa femminile ed erano stati riservati come ultimo lotto. Sotto il Consolato, il bravo Grandet divenne sindaco, amministrò oculatamente e vendemmiò ancor meglio. Sotto l’Impero fu monsieur Grandet. Napoleone, che non amava i repubblicani, mise al posto di Grandet, che passava per avere portato il berretto frigio, un grosso proprietario terriero, il cui nome recava la particella nobiliare, futuro barone dell’Impero. Grandet rinunciò senza rimpianti alla carica municipale. Nell’interesse cittadino aveva fatto costruire ottime strade che conducevano alle sue proprietà. La sua casa e i suoi beni, iscritti nel catasto per cifre modiche, pagavano poche imposte. Dopo la classificazione dei suoi vari poderi, le sue vigne, grazie a cure assidue, erano diventate capofila della zona, termine tecnico per designare quelle che producevano la migliore qualità di vino. Grandet avrebbe potuto chiedere la croce della Legion d’Onore.9 Ciò avvenne nel 1806.10 Egli aveva allora cinquantasette anni e sua moglie circa trentasei. Frutto dei loro legittimi amori, un’unica figlia di dieci anni. Grandet, che la Provvidenza volle forse consolare per la perdita della sua carica nella pubblica amministrazione, ereditò in quell’anno da madame de La Gaudinière, nata de La Bertellière, madre di madame Grandet, poi dal vecchio La Bertellière, padre della defunta, infine da madame Gentillet, nonna materna. Tre eredità della cui entità nessuno seppe nulla. L’avarizia di quei tre vecchi era così travolgente che da parecchio tempo accumulavano i soldi per poterli contemplare in segreto. Per il vecchio La Bertellière un investimento era una prodigalità: lo interessava di più la vista dell’oro che l’utile ricavabile dall’usura. Saumur valutò quindi il valore di quelle sostanze basandosi sul reddito dei beni al sole. Grandet ottenne allora quel nuovo titolo di nobiltà che la nostra smania d’eguaglianza non riuscirà mai a fare sparire, diventò il maggiore contribuente del distretto. Coltivava cento arpenti di vigneto, che nelle annate buone gli davano da sette a ottocento barili di vino. Possedeva tredici fattorie, una vecchia abbazia di cui per economia aveva fatto murare, in questa maniera assicurandone la conservazione, finestre, ogive e vetrate,11 e centoventisette arpenti di prato su cui crescevano e si irrobustivano tremila pioppi piantati nel 1793. Infine, era di sua proprietà la casa in cui abitava. Questi i beni visibili. Quanto alle disponibilità liquide, due sole persone erano in grado di valutarne approssimativamente la consistenza: una era Cruchot, il notaio che si occupava dei prestiti a interesse che faceva Grandet; l’altra des Grassins, il più ricco banchiere di Saumur, alle cui operazioni lucrose il vignaiuolo partecipava segretamente quando voleva. Benché il vecchio Cruchot e des Grassins fossero dotati di quella profonda discrezione che in provincia procurano fiducia e ricchezza, manifestavano in pubblico un enorme rispetto per Grandet: la gente poteva così arguire l’entità dei capitali dell’ex sindaco dalla considerazione ossequiosa di cui era oggetto. Non v’era a Saumur nessuno che non fosse convinto che Grandet possedesse un tesoro, un nascondiglio pieno di luigi, e che non si abbandonasse nottetempo alle gioie ineffabili che procura la vista di una grande quantità di oro. Gli avari ne acquisivano quasi la certezza, osservando gli occhi del brav’uomo, ai quali il metallo giallo sembrava avere comunicato il suo colore. Lo sguardo di un uomo avvezzo a ricavare immensi benefici dai suoi capitali acquista inevitabilmente, come quello delle persone sensuali, dei giocatori e dei cortigiani, delle abitudini indefinibili, dei moti furtivi, avidi, misteriosi che non sfuggono ai suoi correligionari. Questo linguaggio segreto forma in qualche modo la massoneria delle passioni. Grandet ispirava dunque la rispettosa stima alla quale aveva diritto un uomo che non doveva mai nulla a nessuno, che da bottaio e vignaiuolo esperto prevedeva con esattezza astronomica quando era il caso di fabbricare per la raccolta mille o solo cinquecento barili, che non si lasciava scappare una sola occasione di fare un affare, che aveva sempre botti da vendere quando le botti valevano più del vino, che poteva riportare la sua vendemmia in ...