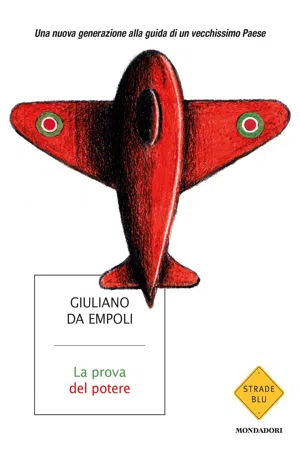Le superfici sfavillanti dei grattacieli di Shenzhen dissimulano in realtà un grosso equivoco. L’idea che il boom cinese sia il frutto della tabula rasa: un miracolo istantaneo generato dal deserto della Rivoluzione culturale, come questa vorticosa «città generica» passata da cinquecentomila a più di dieci milioni di abitanti, solo nel giro di una manciata di anni. In realtà è vero il contrario: la rinascita cinese ha radici profondissime, che affondano nella storia millenaria del Regno di Mezzo. E nell’azione visionaria di un piccolo generale originario delle campagne del Sichuan.
Nell’autunno del 1977, Deng Xiaoping non è ancora il leader incontrastato della nazione più popolosa della storia dell’umanità. Al contrario, è stato riabilitato solo da un paio di mesi, dopo l’ennesimo tentativo da parte di Mao di farlo fuori. Ora, però, il Grande Timoniere è finalmente uscito di scena e, a settantatré anni, questo inossidabile guerriero alto poco più di un metro e mezzo, quasi completamente sordo dall’orecchio destro, morto e risorto innumerevoli volte a Parigi, a Mosca e a Pechino, sente che il suo momento è finalmente arrivato.
Al pallido Hua Guofeng, designato da Mao come proprio erede, ha chiesto una sola cosa. Lascia che mi occupi della cultura. Tu continua pure a presiedere il Comitato centrale del partito, a dirigere l’esercito, a difendere la memoria putrescente dell’ultimo imperatore. Io vorrei consacrare gli anni che restano della mia vita tormentata a rinverdire i fasti della scienza che ha donato al mondo la stampa, la bussola e la polvere da sparo.
In un paese dove le università sono sostanzialmente chiuse da un decennio e le migliori menti sono state spedite a zappare la terra negli anni della Rivoluzione culturale, quella di Deng sembra quasi una provocazione. Ma come! Il Grande Timoniere ha cercato di cancellare ogni traccia della cultura cinese, ha perseguitato gli studiosi di ogni disciplina, ha perfino demolito la casa di Confucio, alla quale gli imperatori avevano reso omaggio per secoli, e ora, con il cadavere di Mao ancora caldo, minacciosamente esposto in un sarcofago di cristallo da cui sembra pronto a saltar fuori da un attimo all’altro, il rinnegato Deng, da poco riabilitato, vuole occuparsi di cultura?
C’è di peggio. Appena riammesso allo Zhongnanhai – la vera Città Proibita dove si decidono ogni giorno le sorti di un miliardo di uomini – Deng si è già rimesso in viaggio. E anziché dirigersi verso le regioni interne, sulle quali Mao ha concentrato per decenni tutti gli sforzi e gli investimenti del regime, ha imboccato la direzione opposta.
Agli inizi di novembre Deng Xiaoping sbarca a Guangzhou, l’antica Canton. E capisce. La rinascita della potenza cinese può partire da qui. Non dalle acciaierie rurali del Grande balzo in avanti (38 milioni di morti per fame). Non dalla tabula rasa della Rivoluzione culturale (3 milioni di vittime di morte violenta e decine di milioni di torturati e di deportati). Ma da questo porto antichissimo e ribelle, vessato da generazioni di imperatori del Nord, che hanno sempre diffidato della sua insopprimibile autonomia.
Al contrario di Mao, Deng non è uno storico. Non ha trascorso mesi a compulsare le intricate genealogie degli imperatori o i trattati degli strateghi dei Regni combattenti. Non ha composto versi immortali mentre i soldati lo trasportavano in portantina tra le montagne del Guizhou. Una cosa però gli è chiara. Non si parte da zero. Neppure il sovrano assoluto che ha sotto di sé un miliardo di anime ha il potere di riscrivere il passato.
A furia di rifondazioni, di ore X e di palingenesi, la Cina è ormai allo stremo: infrastrutture devastate, fabbriche ferme alla tecnologia sovietica degli anni Cinquanta, l’ottanta per cento della popolazione in miseria nelle campagne, con un reddito medio di quaranta dollari l’anno, e il resto in città, dove il lavoro non c’è e il potere è nelle mani di militari incompetenti e corrotti. La Repubblica popolare ha bisogno di capitali, di tecnologie e, soprattutto, di uomini che abbiano la forza di ricominciare a costruire sulle macerie di trent’anni di dittatura. Ma dove prendere tutto ciò quando le casse dello Stato sono vuote e le migliori intelligenze prostrate da decenni di umiliazioni?
La risposta non si trova nelle elucubrazioni degli ideologi del partito, bensì nella storia millenaria del Celeste Impero. Canton è, da sempre, la capitale di un’altra Cina. Una potenza affacciata sul mare, curiosa del mondo, aperta agli scambi. Di qui partirono, oltre duemila anni fa, i leggendari mercanti di Yueh, che setacciavano il globo in cerca di affari. Di qui si snodava la via della porcellana, quando, sotto la dinastia Tang, risiedevano in città oltre duecentomila forestieri, impegnati in ogni genere di traffici. Di qui, infine, si sono mossi milioni di emigranti che hanno colonizzato tutti i porti del Sudest asiatico: le grandi famiglie dei cinesi d’oltremare che ancora oggi governano le economie della Malesia, dell’Indonesia, della Thailandia, del Vietnam. Non è certo un caso se a pochi chilometri da qui la corona britannica ha fondato la sua colonia più prospera e dinamica: Hong Kong, ciò che la Cina potrebbe diventare se solo tornasse a essere se stessa.
Per giorni, Deng ascolta le critiche e le proposte dei notabili di Guangzhou. La città è in pessime condizioni. Mao, che diffidava delle coste e puntava solo sulle province interne della Cina, ha deliberatamente mortificato l’antica Canton. In trent’anni, il numero di linee telefoniche non è cresciuto di una sola unità, così come il numero dei ponti che attraversano il maestoso delta del Fiume delle Perle.
Eppure qui nessuno ha perso la speranza. «Poco importa se il governo centrale non ha risorse da investire» dicono. «I capitali li porteranno altri, se solo gli daremo la possibilità di farlo.» A Guangzhou, Deng capisce che la rete millenaria dei cinesi d’oltremare è viva e vegeta, e aspetta solo di essere attivata per inondare la madrepatria di iniziative, di investimenti e di conoscenze. Dietro l’angolo ci sono i cugini di Hong Kong che non hanno più spazio per ingrandire le loro fabbriche e sognano la manodopera cinese a bassissimo costo. Poi, al di là della colonia, ci sono milioni di cantonesi che hanno fatto fortuna a Singapore, a Kuala Lumpur e a San Francisco, e non aspettano altro che di poter tornare a investire sulle terre ancestrali.
Rientrato a Pechino, Deng dà immediatamente seguito all’intuizione di Guangzhou. Avvia le procedure per la costituzione di tre «zone economiche speciali» collocate nelle vicinanze dell’antica Canton (e per una più a nord, sulle coste del Fujian, l’altra regione di origine dei cinesi d’oltremare). Lì le regole dell’economia pianificata cesseranno di avere corso e, al loro posto, si sperimenteranno le virtù di una via cinese al capitalismo: il minimo di regole e la massima apertura possibile agli investimenti dall’estero. Dopo dieci anni di Rivoluzione culturale maoista, è il segnale che i cinesi d’oltremare aspettavano: la Cina ha smesso di sognare la tabula rasa ed è pronta a riassumere il ruolo che le spetta, sulla base della propria cultura e della propria storia.
Nel suo piccolo, anche l’Italia ha vissuto una rivoluzione culturale. Meno sanguinaria, ma più prolungata di quella cinese. Nel corso degli ultimi vent’anni abbiamo tentato in tutti i modi di smettere di essere noi stessi per diventare qualcos’altro. Il paese dei balocchi di Berlusconi: una specie di sogno americano adattato ai gusti delicati di un oligarca russo. Il paese normale di D’Alema: una sorta di utopia germanica vista attraverso lo sguardo allegro di un impiegato statale bulgaro.
Il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi. Un paese più povero e meno presente sulla scena del mondo. Smarrito come se l’avessero ibernato per poi risvegliarlo dopo un quarto di secolo.
Mi pare evidente che se non riusciamo più a vedere una prospettiva è perché abbiamo smarrito la memoria. Di ciò che siamo e di dove vogliamo andare. La rivoluzione culturale italiana è prima di tutto questo: una forma di amnesia radicale che ha colpito le nostre classi dirigenti e l’opinione pubblica nel suo insieme. Come se fossimo a Pechino, il 13 giugno 1966, quando Mao sospende le lezioni nelle scuole e nelle università. «A Pechino non c’è abbastanza caos» proclama. «Pechino è troppo educata.» E spedisce le guardie rosse a distruggere i templi del sapere.
Le élite che hanno governato l’Italia nel corso degli ultimi decenni hanno fatto di tutto per cancellare la memoria. A furia di svolte e di rifondazioni, di continui cambi di nome e di posizione, risoltisi il più delle volte in patetiche scopiazzature di modelli stranieri, i cosiddetti leader della Seconda Repubblica hanno prodotto una sorta di Alzheimer collettivo, il cui principale risultato è stato condannare il paese all’eterna ripetizione degli stessi dibattiti e degli stessi errori. Un’impasse che ha fatto comodo a tanti, perché ha permesso l’infinito galleggiamento – e il ciclico ritorno – di una classe dirigente senza qualità e senza idee.
Il bello è che la generazione che ha governato – non solo la politica, ma i giornali, la televisione, la cultura degli ultimi vent’anni – si era spacciata per quella delle idee al potere. Dopo avere trasformato le abitudini e i costumi degli italiani, gli orgogliosi combattenti del Sessantotto e del Settantasette si sono affacciati alla ribalta all’inizio degli anni Novanta, appena in tempo per dare il colpo di grazia ai dinosauri della Prima Repubblica e per proclamare l’avvento di un mondo nuovo. Splendidi quarantenni di vent’anni fa, approdati alla guida di partiti e movimenti, di grandi quotidiani e telegiornali. Tonici, magri, eleganti: pronti a inaugurare la stagione delle mani pulite e delle giacche di velluto, della società civile e del culatello responsabile. Un’era nuova, senza nulla in comune con la precedente – quella dei ladri, degli accumulatori di debito pubblico e di preferenze – al punto da autoproclamarsi Seconda Repubblica, pur in assenza di alcuna significativa modifica costituzionale. Fondata sul principio che bastassero le facce nuove e le migliori intenzioni per assicurare la rinascita delle istituzioni e della politica.
La cesura radicale con il passato ce l’avevano nel Dna. Non erano forse stati loro a scrivere sui muri delle facoltà occupate: «Vogliamo essere orfani»? Il Sessantotto non è semplicemente una ribellione contro i padri, è rifiuto radicale della filiazione, desiderio impossibile di diventare genitori di se stessi. È l’idea che un mondo nuovo possa sorgere dal nulla, senza precedenti, originato dal solo slancio vitale di una generazione prometeica. Tutto ciò che c’era prima è stato solo tradimento, inganno, abuso. Tutto ciò che verrà dopo è armonia. «Sous les pavés, la plage!»
Peccato che la tabula rasa presenti sempre gli stessi inconvenienti. Se n’era accorto il solito Pasolini, quando nel 1973 descriveva i giovani contestatori:
La condanna radicale e indiscriminata che essi hanno pronunciato contro i loro padri – che sono la storia in evoluzione e la cultura precedente – alzando contro di essi una barriera insormontabile, ha finito con l’isolarli, impedendo loro, coi loro padri, un rapporto dialettico. Ora, solo attraverso tale rapporto dialettico – sia pur drammatico ed estremizzato – essi avrebbero potuto avere reale coscienza storica di sé, e andare avanti, «superare» i padri. Invece l’isolamento in cui si sono chiusi – come in un mondo a parte, in un ghetto riservato alla gioventù – li ha tenuti fermi alla loro insopprimibile realtà storica: e ciò ha implicato – fatalmente – un regresso. Essi sono in realtà andati più indietro dei loro padri, risuscitando nella loro anima terrori e conformismi, e, nel loro aspetto fisico, convenzionalità e miserie che parevano superate per sempre.
Il ragionamento non fa una piega e, purtroppo, non si applica solo ai sessantottini, ma anche alla stagione politica – la Seconda Repubblica – da essi plasmata e governata.
«Governata?» direte voi. E Berlusconi dove lo metti?
Già, Berlusconi: l’incontrastato dominatore della Seconda Repubblica, colui sul quale si è incentrata l’intera interminabile rissa di condominio che ha occupato gli ultimi vent’anni della nostra storia. Non certo un sessantottino, quello. Né per età, né per convinzioni politiche, né per senso estetico. Eppure è stato lui a rovinare loro la festa. Un’epoca che, a rigor di logica e di demografia, avrebbe dovuto essere quella degli splendidi quarantenni nannimorettiani passerà invece alla storia come il ventennio berlusconiano. Con i D’Alema e i Paolo Mieli, i Veltroni e i Cacciari – con tutta l’intelligenza e i machiavellismi degni del cardinale Mazzarino – ridotti in fondo a fare da comprimari a questo improbabile caimano in doppiopetto.
Pensateci un momento, però. Vi pare possibile che la stagione dei sessantottini – non solo quelli al potere, ma proprio i milioni di elettori che appartengono a quella generazione, peraltro assai numerosa, e che hanno dato il tono agli anni della Seconda Repubblica – vi pare possibile, dicevo, che quella stagione sia stata dominata da qualcuno, Berlusconi, che ne rappresentava, in apparenza, la negazione?
La risposta è no. Checché ne dicano alcuni, siamo pur sempre in democrazia e i voti Berlusconi li ha presi. Non solo quelli delle (presunte) casalinghe teledipendenti del Mezzogiorno e dei (presunti) evasori fiscali del Basso Piave.
Allora come si spiega che l’apoteosi della generazione del Sessantotto abbia coinciso con il trionfo di Berlusconi? La mia impressione è questa: che assai più di D’Alema (sessantottino riluttante), di Paolo Mieli (sessantottino cinico), di Veltroni (sessantottino kennediano) e di Cacciari (sessantottino nichilista), Berlusconi abbia incarnato i valori del Sessantotto vincente.
Non quello politico dei gruppuscoli dimenticati dalla storia: i trotzkisti, maoisti, operaisti e quant’altri hanno occupato la scena per qualche attimo prima di avvitarsi in una spirale di violenza e d’irrilevanza. Bensì quello culturale che ha cambiato per davvero la società in cui viviamo. L’edonismo di chi vuole godere del presente, mandare in soffitta le tradizioni e le convenzioni, celebrare fino in fondo la rivoluzione sessuale e il culto della giovinezza. Il consumismo di chi afferma la sua personalità attraverso lo stile, i vestiti, le nuove pratiche del tempo libero. L’antipolitica di chi, in fondo, diffida di qualsiasi autorità e in modo particolare dei parrucconi che si avvolgono negli orpelli di istituzioni polverose e corrotte.
Con il primo Sessantotto, quello politico dei gruppuscoli, Berlusconi non ha evidentemente nulla a che vedere. Del secondo, quello edonistico e consumistico, incarna invece la forma più pura e di massimo successo. È ciò che intendono Mario Perniola e Valerio Magrelli quando parlano di «Sessantotto realizzato da Berlusconi». Pensateci bene. La vecchia cultura borghese poneva dei limiti evidenti all’estensione del dominio commerciale. L’uniforme dell’uomo vestito di grigio, per esempio: l’impiegato in giacca e cravatta divenuto un oggetto di scherno per gli studenti delle facoltà okkupate.
Quel vestito non era tanto una manifestazione di conformismo, come i contestatori hanno voluto credere, quanto un fattore di praticità e di economicità. Negli anni Cinquanta la nostra era ancora una società povera, seppure in fase di rapido recupero. Gli uomini non possedevano, in media, più di un paio di completi e qualche camicia bianca. L’uniforme impiegatizia permetteva loro di indossare sempre più o meno gli stessi vestiti, senza trovarsi in imbarazzo. La moda maschile era all’epoca un fenomeno quasi sconosciuto, e un piccolissimo budget annuale era sufficiente per non sfigurare in ufficio e in società.
Tutto cambia con l’avvento degli alfieri della controcultura negli anni Sessanta. Per loro l’abbigliamento diventa un fattore identitario. Solo un piccolo borghese reazionario può accettare di indossare ogni giorno l’uniforme degli impiegati in giacca e cravatta. I sessantottini sono curiosi, fantasiosi e liberi, ed esprimono queste loro caratteristiche attraverso l’abbigliamento. Fanno la comparsa i colletti alla coreana e le giacche ricamate, i pantaloni a zampa d’elefante e i poncho peruviani.
Nel giro di pochi mesi i vecchi completi lisi vanno in soffitta, e al loro posto si impongono i colori sgargianti e mutevoli della rivoluzione giovanile. L’abbigliamento maschile esce dalla sfera della tradizione e fa il suo ingresso a pieno titolo in quello della moda e del consumo.
Le scene domestiche si trasformano in dialoghi di Flaiano: «Una famiglia si prepara a uscire di casa. Il marito alla moglie: “Io vengo con la maglia a collo alto e il giubbotto”. E lei: “Perché non metti la camicia da pescatore col foulard?”. Lui: “Non la porta più nessuno, è superata. Forse mi metto la camicia indiana e l’amuleto”».
E via di seguito, con i figli che entrano in campo, a discutere di pantaloni sfrangiati e di risvolti, di giubbotti da motociclista scoloriti di proposito e di collane di filigrana, finché la madre sbotta: «È una tragedia, ogni volta che si deve andare da qualche parte uno non sa che mettersi!». E la figlia, di rimando: «Mamma, non essere complessante! Questa società di m… bisogna rifarla. E se non si comincia dagli abiti, da dove vuoi cominciare?».
Li potremmo passare in rassegna uno per uno, i modi in cui la rivolta è sfociata nel consumismo più sfacciato. Non si tratta, come sostiene qualcuno, della capacità del sistema di recuperare a proprio beneficio le istanze sovversive dei contestatori. Il «sistema» non ha «recuperato» proprio nulla, perché la controcultura ne è stata parte...