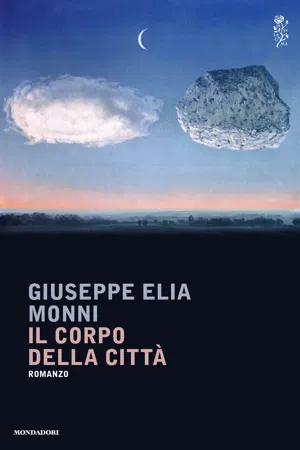Il sole era già alto, quando il loro carro attraversò la Scaffa, e da quel momento in poi, dondolando su quello stretto pontile di legno che si teneva in equilibrio come un funambolo sull’estuario della laguna di Santa Gilla, il piccolo Pietro si sentì un altro, come un acrobata tra due mondi azzurri d’acqua e di cielo. Il padre, a cavallo innanzi al carro, si voltava continuamente a rimirarlo, e rideva felice, per quell’espressione estasiata: «Non avevo mai visto una luce così!» esclamava Pietro, e Giustina stentava a tenerlo stretto. «Ti abbaglia, sì?» domandava il padre. Perch’era come se stessero camminando, piccoli piccoli, sulla superficie leggermente curva di un immenso specchio, che quella luce rifletteva, e loro una minuscola carovana accecata, che procedeva a capo chino, fiduciosa e lenta. La strada litoranea, che correva verso Meridione, lungo il profilo occidentale del Golfo degli Angeli, si stendeva su una sottile lingua di sabbia: da una parte la sconfinata volta marina, disseminata di crepitanti scintille d’oro, e dall’altra una sterminata distesa di stagni, cinta dai monti cupi e lontani, a guardia dell’orizzonte, come se il cielo si fosse frantumato in milioni di frammenti celesti, precipitati su quell’immenso panno di velluto ch’erano isole di cisto marrone, e capannelli di canneti biondi, coronati di giunco. A volte la strada si faceva così sottile, e così sepolta dalla sabbia d’avorio, che più non si poteva dire strada, ma spiaggia, e molto spesso invasa dall’acqua, che zoccoli di cavallo e ruote di carro vi affondavano, bagnandosi: ecco, in que’ punti mare e laguna si toccavano, come giganti innamorati, pensò Pietro, si baciavano colmi di pudore, scambiandosi.
«Le ultime piene, della Primavera scorsa, hanno distrutta definitivamente la strada...» spiegava Don Gemiliano. «E questo è stato un problema, per gli approvvigionamenti di legna da Capoterra e per tutti i contadini della piana di Pula, che vivono dei mercati della Città...»: così si dilungava Don Gemiliano, sull’uso e sull’utilità di strade e ponti, di poste e porti, per il commercio e più in generale per il progresso, delle genti e delle nazioni: uno dei suoi discorsi preferiti, oltre ovviamente al tempo atmosferico, al moto delle stelle, ai resti romani e ai flussi fluviali, non meno interessanti e misteriosi, a suo dire, di quelli degli umori umani.
In tutto questo, il piccolo Pietro lo ascoltava avidamente, assetato di quelle spiegazioni come se non le avesse udite mai: come se ascoltarne l’eco, come aveva sempre fatto, da quel suo letto di paglia di Stampace, da quel suo collegio di Torino, tetro come un confessionale, freddo come una sacrestia, non avesse avuto lo stesso fascino e la stessa efficacia che ascoltarle in quel luogo, in quel momento. Tutto gli appariva, in una parola, aperto. Al loro passaggio gli uccelli acquatici più vicini compivano un breve volo, per ritornare a posarsi poco lontano e riprendere indisturbati la loro strana caccia al tesoro. Spesso Pietro si voltava allegramente, per spiare Simplicio, il quale, in groppa al suo asino, credendo di non esser visto da nessuno, fingeva d’imbracciare un fucile e sussurrando fra sé – Pum! – tutti li colpiva al volo!
Un’ora dopo iniziarono a lambire quelle vasche nelle quali lavoravano, curvi ed esausti, i pescatori: e Pietro non faceva altro che domandare spiegazioni, come un bambino di cinque anni, cosa facessero e perché e come, con una fretta ed una puntigliosità che le risposte del padre non riuscivano a star dietro alle domande, a tutte quelle curiosità, a tutte quelle necessità, di nozioni arretrate, di gite e viaggi e vite mancate. Perciò il padre non ne era infastidito, ed anzi, si sentiva quasi inadeguato a fronteggiare quell’entusiasmo e quella voracia cui non era abituato: e quanto rideva Simplicio, alle spalle di tutti, per quella nemesi che dovea affrontare il Professore, e quanto si sentiva orgogliosa di quel piccolo petulante allievo, Giustina, che quasi se ne sentiva tutrice! Di più: madre.
Volle anche fermarsi, Pietro, per vedere da vicino come i pescatori fissavano le nasse, e il padre gli spiegò come venivano poste quelle trappole, rispetto alla corrente, e gli stessi pescatori lo ascoltarono ammirati, specie di se stessi, per il fatto che scoprirono d’essere stati, da sempre, tanto inconsapevolmente astuti!
Poco distante, nel folto dei canneti, in un fremore stordito e primordiale, vi erano donne che strappavano giunchi: «Per intrecciare i cesti...» spiegò Don Gemiliano, mentre aiutava Pietro a risalir sul carro: ma il piccolo teneva la testa voltata, in quella direzione, e il padre protestò, senza capire; quindi, voltatosi anch’egli, si accorse che il figlio stava fissando quelle braccia di femmine: sanguinanti.
Da quel momento, quando il sole iniziò la sua discesa, il figlio si fece più silenzioso, ed era il padre a parlar più fitto, come a volerlo distrarre. Sulla linea dell’orizzonte s’intravedevano livide imbarcazioni, lente nelle acque basse, stagnanti in schiume dorate.
«Sapete che fanno?» domandò Don Gemiliano e, senza attendere risposte, spiegò: «Avvelenano i pesci, con estratto d’euforbia...»
«È velenosa, Babbo?»
«Sì, Pietro, è velenosa: uccide i pesci rapidamente, ma uccide anche lo stagno. Per questo è pratica proibita, fin dagli Antichi, perché, per avere di che mangiare il padre, toglie di che mangiare al figlio.»
Pietro vi pensò un attimo, quindi, con un vago sdegno, domandò: «E perché se è proibito lo fanno?».
Don Gemiliano si voltò stupito verso di lui, e tutti risero, eccetto Pietro, ovviamente, che anzi pensò lo canzonassero, in quella sua disarmante e disarmata intransigenza di bambino. Quando si esplora un mondo, se ne scopre sempre un altro. È il destino dell’uomo.
E quando gli acquitrini più estremi della laguna s’infossarono nelle acque paludose del territorio di Capoterra, era già sera. Tra gli alberi torti, Pietro vide delle vecchie donne che, col cappuccio nero e le gonne rialzate, camminavano lente nell’acqua, in un branco silente e rado: «Che fanno...?» chiese al padre, spaventato, perché sembravano in tutto e per tutto delle streghe, e chissà poi che non lo fossero davvero.
«Si fanno attaccare dalle sanguisughe...» spiegò Don Gemiliano «al termine della sera, quando riemergono, hanno le gambe ricoperte di decine di sanguisughe nere: le staccano ad una ad una col sale e le conservano...»
«Per farne cosa?» domandò stupefatto, ma senza quel disgusto che avrebbe avuto un adulto.
«Le vendono alle farmacie» sorrise Don Gemiliano «in Città...» e Giustina sentenziò: «A questo porta la povertà!».
Lontano, oltre le paludi vischiose, allagate dalla luce del tramonto, stavano le casupole arancioni di Capoterra. Così, Don Gemiliano ne approfittò per raccontare la storia di quel borgo di fango: l’antico avamposto romano, la chiesa medievale della Maddalena, di cui avevano appena intravista la base dei resti ciclopici, seppelliti dai rovi, quindi lo spopolamento del territorio a causa delle razzie dei pirati, e poi delle pesti; raccontò dell’arrivo di Girolamo Torrellas, dell’editto di cento anni prima, col quale il nobiluomo avea promesso aiuti economici, una casa e un lavoro, alle famiglie che avessero deciso di trasferirsi nuovamente laggiù, per rifondar quei luoghi; e raccontò dell’arrivo di decine di famiglie disperate, da tutta l’Isola, in fuga dalla fame e dalle malattie, dalla morte e dalle altre condanne. E stava per raccontare anche di Villa d’Orri, e svelare finalmente alla famiglia di chi sarebbero stati ospiti, quella notte, quando s’imbatterono in una squadra di operai che si apprestavano a lasciare – per quel giorno – i loro lavori: stavano infatti sistemando la strada, che da quel punto in poi era ampia, piatta e lastricata: «Per chi state compiendo quest’opera meritoria?» chiese enfaticamente Don Gemiliano, che forse certo sapeva la risposta: «Per Don Stefano Manca» risposero quelli, «Marchese di Villahermosa».
Dinanzi a loro si stagliava il profilo scosceso dei monti alti del Sulcis: dietro le cime rocciose scompariva definitivamente il sole, in un ultimo abbaglio arancione, mentre ombre sempre più lunghe si stendevano lungo l’altro versante: rendendo ancora più cupe le selve più alte, rifugio di fiere ritrose, quindi i poggi dabbasso, i pascoli dai quali si ritiravano i greggi ed i campi dai quali si ritiravano gli uomini, e gli uliveti e i frutteti, infino il mare. Dinanzi a loro, a perdita d’occhio, per centinaia di miglia quadrate, stava la proprietà dei Marchesi di Villahermosa, che avevano preso quel pezzo di Isola identico a tutti gli altri, con le stesse foreste impenetrabili, con gli stessi altopiani desertici, e le colline dilavate e le coste avare, e ne avevano fatto una riserva di caccia, un’azienda agricola, un giardino e una casa mirabile. Un mondo perfetto, insomma. Un mondo a parte. Che per Don Gemiliano, ovviamente, aveva sempre rappresentato più che un modello: un ideale. Il mito di un’oasi di perfezione che si può vivere; di più: che si può creare! Ma che, proprio per questo, rimane sempre sullo sfondo della vita reale, il riflesso del sogno di cui abbiamo bisogno, perché resti tale.
Sui profili dei rilievi rocciosi, che piagavano le falde dei monti, i Marchesi avevano piantato più di trentamila mandorli, che durante le secche d’Inverno, visti da Cagliari, sembravano cumuli di neve scesi a valle. Sulle distese di pascoli verdi, anni di spietramenti e arature, pasturavano capre e pecore e vacche; steccati perfetti contenevano a stento le pulsioni dei becchi e dei montoni, ed alte staccionate consentivano le corse nervose di decine di cavalli, da lavoro, da cocchio e da corsa: i Marchesi acquistavano infatti stalloni dalla Spagna e dalla Turchia, dall’Arabia e dalla Normandia, e avevano negli anni selezionato una razza esemplare.
Più in là, dove c’erano state, fino a pochi anni prima, distese di ginestre, di pruni e di stoppie, ora v’erano campi di grano, di avena e d’orzo; e distanti di poco si potevano vedere i caseggiati delle stalle e dei porcilai, i depositi dei foraggi e i granai.
Ancora più a valle, poi, si estendevano sterminati oliveti, e frutteti, fino al mare. Infiniti filari di olivi, meli, peri, albicocchi, susini, peschi, ciliegi, e fichi, di tutte le varietà immaginabili, erano perfettamente allineati, e spostandosi anche solo d’un passo ogni loro prospettiva cambiava, permettendo di aprire nuovi scorci degli stessi paesaggi, sempre un poco simili, sempre un poco diversi: dalle montagne ai colli ai pascoli ai campi, fino alle spiagge, dove i Marchesi avevano approntato un attracco. Proprio laggiù, tra le cime verdi degli alberi più alti, s’intravedeva il culmine della casa d’Orri, una villa di pietra chiara che, rivolta ad Oriente, aveva Cagliari, dall’altra riva del Golfo, in fronte.
Per quanti anni Gemiliano si era soffermato ad osservare quella casa lontana, specie alle prime ore dell’alba, dall’alto del bastione di Santa Croce, quando la prima luce si rifletteva su quella facciata remota, sull’altra sponda del Golfo; e quante volte si era ripromesso di visitar Villa d’Orri, e di conoscere finalmente i Manca...!
Sapeva della riservatezza dei Marchesi, e sapere che la maggior parte del tempo la trascorrevano in Continente, e in viaggio, gli aveva consentito di avere un pretesto per rimandare a oltranza quell’appuntamento.
Fin quando, proprio in quei mesi, aveano coinciso l’incarico della bonifica di Pula e l’invito da parte dell’amico, Don Gavino Nieddu, il quale, conoscendo assai bene il Marchese Stefano, si era proposto come sensale di un incontro. Tutto questo avea convinto Don Gemiliano che il momento per varcare quel confine era arrivato, forse perfino scritto nel cielo, lui che non credeva ci fossero confini, nel mondo, e nulla fosse scritto nel firmamento che non potesse essere ridisegnato dalla nostra mano.
Ma quando la piccola carovana ebbe varcato il solenne cancello d’ingresso, e attraversato il lungo lunghissimo vialone d’accesso, e giunse al cospetto della grande villa, che di lì a pochi anni sarebbe stata residenza di un sovrano, Don Gemiliano Deidda istintivamente si voltò indietro, e si vergognò di presentarsi così, con un carro colmo di miseri sacchi e mobilio, un’anziana donna alla guida, con accanto un ragazzetto gracile e pallido, e un povero vecchio su un asino, che si guardava attorno atterrito!
«Benvenuti, dunque!» esclamò Don Gavino, andandogli incontro.
Don Gavino Nieddu era un signorotto d’aspetto simpatico: basso, tozzo, con baffi e pizzetto alla spagnola, e l’intero abbigliamento fuorimoda, per non dir modesto, e trasandato, ma un sorriso e specie una risata così contagiosi che gli si sarebbe perdonato tutto. Anche il linguaggio, e le maniere, che così spesso apparivano per quel che erano. Il suo accento, e molti altri particolari, denunciavano la sua origine rurale, della Sardegna dell’interno, che i cittadini della Capitale ritenevano rozza e selvatica, se non addirittura primitiva. Ma l’intelligenza di Don Gavino gli avea consentito di conquistare titoli sempre più prestigiosi, fino alla carica di Giudice della Reale Udienza, che lo avevano innalzato ben al di sopra di quella superbia, senza peraltro concedere nulla alle chiacchere, o peggio: alle calunnie. Forse su queste basi era nata l’amicizia con Don Gemiliano. Certo, la famiglia Nieddu s’era arricchita, ne’ secoli, gestendo con abilità il ruolo d’amministratrice (più ancora che i beni...) della grande famiglia feudale dei Carroz, e lo stesso Palazzo Nieddu, in costruzione in Castello, s’addossava così pesantemente sui resti di quello dei padroni spagnoli – sempre più lontani, sempre più assenti – che sembrava la raffigurazione stessa del parassitismo; e forse peggio. Ma dopotutto: chi si sarebbe potuto definire parassita di chi? Chi avea svuotato di potere e ricchezza una famiglia di usurpatori stranieri, o non piuttosto questi ultimi? E si potrebbe definire parassita quell’organismo che, approfittando di un patrimonio moribondo, vi si attaccasse e ne traesse giovamento, per sé e per la propria prole e, in una parola, traesse dalla morte vita? Non sarebbe stato, forse, più giusto riconsiderare il concetto stesso di parassitismo...? Don Gavino, insomma, neolatifondista, avea maturato negli anni una concezione del progresso assai simile a quella di Don Gemiliano Deidda, e la convinzione che l’investimento di capitali nell’agricoltura, nell’agricoltura moderna, avrebbe dissipato, oltre alla miseria delle popolazioni, anche gli ultimi pregiudizi e quei sospetti sulla sua famiglia, arricchendo, oltre al suo patrimonio, anche il suo nome, e più della sua fama il suo ricordo.
Per questo, Don Gavino aveva fatto mille pressioni politiche affinché fosse conferito a Don Gemiliano l’incarico di bonificare la piana di Pula, dove, di là della proprietà dei Manca, tra gli Amat e gli Aymerich, stava proprio la contea di Santa Margherita, posseduta dai Nieddu.
Fu dunque lui, quella sera, ad accoglierli a Villa d’Orri: «Il Marchese si scusa con voi, ma è stato trattenuto in Calasetta, e dovrebbe riuscire a raggiungerci, spero, dopodomani» così spiegò Don Gavino. «Intanto, mi ha concesso l’onore di accogliervi e farvi accomodare nella foresteria. Ma come mai siete arrivati così tardi?»
«Siamo partiti dopo mezzogiorno...» spiegò Don Gemiliano, distratto dai servitori che aiutavano Simplicio e Giustina, a loro volta a disagio «e ci siamo fermati più d’una volta lungo la strada...»
Don Gavino lo riempì di pacche sulle spalle, per scuoterlo da quell’imbarazzo, e lo abbracciò anche, divertito: «Domani vi accompagnerò a fare una passeggiata» gli disse. «Così vi rasserenerete un poco! Intanto, ritiratevi pure coi vostri familiari, e ci vedremo domattina, quando ne avrete piacere!»
La mattina seguente Don Gemiliano fu sveglio da presto; più precisamente, fu sveglio sempre, poiché non chiuse occhio per tutta la notte. Mille pensieri gli correvano per la mente e per il petto, come torme di cavalli in una battaglia, ma in rotta, non sapendo come battere in ritirata o riorganizzarsi – senza capo – per un’estrema temeraria sortita. Tutto si rimestava tumultuosamente, dalla sua sfida alla Città, che ormai sembrava persa definitivamente – e ad un solo passo dalla meta – per il silenzio e la distanza dei Tessa, alla mancanza di Flora, e di Paolo, ed alla illusione sempre disillusa che Pietro potesse avere una giovinezza vera, una vita int...