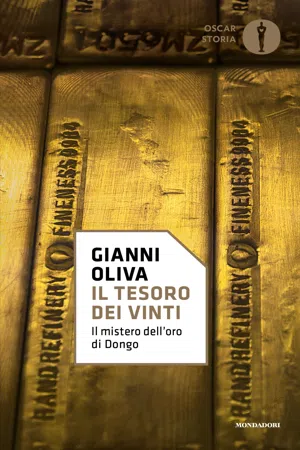Antica Strada Regina
All’alba del 27 aprile sul lago di Como piove: una pioggia di primavera, a tratti fine ma intensa, a tratti scrosciante, che bagna i paesi sulle rive, le ville storiche di Cernobbio e Bellagio, i giardini dove hanno passeggiato Liszt e Bellini, le case in pietra dei contadini e dei barcaioli. La strada della riva occidentale, la Antica Strada Regina che in sessanta chilometri risale da Como sino al Ponte del Passo, è inondata di rivoli che faticano a defluire già nel tratto iniziale: oltre Cadenabbia e Menaggio, dove i due rami del lago confluiscono nell’Alto Lario, il vento che spira da nord, il tifano, diventa burrascoso e complica ancor più gli spostamenti. Il tracciato è difficile di per se stesso, tormentato, con una carreggiata stretta e la montagna sovrastante che sembra precipitare nel lago: la pioggia lo rende insidioso, insicuro, lentissimo.
Storicamente, la sponda occidentale del lago è la strada della fuga e del contrabbando, perché la Svizzera è a due passi con le sue ricchezze, le sue promesse d’asilo, i suoi orologi, le sue sigarette sottoprezzo: da Menaggio si può piegare a ovest, verso Porlezza, e in pochi chilometri si arriva sul lago di Lugano; dall’estremità settentrionale del Lario, dove il Ponte del Passo collega le due rive, si può invece proseguire verso Chiavenna e di lì raggiungere il territorio elvetico attraverso l’accessibile percorso della Val Bregaglia o quello più impegnativo del Passo dello Spluga. In alternativa, dal Ponte del Passo ci si può inoltrare a est nel lungo corridoio della Valtellina e da lì dirigersi verso Merano e puntare verso il Brennero e l’Austria.
Nel momento in cui la guerra sta per finire, la strada del lago di Como diventa strategica. Le armate angloamericane del generale Harold Alexander hanno ormai sfondato la Linea Gotica, il Comitato di liberazione nazionale dell’Alta Italia ha decretato lo sciopero generale, le formazioni partigiane stanno scendendo dalle vallate alpine verso le grandi città, in tutto il Nord soffia il vento dell’insurrezione. Per gli sconfitti (i reparti tedeschi della Wehrmacht e i fascisti della Repubblica sociale) non c’è più tempo né per trattative, né per progetti di resistenza ulteriore: bisogna solo trovare una via di fuga e di salvezza, lasciare in fretta la Pianura padana, sottrarsi alla prevedibile violenza della resa dei conti.
Dal punto di vista tattico, la strada della sponda occidentale non è certo ideale per una ritirata. Per chi si muove a piedi scappare è relativamente facile perché ci sono i sentieri del contrabbando, percorsi da generazioni di valligiani-«spalloni» delle valli di Intelvi, di Livo e di San Iorio (contro i quali poco hanno potuto le caserme dei finanzieri sparse per ogni dove). Ma per chi si muove in auto o in camion, la strada rischia di diventare una trappola: non ci sono sbocchi laterali e la carreggiata è a tratti così stretta che risulta difficile persino fare un’inversione di marcia. Inoltre, le anse della sponda, le asperità della montagna, le gallerie sembrano fatte apposta per chi vuol tendere agguati o stabilire posti di blocco.
Sotto il profilo logistico, la strada della sponda orientale, che sale da Lecco sino a Colico, appare invece più agevole: le alture che la sovrastano sono meno dirupate, le corsie sono più larghe e lineari e non mancano percorsi alternativi laterali per puntare verso oriente attraverso la Valsassina o la Valle Varrone.
Nell’emergenza di fine aprile 1945, nessuno (né tra coloro che vogliono fuggire, né tra coloro che vogliono impedirlo) sa prevedere quale percorso sarà eventualmente scelto e neppure se qualcuno tenterà di forzare il passaggio: troppa confusione per opzioni razionali, troppa casualità legata alle contingenze dell’ultima ora, troppa imprevedibilità. L’unica certezza è che il lago di Como occupa una posizione strategica tra Milano e la Svizzera e che sarà verosimilmente coinvolto nei movimenti estremi degli sconfitti.
I partigiani garibaldini dell’Alto Lario
In questa prospettiva i partigiani del Lario e della Valtellina si sono organizzati. Nell’area operano due divisioni garibaldine, secondo una distribuzione territoriale decisa nel settembre 1944: la 1a divisione garibaldina lombarda, comandata da Dionisio Gambaruto «Nicola», agisce sulla sponda occidentale, mentre la 2a divisione garibaldina lombarda, comandata da Valdo Aldrovandi «Al», è schierata sulla sponda orientale. Della 1a divisione fanno parte tre brigate: la 40a brigata d’assalto «Giacomo Matteotti», che presidia la bassa Valtellina sino a Tirano, la 90a «Elio Zampiero» che opera nella Val Chiavenna, e la 52a «Luigi Clerici», destinata a incrociare il proprio destino con quello di Mussolini e dei gerarchi in fuga: la 52a agisce lungo la sponda del lago, concentrando i suoi sforzi soprattutto nella parte alta, tra Menaggio e Ponte del Passo, con il comando in spostamento tra Domaso, Dongo, Gravedona, Musso, Germasino.
All’inizio di aprile 1945, in previsione delle convulsioni di fine guerra, i responsabili militari e politici della Resistenza lariana decidono l’unificazione dei comandi, constatata l’unità tattica del settore e l’urgenza di un’azione coordinata in tutta l’area Como-Lecco-Sondrio. Presa l’11 aprile, la deliberazione fa esplicito riferimento alla necessità di presidiare al meglio «le due strade di accesso alla Valtellina, provenienti da Lecco e da Como, particolarmente vulnerabili in punti che consentirebbero il blocco della ritirata tedesca», oltre alla «salvaguardia dell’importante patrimonio idroelettrico esistente in zona».1 Il comando unificato comprende le divisioni «Valtellina», «Grigna» e «Spluga», nelle quali sono confluite le precedenti formazioni: della divisione «Spluga» fa parte la 52a brigata «Luigi Clerici».
Anche se l’unificazione militare è assai più una prospettiva che una realtà operativa e se le brigate continuano a muoversi in sostanziale autonomia, la decisione dimostra che i partigiani sono all’erta, consapevoli della centralità strategica che la zona può assumere. A rendere ancora più evidente l’importanza dell’area lariana è un’azione di rastrellamento iniziata il 23 aprile da reparti della Repubblica sociale, appoggiati dai presidi tedeschi: partendo dalla strada provinciale e salendo verso le montagne che sovrastano Dongo, essi attaccano i distaccamenti della 52a «Luigi Clerici». Il più colpito è il distaccamento «Antonio Gramsci», comandato da Andrea Arrigoni «Barba» e composto da una trentina di uomini. Nello scontro i partigiani lamentano la perdita di un combattente, Enrico Conti «Pilsudski», ucciso durante il tentativo di ripiegamento, e il ferimento di altri tre, tra cui il comandante «Barba». Risalita la montagna verso Passo Giovio, il «Gramsci» si rifugia in una casermetta abbandonata della Guardia di finanza, dove pensa di potersi riprendere e riorganizzare, ma il mattino successivo l’edificio viene circondato dalle forze fasciste: nel nuovo scontro, muoiono il commissario politico Giulio Paracchini «Gino» e il giovane partigiano di Como Carlo Brenna «Giorgio», mentre un terzo combattente, Primo Maffioli «Falco», caduto prigioniero, viene prima torturato e poi ucciso. Altri quattro partigiani sono gravemente feriti e tra loro il caposquadra Aldino Frassi «Romolo». Nel pomeriggio, quando i rastrellatori ridiscendono la montagna verso il lago, il distaccamento «Gramsci» è ridotto a metà degli effettivi ed è ormai privo di comandanti.
Difficile stabilire se il rastrellamento del 23 e 24 aprile, condotto dai militi della Rsi con un dispiegamento significativo di forze, sia un’azione disposta dai comandi superiori in vista del tracollo finale per eliminare la presenza partigiana in un’area strategica, oppure se si tratti di un’iniziativa locale, in risposta alla cattura avvenuta qualche giorno prima di elementi legati alle brigate nere. Certo è, comunque, che i combattimenti sopra Dongo contribuiscono ad alzare il livello di tensione e ad allertare ulteriormente le forze resistenziali: se i fascisti sono intervenuti così massicciamente nel momento in cui la guerra finisce, significa che stanno preparando qualche azione particolare nell’area del lago, oppure che vogliono garantirsi uno spazio fruibile per la fuga.
Nella giornata del 25 le notizie degli scontri si inseguono in tutta la sponda occidentale dell’Alto Lario: i corpi dei caduti vengono portati a Garzeno, nell’entroterra di Dongo, mentre i feriti sono curati per quanto possibile nelle cascine dei valligiani; il 26, quando si apprende dell’insurrezione di Milano, le maestranze della Ferriera Falck di Dongo interrompono il lavoro e alcuni operai salgono sino a Garzeno per riportare in paese i corpi dei caduti. L’emozione è palpabile dovunque: uomini e donne nella piazza, tra il cordoglio per le vittime e l’attesa di eventi decisivi; viavai di mezzi, con partigiani in movimento tra una località e l’altra; informazioni frammentarie che giungono dal basso lago e parlano degli avvenimenti di Milano, ora ingigantendoli, ora drammatizzandoli; volti ansiosi di chi sta per assistere all’epilogo di una stagione tremenda; l’atmosfera sospesa che accompagna il crollo di un’epoca, quando è ormai chiaro chi sono i vinti e chi i vincitori, ma non si sa quanta violenza possa ancora scatenarsi.
Presìdi fascisti e posti di blocco partigiani
Frattanto l’apparato militare della Repubblica sociale si sgretola. Le notizie dell’insurrezione precipitano nel caos una struttura già provata, con la distanza da Milano e dai centri del potere che produce un senso inquietante di isolamento e con la particolare conformazione dell’area che prospetta il rischio di rimanere intrappolati: a soli due giorni dall’ultimo sanguinoso rastrellamento, i reparti di stanza nell’Alto Lario si sbandano. Il presidio di Dongo, dopo aver sparato qualche colpo in aria per intimidire le maestranze della Falck, fugge verso l’altra sponda del lago su un barcone usualmente impiegato per il trasporto delle merci; qualche chilometro più a nord, a Domaso, un altro presidio ha già lasciato il proprio posto nella notte precedente; a Ponte del Passo i militi di guardia chiedono di parlamentare con i comandi partigiani; a Gravedona si arrende il distaccamento della Milizia confinaria.
I soldati tedeschi presenti nell’area concordano a loro volta la consegna delle armi in cambio della libertà di movimento verso nord (il confine con la Svizzera o la via della Valtellina in direzione Merano): è il caso del comando sistemato nell’albergo Italia a Gravedona e degli uomini di stanza a Dongo, alloggiati in un albergo dallo stesso nome. Sono militari consapevoli che la guerra è perduta e vogliono soltanto raggiungere i propri confini.
Nella giornata del 26, di fronte all’incalzare della crisi finale, i partigiani della 52a brigata garibaldina dispongono due posti di blocco: uno viene stabilito nella parte più settentrionale del lago, poco prima del Ponte del Passo, all’altezza dell’incrocio tra la provinciale e la diramazione per Gera; un altro a Musso, due chilometri a sud di Dongo, in una strettoia che viene facilmente bloccata con un tronco d’albero.
In tutti i paesi dell’Alto Lario i partigiani sono in armi e assumono il controllo del territorio; ci sono presidi della 52a brigata a Domaso, a Gravedona, a Dongo, a Musso; il resto delle forze si concentra nell’immediato retroterra del lago, a Gera, a Germasino, a Garzeno. Accanto ai partigiani vi sono cittadini che non hanno preso parte alla Resistenza in montagna, ma che si mobilitano in vista dell’insurrezione: a Musso una trentina di loro viene organizzata dal capitano Davide Barbieri, che di fatto assume il controllo del paese.
Che cosa si aspettano gli uomini armati schierati ai posti di blocco o i cittadini in fermento nelle piazze e lungo la strada? Dalle memorie e dalle testimonianze, non risulta che qualcuno preveda l’arrivo del Duce e dei gerarchi. La convinzione diffusa è che giungeranno colonne di soldati tedeschi in transito e che la Resistenza dovrà chiederne la resa o almeno rallentarne la marcia. L’esito della guerra è ormai scontato, ma non si può lasciare il nemico libero di ritirarsi impunemente: il senso di riscatto insito nella scelta resistenziale implica la partecipazione attiva alla fase finale ed è improponibile l’idea che le formazioni partigiane assistano da spettatrici al ripiegamento dell’esercito sconfitto. C’è chi teme lo scontro con forze militari che mantengono un’organizzazione salda e un armamento di prim’ordine e si affida alle possibili mediazioni dei sacerdoti per un epilogo incruento; c’è chi ritiene invece si possano sfruttare le strettoie e le asperità del lungolago per imporre il disarmo completo; c’è chi pensa ad azioni di controllo sui camion per impedire vengano portati via beni nazionali requisiti: in ogni caso, tutti ritengono che nel giro di qualche ora o di qualche giorno compariranno i camion militari della Wehrmacht e tutti (il combattente partigiano di base così come il cittadino che attende da cinque anni la pace) hanno il bisogno inconscio di vedere materializzata la sconfitta del nemico.
Un’altra convinzione diffusa è che si debbano presidiare le centrali idroelettriche, i ponti, le fabbriche e tutte le costruzioni di pubblica utilità: fare «terra bruciata» nel momento della ritirata è una pratica antica, che i tedeschi hanno già attuato nel corso dei mesi precedenti durante il ripiegamento dall’Italia centrale verso la Linea Gotica, e che potrebbero a maggior ragione riproporre nel momento dell’epilogo. Difendere gli impianti significa proteggere il proprio futuro, la propria economia, il proprio lavoro: per non vedere pregiudicato il ritorno progressivo alla normalità, l’Italia del dopoguerra ha bisogno delle sue infrastrutture intatte.
Forse qualcuno pensa anche di vedere arrivare singoli esponenti del regime in cerca di scampo, uomini di secondo piano, responsabili locali di violenze o intimidazioni, timorosi di vendette popolari o di processi sommari: è possibile che la Svizzera rappresenti per loro una meta praticabile e che la Confederazione Elvetica ne conceda l’ingresso. Per questo oltre ai posti di blocco e ai presidi del lungolago, i partigiani mantengono una parte delle forze nell’entroterra, là dove partono i sentieri del contrabbando.
Quel che è certo è che nessuno, né tra i partigiani né tra i civili del Lario, pensa di trovare sul lungolago Mussolini e i ministri di Salò. È opinione comune che i vertici del regime abbiano pianificato una precisa strategia di fuga e che cerchino di trovare rifugio per via aerea in qualche Paese compiacente (la stessa Svizzera, oppure la Spagna franchista, oppure semplicemente la Germania per ritardare di qualche giorno l’epilogo): quand’anche i loro piani dovessero fallire, si ritiene che essi si consegnerebbero prigionieri nelle mani degli angloamericani, le cui armate vittoriose ormai dilagano nella Pianura padana e sono già alle porte di Milano e delle principali città; oppure ancora si pensa che potrebbero arrendersi al Comitato di liberazione nazionale dell’Alta Italia, concordando un trasferimento di poteri incruento e uscendo di scena senza traumi. Per un’istintiva ritrosia psicologica, nessuno riesce a pensare che il destino potrebbe di lì a poco metterlo faccia a faccia con il Duce. La «grande storia» (quella dei dittatori, dei comandanti supremi, dei sovrani) è troppo distante dalla «piccola storia» della gente comune per immaginarne l’incontro: e invece la «grande» e la «piccola» storia talvolta si incontrano, intrecciando i destini degli uni e degli altri, ingarbugliandoli, magari inghiottendoli. È ciò che accade sul lago di Como il 27 e 28 aprile 1945, tra Musso, Dongo e Giulino di Mezzegra: ed è ciò che trasforma per due giorni il Lario nel lago dei destini incrociati.
Il Duce a Menaggio
In quel mattino livido del 27 aprile, a guardare la pioggia cadere sul lago non sono soltanto i partigiani della 52a brigata e i cittadini antifascisti dell’Alto Lario. Una quindicina di chilometri più a sud, nella piazza di Menaggio, ci sono alcuni protagonisti d’eccezione della storia italiana, uomini di potere giunti al crepuscolo della loro avventura politica e umana: scrutano la strada provinciale, confabulano tra loro, si spostano da un crocchio all’altro tra scatti di nervi, dubbi, apprensione. Alcuni, come il segretario del partito Alessandro Pavolini, conservano il tratto secco nel quale hanno sempre espresso la propria energia, ma la gravità del momento trasforma il vitalismo in esaltazione e i movimenti appaiono frenetici, talvolta convulsi; altri, come il sottosegretario Francesco Barracu, si muovono con solennità austera, nascondendo l’inquietudine dietro l’apparente distacco; altri ancora, come i ministri Paolo Zerbino e Ferdinando Mezzasoma, si presentano senza maschere, lasciando trasparire la propria incertezza e la propria ansia.
È l’alba, il chiarore stenta a farsi largo nel cielo scuro di nuvole, la pioggia bagna i protagonisti che si riparano alla meglio con i cappotti militari e gli ombrelli. Davanti al comando dell’XI brigata nera c’è la confusione dei momenti epocali, in un accalcarsi caotico di uomini e mezzi: vi è un’autoblinda giunta da Como al comando di Pavolini, tanto imponente quanto ingombrante; vi sono duecento soldati tedeschi appartenenti a una unità contraerea, comandati dal tenente...