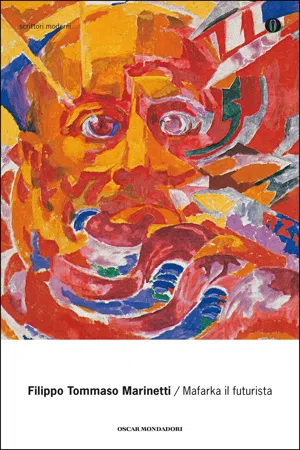— Cane! Scorpione! Vipera cornuta!… Lascia quella negra!… Ti proibisco di torcerle un capello!… Ma dove s’è cacciato il mio primo capitano?… Abdalla! Abdalla! Abdalla!…
Si udì un gemito di donna ferita, e, con qualche intervallo, il rumore di una lotta violenta, in un boschetto di fichi, a venti cubiti sotto i merli della fortezza, dall’alto della quale Mafarka-el-Bar, re di Tell-el-Kibir, sorvegliava la enumerazione dei prigionieri negri, gridando dei comandi ai suoi ufficiali.
— Abdalla! — soggiunse il re; — è laggiù, sul margine del terrapieno!… Presto! Afferra pel collo quel cannoniere, e gettalo nel fossato!
Echeggiò un grido straziante, e, poco dopo, si udì il colpo sordo e lontano d’un corpo caduto da una grande altezza su delle pietre.
— Padrone, t’ho obbedito!
Il gemito femminile si trascinò, affievolito, pel boschetto di fichi, e andò estinguendosi a poco a poco, mentre crescevano il tintinnìo delle catene e lo scalpiccìo dei piedi ignudi nella polvere.
— Quanti sono i nostri prigionieri?
— Seimila negri e quattromila negre. Ma eccone altri… Ecco la seconda colonna che s’avanza.
— E il bottino?
— Tre mitragliatrici, duecento fucili, cinquanta barili di rhum e cinquecentomila scatole di conserve… Abbiamo catturato trecento tori, duemila cammelli e mille dromedari… Ci sono, inoltre, più di quarantamila gabbie di galline.
E frattanto, le volte delle caserme, sotto le mura, echeggiavano d’un gridìo incessante di pollame, di donne e di marmaglia, rotto a tratti dalle bestemmie e dagli sputacchi sonori degli ufficiali adirati, che contavano senza fine maschi e femmine, mentre passavano a tre a tre, cacciandoli avanti a frustate.
I nitriti dei cavalli, i muggiti delle vacche, il rumore delle catene, l’urlar dei negri sotto gli scudisci irti di chiodi, scandevano lo scorrere torrenziale e monotono di quel grande armento invisibile, di cui si poteva seguire il cammino osservando i nembi di polvere che si levavano dal fondo delle vie, come fra muri in demolizione.
L’atmosfera ne era gonfia; un’atmosfera incandescente e color d’ocra, nella quale la voce delle sentinelle sembrava fare dei buchi neri.
A quando a quando la brezza ovattata del deserto si levava a stento, come per lo sforzo d’un braccio estenuato, e raffiche di fetore passavano allora sulla città. Era un fetore acido e melato, che inzuccherava e graffiava a un tempo le narici…
Mafarka-el-Bar dilatava le sue, ancora otturate dalla sabbia sollevata dalla battaglia, sforzandosi di respirare quell’alito fosforoso che rievocava, per lui, innumerevoli cadaveri neri sparsi per le pianure e arrostiti dal sole, tutt’intorno alla città.
Veniva da tutti i punti dell’orizzonte, quel sinistro odore di carnaio; ma la sua virulenza acre e muschiata si esagerava terribilmente verso l’ovest, laggiù, sul tragico ponte di Balambala, dove venivano trascinate in quel momento le famose Giraffe da guerra, mostri bizzarri di legname e di ferro, il cui collo multicolore s’allungava smisuratamente, e che s’avanzavano con un’andatura trepidante e restìa.
Il capo supremo stette a lungo ad ascoltare il loro ballonzolìo fragoroso e intermittente, che risuonava fin nelle viscere della città, come una risacca di lava nelle profondità delle caverne vulcaniche. Poi, egli si affacciò di nuovo fra due merli per interrogare ancora il suo primo capitano.
— Dov’è Muktar?…
— È là, anche lui, sul ponte di Balambala… Non vedi la sua galabieh vermiglia?… Egli fa racconciare dai suoi funai la pancia schiattata della più grande Giraffa da guerra.
— Con che cosa la racconciano?
— Con della corteccia di palmizio, molto più solida del cuoio fornito da quel furfante di Sabattan!… La sua avidità di mercante ladro ci ha ritardata la vittoria, questa mattina!…
— Che ne hai fatto, di quel traditore?
— L’ho fatto incatenare, durante la mischia.
— Non era necessario… Quella mala bestia non mi fa certo paura. Lo rimetterai in libertà, quando le porte della città saranno chiuse… Quella di Balambala deve rimanere aperta ai fellah. Tu sorveglierai, in persona, quel passaggio, ed anche la prigione di Gogorrù. A proposito: come va l’appetito del nostro caro prigioniero?
— Vostro zio Bubassa ha mangiato stamane due grandi scodelle di hallahua e un rotolo di karamendin.
— Bene!… Abdalla, va a dire a mio fratello Magamal che lanci subito le sue spie verso tutti i punti dell’orizzonte, e che ritorni, fra un’ora, con notizie precise!
Quando la meridiana della torre di Gogorrù segnò il mezzogiorno, Mafarka-el-Bar salì sulla terrazza della cittadella, la cui mole torrida e abbagliante di calce sembrava vogare nel cielo come una nuvola, sulle cime ondeggianti dei palmizi, fra un soave tubare di tortore felici.
Con un gesto agile egli liberò dalla tunica di scorza le sue spalle color di rame, e, nudo fino alla cintola, alzò al cielo le braccia tatuate d’uccelli, cantando con la sua gran voce azzurra:
— Allah! Allah! Allah!
Egli aveva la disinvoltura e la robustezza di un giovane atleta invincibile, armato per mordere, per strangolare e per atterrare. Il suo corpo troppo compatto, troppo vivo e quasi frenetico sotto una peluria fulva e una pelle chiazzata, come di serpente, sembrava dipinto coi colori della fortuna e della vittoria, al pari dello scafo di una bella nave. E la luce lo adorava certo appassionatamente, poiché non cessava d’accarezzargli i pettorali ampi, tutti a groppi d’impazienti radici, e i bicipiti che parevan di quercia, e la muscolatura inquietante delle gambe, alla quale il sudore dava luccicori esplosivi.
Il suo volto franco, dalle mascelle quadrate, aveva il colore delle terrecotte più belle; la sua bocca era grande e sensuale; il suo naso, fine e piuttosto corto; il suo sguardo, tenace. Gli occhi, d’un bel nero dorato di liquirizia, fiammeggiavano violentemente al sole, troppo vicini fra loro, come quelli degli animali da preda; ma spesso sembravano liquefarsi sotto la frangia delle ciglia, esagerando il pallore opaco di una fronte mite, coronata d’irremovibile volontà dai capelli foltissimi, corti e piantati vicini alle sopracciglia.
— Allah! Allah! — cantò egli ancora, con la sua bella voce dalle sonorità glauche e trasparenti, che sembrava avesse attraversato il mare.
E quella voce volava infatti, a volo spiegato, da un continente all’altro, sorpassando l’ondeggiare onnicolore delle cupole e dei pinnacoli, le piazze ribollenti di folla e le maestose ondate di verdura chiuse fra le candide dighe dei bastioni, che torri gialle interrompevano qua e là, ripercuotendo fino ai limiti del deserto il grido ieratico:
— Allah! Allah! Allah!
Era quello il segnale del riposo concesso dal capo supremo al grande esercito arabo, estenuato per la battaglia del mattino e gorgogliante ora nelle viuzze anguste della immensa città, come un’acqua sotterranea e minacciosa.
Quasi non si vedeva, quell’esercito, ma il suo sudore fumante e il suo tragico alito salivano globulosamente – come dalle finestre di un calidario – su, verso il cielo, dove la battaglia continuava ancora.
Nel cielo, un imperversare di freccie verdi, un aggrovigliarsi di lance nere, un crollar di massi incandescenti sul petto in fusione del Sole, che, ritto e tutto ignudo sullo zenit, si difendeva ancora vittoriosamente, facendosi turbinare intorno al capo una terribile scimitarra bianca. Fantastica ruota, di cui la sua faccia era il mozzo furibondo che girava velocissimo, in mezzo alla danza guerresca dei raggi alcoolizzati, alla rissa dei cembali e al garrire delle bandiere entusiastiche che la follia aveva piantate sulle cime lontane e sui morbidi divani delle colline… e laggiù, più lontano ancora, sugl’isolotti ostinati che spezzano flutti di zaffiro… e dappertutto, e dappertutto, sempre più lontano, vedete?… nel ventagio dell’orizzonte, che riabbatte sulla terra l’alito immenso, avventuroso, assurdo dell’Eterno!…
— Allah! Allah!… — gli rispose il formicolìo grigiastro dei soldati sui bastioni, le cui muraglie alte cento cubiti acciecavano come tanti specchi giganteschi sotto i loro merli puntuti in forma di burnù.
E frattanto, le pianure sabbiose dello zenit fremevano sotto il galoppo del Sole, che cavalcava a bardosso la sua indomabile giumenta nera, convulsa di velocità… Eccone la schiuma abbagliante ed eccone la sferzante criniera!… Arrovesciate il capo e vedrete i suoi zoccoli d’oro massiccio, che scalpitano nella bragia. Ma guardatevi dai suoi escrementi di caldo soffocante, che piombano dall’alto, accoppando uomini e bestie!…
— Allah! Allah! — rispose infine la folla delle galabieh turchine che formicolava in fondo al mercato e sulle terrazze sovraccariche di metalli rilucenti, di tappeti animati e di gabbie d’uccelli loquaci.
La città di Tell-el-Kibir aveva preso, da due giorni, un aspetto insolito. Impossibile circolare nelle sue vie rigurgitanti di gente, dove passavano di tanto in tanto dei carri pieni d’uomini ritti, aggrappati gli uni agli altri e sobbalzanti come fasci mal legati. Ma i tumulti della folla impantanavano ad ogni istante i cavalli, e i veicoli, immobili sotto i loro cocchieri furibondi, parevano allora isolotti sradicati e galleggianti sull’irrompere di un torrente devastatore.
Risse e parapiglia vi formavano continuamente dei gorghi di braccia e di bastoni alzati, di cui si divertivano rumorosamente le donne e i fanciulli che traboccavano dai balconi traforati delle moschee.
Anche queste erano state invase, come tutti gli altri edifici, dalle tribù del deserto che fuggivano davanti agli eserciti inondanti di Brafane-el-Kibir.
Popolazioni intere si erano ingolfate per le porte della città, recando le loro ricchezze ammucchiate su carri tratti da bufali, ed affluendo interminabilmente, da ogni parte, come altrettanti rivi che colassero in un’unica cisterna.
Ma, ad un tratto, una notizia trionfale era corsa per tutte le case, facendo sbattere di gioia tutti i cuori, così come un vento impetuoso fa sbattere le porte.
Si diceva dappertutto che Mafarka-el-Bar aveva detronizzato suo zio Bubassa, con un audace colpo di mano, assumendo subito la difesa della città e il comando supremo dell’esercito.
Quella sera, le lance delle sentinelle, sui bastioni, avevano subitamente brillato di una speranza di vittoria che non doveva rimaner delusa.
Infatti il petto di Mafarka, più forte di una diga, aveva ricacciato indietro l’oceano di bitume che orlava le colline fulve, sfiorate, all’orizzonte, da grandi nuvole striate e palmate di turchese.
Non gli venivano forse incontro per rendergli gli omaggi supremi, quei radiosi cetacei aerei, dalle pinne splendenti, la cui disinvoltura elastica rapiva lo sguardo, e che navigavano voluttuosamente pel vasto cielo, verso la città di Tell-el-Kibir?
E il vento le traeva pianamente; un vento torrido e nudo, dal corpo melodioso tutto rorido di sale marino, come un palombaro; un vento equilibrista, che spiccava un salto, passando al disopra della cittadella e gettava a palate, ai piedi di Mafarka, aromi violetti, acri fetori e rosse grida di marinai.
Poiché la flotta intera salutava in Mafarka il proprio ammiraglio, con tutte le sue bandiere luminose scivolanti su pei cordami e simili alle faville di un incendio agonizzante.
Ed egli si protendeva al di fuori, per contemplare, a trecento cubiti sotto ai suoi piedi, le sete abbrividenti e dorate del mare, che i fili della luce, pioventi giù dalla matassa delle nubi, tessevano all’infinito, sulle alberature intricate, con un andirivieni di gigantesco telaio.
Mafarka fece lentamente il giro della terrazza, affacciandosi a quando a quando al parapetto, verso il quale salivano a vicenda gli schiocchi delle vele, lo stridìo arrugginito dei maiali e il muggito violaceo dei buoi che si lamentano nelle profondità delle fattorie.
Ad un tratto egli si voltò, come se un uccellaccio nottivago lo avesse sfiorato. Kaim-Friza, il gran capo degli agricoltori, era dietro di lui e gli s’inchinava.
Addossato alla balaustrata, Mafarka ebbe un movimento di ripugnanza al guardare quel sordido nano che andava in una galabieh rossastra e infangata, e che a tratti spingeva fuor dalle spalle una piccola testa grinzosa di tartaruga.
Il re non aveva mai potuto vincere il sentimento di repulsione che gl’ispirava quell’essere meschino e scaltro, quantunque fossero grandissimi i servigi che egli aveva reso alla città con una saggia legislazione agraria.
— Sta lontano da me, amico mio, perché puzzi di letame… E, davvero, io ho singolarmente delicate le narici, questa mattina, dopo tutti i profumi di cadaveri di cui Dio mi ha gratificato… Ah! Ah! i miei scherzi ti dànno fastidio, lo so… Ebbene: che cosa vieni a comunicarmi?… Capisco… capisco… Tu mi supplicherai di metter fine alla guerra per non affamare il popolo!… La miseria delle campagne… So, so tutto! E me ne infischio!
Poi, prendendo Kaim per un braccio:
— Vieni qua! — soggiunse. — Ah! ah! vedesti mai...