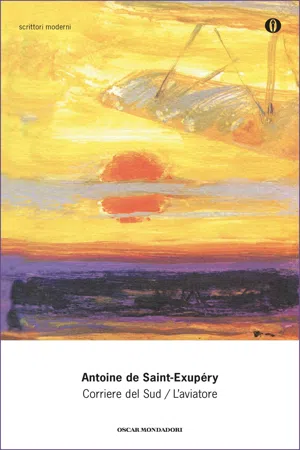Devo tornare indietro, raccontare questi due mesi passati, altrimenti che cosa ne rimarrebbe? Quando gli avvenimenti che mi dispongo a narrare avranno a poco a poco esaurito il loro debole risucchio, i loro cerchi concentrici sui personaggi che hanno semplicemente cancellato, come l’acqua richiusa di un lago, quando saranno ovattate le emozioni laceranti, poi meno laceranti, poi dolci che io devo loro, il mondo mi sembrerà di nuovo sicuro. Già posso passeggiare là dove il ricordo di Geneviève e di Bernis dovrebbe essermi crudele, senza che un rimpianto, appena, mi tocchi.
Due mesi prima Bernis risaliva verso Parigi, ma, dopo una così lunga assenza, non ci si ritrova più, si sente d’ingombro in quella città. Era soltanto Jacques Bernis, con addosso una giacca che sa di canfora. Si muoveva dentro un corpo intorpidito, goffo, e chiedeva ai suoi effetti personali, troppo in ordine in un angolo della stanza, tutto ciò che essi rivelano di instabile, di provvisorio: quella stanza non era ancora conquistata da biancheria pulita, da libri.
«Pronto... Sei tu?» Fa l’elenco delle sue conoscenze. È tutto un esclamare, un congratularsi con lui: «Bravo! Chi non muore si risente!». «Sì, in effetti...» «Quando ci vediamo?» No, oggi nessuno è libero. Domani? Domani giocano a golf, perché non ci va anche lui? Non ne ha voglia? Allora dopodomani – per cena – alle otto in punto.
Entra impacciato in un locale da ballo, tra i gigolò, senza togliersi il suo cappotto pesante come la tenuta di un esploratore. Quei giovani vivono la loro notte chiusi lì dentro come pesci in un acquario, fanno un complimento galante, ballano, tornano a bere. Bernis, in quel mondo evanescente nel quale è l’unico a conservare la ragione, si sente carico come un facchino, grava a perpendicolo sulle gambe, e i suoi pensieri non hanno alone. Si fa strada fra i tavoli verso un posto libero. Gli occhi delle donne che sfiora con i suoi lo evitano, sembrano spegnersi. I giovani si fanno da parte, ondeggiando, per lasciarlo passare. Similmente, di notte, a mano a mano che l’ufficiale di ronda avanza, le sigarette delle sentinelle cascano dalle dita.
Quel mondo lo ritrovavamo ogni volta, come i marinai bretoni ritrovano il loro villaggio da cartolina illustrata e la loro fidanzata troppo fedele, appena un po’ invecchiata a ogni ritorno. Sempre uguale, come l’incisione di un libro per bambini. A ritrovare tutto così al suo posto, così ben regolato dal destino, sentivamo il terrore di qualcosa di oscuro. Bernis chiedeva notizie di un amico: «Ma sì. Sempre lo stesso. I suoi affari non vanno granché bene. Sai com’è... la vita...». Tutti erano prigionieri di se stessi, limitati da quel freno oscuro e non come lui, il fuggiasco, il bimbo povero, il mago.
I volti dei suoi amici appena consumati, appena assottigliati da due inverni, da due estati. Quella donna nell’angolo del bar: la riconosceva. Il volto appena un po’ stanco per aver servito tanti sorrisi. Quel barman: lo stesso. Ebbe paura di esserne riconosciuto, come se quella voce, interpellandolo, potesse resuscitare in lui un Bernis morto, un Bernis senza ali, un Bernis che non era evaso.
A poco a poco, al ritorno, un paesaggio già si costruiva intorno a lui, come una prigione. Il paesaggio vero, che stava per rivelarsi, si toglieva di dosso le sabbie del Sahara, le rocce di Spagna, come costumi teatrali. Poi, passata la frontiera, ecco Perpignan servita dalla sua pianura. Quella pianura su cui fluiva ancora il sole, in lunghe colate oblique, di attimo in attimo più logore, abiti d’oro disseminati sull’erba, di attimo in attimo più fragili, più trasparenti, che non si spengono ma svaporano. E allora, un fango verde, cupo e dolce sotto l’aria azzurra. Uno sfondo tranquillo. Con il motore a basso regime, un tuffo verso quel fondo marino dove tutto riposa, dove tutto assume l’evidenza e la durata di un muro.
Il tragitto dall’aeroporto alla stazione, in automobile. I volti chiusi, duri davanti a lui. Mani che recano inciso il loro destino riposavano aperte sulle ginocchia, così pesanti. Contadini che tornavano dai campi, appena sfiorati. Una ragazza davanti alla porta che spiava l’arrivo di un uomo tra centomila, che aveva rinunciato a centomila speranze. Una madre che cullava il suo bimbo, che di quel bimbo era già prigioniera e non poteva fuggire.
Bernis, entrato nel segreto delle cose, tornava al paese per le strade più intime, con le mani in tasca, senza valigia, pilota di linea. Nel più immutabile dei mondi, dove per toccare un muro, per allargare un campo, erano necessari vent’anni di pratiche.
Dopo due anni di Africa e di paesaggi mobili e sempre mutevoli come la superficie del mare – i quali, però, tolti uno dopo l’altro, lasciavano nudo quel vecchio paesaggio, il solo, l’eterno, quello da cui era uscito –, lui, arcangelo triste, rimetteva i piedi su una vera terra.
“E tutto è uguale...”
Aveva temuto di trovare le cose diverse, ed ecco che soffriva di scoprirle così uguali. Non attendeva più dagli incontri, dalle amicizie che un vago senso di noia. Da lontano si immagina. Alla partenza si abbandonano dietro le spalle gli affetti con un morso al cuore, ma anche con lo strano senso di aver sepolto un tesoro sottoterra. Quelle fughe, a volte, testimoniano tanto avaro amore. Una notte, nel Sahara popolato di stelle, mentre pensava a quegli affetti lontani, caldi e ricoperti dalla notte, dal tempo, come sementi, aveva avuto la brusca sensazione di essersi tirato un po’ da parte per guardar dormire. Appoggiato all’aeroplano in avaria, davanti a quella curva della sabbia, a quel cedimento dell’orizzonte, vegliava i suoi amori come un pastore...
“Ed ecco quel che ritrovo...”
Bernis un giorno mi scrisse:
Non ti parlo del mio ritorno: mi credo padrone delle cose quando le emozioni mi rispondono: ma non se ne è ridestata nessuna. Ero simile al pellegrino che arriva a Gerusalemme un minuto troppo tardi. Il suo desiderio, la sua fede erano appena morti: e trova soltanto pietre. Questa città, qui: un muro. Voglio ripartire. Ti ricordi di quella prima partenza? L’abbiamo fatta insieme. Murcia, Granada appoggiate come gingilli nella loro vetrina e, poiché non atterravamo, sepolte nel passato. Deposte lì dai secoli che rifluiscono. Il motore faceva quel rumore denso che copre ogni altra cosa e dietro il quale il paesaggio passa in silenzio come un film. E il freddo, poiché volavamo alti: quelle città chiuse nel ghiaccio. Ricordi?
Ho conservato i biglietti che tu mi passavi:
«Sorveglia questo strano scoppiettio... Se aumenta, non ti arrischiare sullo stretto.»
Due ore dopo, a Gibilterra:
«Aspetta Tarifa per attraversare: è meglio.»
A Tangeri:
«Non strisciare troppo atterrando: terreno molle.»
Semplicemente. Con frasi come queste si conquista il mondo. Avevo la rivelazione di una strategia che quegli ordini brevi rendevano forte. Tangeri, quella piccola città senza importanza, era la mia prima conquista. Era, vedi, era il mio primo furto. Sì. Da principio in verticale, ma così lontano. Poi, durante la discesa, quello schiudersi dei prati, dei fiori, delle case. Riportavo in pieno sole una città sommersa che diventava viva. E poi, improvvisamente, quella miracolosa scoperta: a cinquecento metri dal terreno quell’Arabo che arava, che io traevo a me, di cui facevo un uomo a misura mia, che era davvero il mio bottino di guerra o la mia creazione o il mio gioco. Avevo preso un ostaggio e l’Africa m’apparteneva.
Due minuti più tardi, in piedi sull’erba, ero giovane, come posato su una stella dove la vita ricominci. In quel clima nuovo. In quel suolo, in quel cielo mi sentivo come un giovane albero. E mi stiravo dal viaggio con una fame divina. Facevo passi lunghi, flessibili per rilassarmi dopo il lungo pilotaggio, e ridevo di aver raggiunto la mia ombra: l’atterraggio.
E quella primavera! Ti ricordi di quella primavera dopo la pioggia grigia di Tolosa? Quell’aria così nuova che circolava tra le cose? Ogni donna racchiudeva un segreto: un accento, un gesto, un silenzio. E tutte erano desiderabili. E poi, tu mi conosci, quella fretta di ripartire, di cercare più oltre quello che presentivo e non comprendevo, perché ero il rabdomante che sente la sua verga di nocciolo tremare e la porta per il mondo sino al tesoro.
Ma dimmi, dunque, che cosa cerco? Dimmi perché, alla finestra, appoggiato alla città dei miei amici, dei miei desideri, dei miei ricordi, dispero? Perché, per la prima volta, non scopro alcuna sorgente e mi sento così lontano dal tesoro? Qual è questa promessa oscura che mi è stata fatta e che un dio oscuro non mantiene?
Ho ritrovato la sorgente. Ricordi? È Geneviève...
Leggendo questa parola di Bernis, Geneviève, ho chiuso gli occhi e ti ho rivisto bambina. Quindici anni, quando noi ne avevamo tredici. Come avresti potuto invecchiare nei nostri ricordi? Eri rimasta la stessa ragazzina fragile, ed era lei che arrischiavamo nella vita, sorpresi, quando ci giungevano tue notizie.
Mentre altri guidavano all’altare una donna già fatta, Bernis e io, dal fondo dell’Africa, c’eravamo fidanzati con una giovinetta. Bambina di quindici anni, sei stata la più giovane delle madri. Nell’età in cui ci si graffiano le gambe nude nei rovi, tu volevi una culla vera, giocattolo regale. E mentre fra i tuoi parenti, che non indovinavano il prodigio, facevi nella vita umili gesti di donna, per noi vivevi un racconto incantato ed entravi nel mondo dalla porta magica – come in un ballo mascherato, un ballo di bambini – travestita da sposa, da madre, da fata...
Perché eri una fata. Ricordo. Abitavi in una vecchia casa sotto lo spessore delle mura. Ti rivedo spiare il sorgere della luna appoggiata alla finestra simile a una feritoia. La luna saliva. E la pianura cominciava a mormorare e scuoteva le sue nacchere alle ali delle cicale, al ventre delle rane i suoi sonagli, al collo dei buoi che tornavano alla stalla i suoi campanacci. La luna saliva. A volte giungeva dal villaggio un rintocco funebre, e recava ai grilli, al grano, alle cicale l’inesplicabile morte. E tu ti sporgevi, in ansia soltanto per i fidanzati, perché nulla è tanto minacciato quanto la speranza. Ma la luna saliva. Allora, coprendo il suono della campana, i barbagianni si mandavano l’un l’altro richiami d’amore. I cani randagi, in cerchio, l’assediavano e le abbaiavano contro. E ogni albero, ogni erba, ogni canna era viva. E la luna saliva. Allora tu ci prendevi le mani e ci dicevi di ascoltare perché quelli erano i rumori della terra, ed erano rassicuranti e buoni.
Eri così ben protetta da quella casa e, attorno alla casa, da quell’abito vivo della terra. Avevi concluso tanti patti con i tigli, con le querce, con le greggi che noi ti chiamavamo la loro principessa. Il tuo volto si addolciva grado a grado, quando, di sera, il mondo veniva messo in ordine per la notte. «Il fattore ha riportato dentro le bestie.» Lo leggevi dalle luci lontane della stalla. Un rumore sordo: «Sbarrano le porte della chiusa». Tutto era a posto. Poi il tuono del rapido delle sette di sera che doppiava la provincia e spariva, pulendo finalmente il tuo mondo di tutto quanto è inquieto, mobile, incerto come un volto dietro i vetri dei vagoni letto. E la cena, in una sala da pranzo troppo grande, male illuminata, dove tu diventavi la regina della notte perché noi ti sorvegliavamo instancabili come spie. Tu sedevi silenziosa in mezzo ai vecchi, tra le pareti rivestite di legno, e, china in avanti, offrendo solo la tua chioma al cerchio dorato dei paralumi, incoronata di luce, regnavi. E per quel tuo essere così unita alle cose, così sicura delle cose, dei tuoi pensieri, del tuo avvenire, ci sembravi eterna. Regnavi...
Ma noi volevamo sapere se fosse possibile farti soffrire, stringerti fra le braccia sino a soffocarti, perché sentivamo in te una presenza umana che desideravamo portare alla luce. Una tenerezza, un’angoscia che desideravamo vedere. E Bernis ti stringeva tra le braccia e tu arrossivi. E Bernis ti stringeva più forte e i tuoi occhi si facevano lucidi di lacrime senza che le tue labbra imbruttissero come quelle delle vecchie che piangono, e Bernis mi diceva che quelle lacrime venivano dal cuore improvvisamente colmato, più preziose dei diamanti, e che chi le avesse bevute sarebbe diventato immortale. Mi diceva anche che tu abitavi il tuo corpo ...