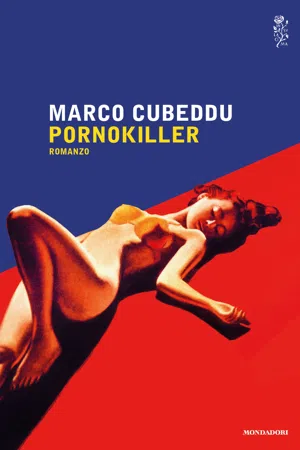“Bella mossa” pensa Carlo, quando Michele Ortaggio, una settimana dopo la comparsa di Brunilde nel cortiletto della sua casa di produzione, lascia la tenuta dei Ballauri gridando: «Te la vedrai con Dmitri!». “Bella mossa davvero” mormora tra sé Carlo masticando un Pocket Coffee come se fosse una bistecca mentre chiude la porta e pensa a cosa succederebbe se chiedesse un prestito a suo fratello per assoldare una guardia del corpo: “Vedi, Gabriele, c’è stato un malinteso, c’è questo Dmitri, è un russo che ha sviluppato una particolare forma di feticismo per le mie articolazioni, e mi chiedevo se tu potessi, non so, diciamo, magari, darmi cinquemila euro per assumere qualcuno, o magari prestarmi anche un paio dei tuoi stagisti, che mi guardi le spalle?”.
Tuuu tuuu tuuu.
Quando ritorna in salotto, dove stava riscrivendo a matita una scena, Brunilde è sdraiata sul divano di pelle, accoccolata nell’enorme impronta lasciata dal suo protettore, intenta a catturare, pinzandoli con le dita laccate d’azzurro del piede sinistro, alcuni fogli della sceneggiatura che Carlo aveva bruscamente abbandonato in fondo al sofà quando era suonato il campanello.
«Ho fame» gli dice, gli occhi fissi sulle sue deliziose estremità.
«Hai finito adesso le patatine» risponde Carlo, rassegnato comunque all’idea di andare in cucina a friggere due uova con un po’ di bacon, senza sospettare che quella esuberante ragazzina stesse, con quegli accessi di fame, coltivando nuove forme di disturbi alimentari, diametralmente opposte a quelle che aveva coltivato in passato.
Appena l’ombra elfica di Brunilde si era posata su di lui, nella pausa pranzo della Hardcorps, Carlo aveva deciso che non avrebbe mai più rimesso piede lì dentro.
Erano andati in un bar di via Pietro Micca e lei gli aveva raccontato la storia della sua vita. Il fratello morto. L’anoressia. L’indifferenza dei suoi genitori. Lo squallore ipocrita della vita borghese. Le fotografie di Sally Mann, il twerking, le performance di Gina Pane. Niki de Saint Phalle. Anders Petersen. Il degrado. Lo zoo di Berlino. Il senso di vuoto. Le poesie su “Nuovi Argomenti”. Il bisogno di dominazione. David Bowie. Yves Klein. Forrest Bess. Piero Manzoni. Tagliarsi. Dimagrire. Scopare. Ingrassare. Morire. Trovare se stessa. Robert Pattinson. L’assoluto. L’aria. Il senso estetico. Bas Jan Ader. Nam June Paik. Il dolore. La solitudine. I numeri primi. Il desiderio di affermazione. L’essere disposta a tutto. La fama. La Marilyn d’oro.
Le mutandine.
La fuga.
Carlo ascoltò tutto con grande trasporto.
Gli sembrava di capirla benissimo: un’artista sofferente, una minuscola versione di se stesso dal musetto affilato.
L’unica cosa che non capì veramente fu la parola “mutandine”.
“Mutandine?” si domandò sovrappensiero.
Se solo avesse dato retta al formicolio che emanava dalla parola “mutandine”, conferendo a quel termine meraviglioso il ruolo di riassunto esatto di Brunilde, un frattale composto di desideri inconfessabili che lei era più che lieta di confessare, forse avrebbe potuto davvero comprendere qualcosa di quella smaniosa e pornografica ragazzina.
Invece, «Con permesso», si alzò per andare a ordinare.
«Mutandine...» comandò a un perplesso barista dai capelli rossi quando arrivò al bancone.
«Come, prego?»
«Ehm, volevo dire, due cappuccini» si corresse, trattenendosi dall’ordinare uno qualunque dei dieci doppio malto esposti in un’invitante vetrinetta semiaperta. «E, mi scusi, c’è del rum dentro quel brownie al cioccolato?»
«No, signore.»
«Ah, be’, allora no, be’, no, allora sì, me ne dia uno.»
Brunilde, dietro di lui, tirava fuori dal box delle bustine di zucchero di diversi colori – cinque, uno per ogni Paese di provenienza di pregiati caffè. La grossa carcassa di Carlo tornò a sedersi di fronte a lei.
Brunilde dispose le bustine in fila sul tavolino: Etiopia arancione, Guatemala azzurro, Papua lilla, Brasile giallo, Giamaica verde acido.
Un pingue cameriere in livrea servì loro due bellissimi cappuccini e il brownie, disposto in un piatto con coltello e forchetta avvolti in un tovagliolo. Brunilde ringraziò lasciva il frocissimo cameriere e poi esclamò: «È giunto il momento che tu scelga la tua bustina di zucchero».
E lui, interdetto: «Prego?».
«Allora, qual è la tua preferita?»
“Non credo di aver capito bene la storia delle mutandine” avrebbe voluto dirle Carlo, fissando quelle bustine alla ricerca di un senso di eternità.
«Scegli una bustina.»
«Quale dovrei scegliere?» le domandò tentando di inforchettare il brownie, una, due, tre volte, per poi rinunciare e ficcarselo in bocca tutto intero davanti allo sguardo divertito di Brunilde.
«Insomma, quale dovrei scegliere?» ripeté, farfugliando.
«La Papua, naturalmente.»
«Ah sì? E perché?»
«Perché è al centro, perché ha un bel colore... e perché si chiama “Papua”.»
Papua.
Mutandine.
Mutandine lilla?
L’inevitabilità degli avvenimenti, l’insindacabilità della concatenazione.
Lei: androgina, adorabile, magnetica.
Lui: febbricitante, disperatissimo, determinato a trasformare quella ventata di pubescente divinità in un capolavoro.
Come poteva funzionare quel mutuo soccorso per ottenere la parte di Paradiso che non può attendere?
Adesso
Anche se è passata solo una settimana, e non ci sono validi motivi per scoraggiarsi, le vibrazioni che gli rimbalzano contro quando telefona alle case di produzione per discutere delle modalità di invio del copione non sono per niente positive. «No grazie», «Al momento abbiamo un programma serratissimo fino al 2017», «Non ci interessa», «Prrrrrrrrrrrr.»
A Carlo basterebbe un budget anche limitato, un paio di milioni sarebbero sufficienti.
“Potrei chiedere i soldi a Gabriele” pensa. Ma si immagina già la scena.
“Pronto, parla il dottor Ballauri.”
“Ehi, ciao fratellone, come va?”
“Non mi chiamare fratellone.”
“Ok, mi scusi, primario. O preferisci che ti chiami già signor sindaco?”
“Che vuoi?”
“Mi servirebbero due milioni di euro.”
Tuuu tuuu tuuu.
No, non funzionerebbe.
E quindi, forse è giunto il momento.
Inutile stare a girarci troppo intorno. Carlo si guarda le mani. Le stringe fino a farle diventare bianche. Dà una fuggevole occhiata a Brunilde che scarta un altro pacchetto di Rodeo e si ficca una manciata di quella merda gialla in bocca premendosi il palmo salato contro la faccia e passandosi innocentemente la lingua sulle labbra. Carlo ingurgita un Pocket Coffee.
06/171951...
Tuuu...
Digrigna i denti.
Tuuu...
Si morde le unghie.
Tuuu...
«Giratichetantoècinema production.»
«Buon, giorno. Dovrei, parlare, con, Vittorio Marnero.»
«Non sono certa che sia in ufficio in questo momento. Mi dia un attimo che verifico. Chi devo dire?»
«Se fossimo in uno dei suoi pessimi film, le direi di annunciare il suo miglior nemico.»
Qualche anno prima
Perché si possa capire fino in fondo la drammaticità di quella telefonata e dell’attesa che ne seguì è necessario fare un passo indietro.
Torniamo dunque a quando Carlo Ballauri, insieme a Vittorio Marnero Rinaldi, si trasferisce a Roma per frequentare il biennio di regia del Centro Sperimentale di Cinematografia. Siamo nell’anno del Signore 1991. Come un quasi laureato al Dams con un passato tanto turbolento e con così poco materiale all’appello (escludendo la felice e produttiva parentesi alla Film Academy) ci sia entrato, al CSC, è in sé un fatto tanto obliquo quanto evidente: grazie all’influente raccomandazione del padre, Ettore Ballauri, stimato primario di cardiochirurgia, Cavaliere del Lavoro, professore di fama e solido catalizzatore di un pacchetto di voti fondamentale per la sopravvivenza del governo Andreotti VII.
Sarebbe da ingenui dubitare del fatto che anche per Vittorio Marnero, laureato in Giurisprudenza con la media del 21, il Cavalier Ballauri non abbia avuto piacere di dire alla persona giusta che era bravo.
Mentre Gabriele Ballauri si avviava a seguire con largo anticipo i successi paterni (segretario di una sezione del Partito, già severissimo professore a contratto e, malgrado la giovane età, chirurgo scrupoloso e rispettato), il fratello più piccolo, che già allora, nonostante la stazza impressionante, sembrava destinato a essere sempre il vezzeggiato e bizzoso secondogenito di casa, si avviava col suo migliore amico alla volta di Roma, deciso come il suo sodale a entrare nel pochissimo serio, ma abbastanza redditizio, ambiente cinematografico italiano.
Vittorio aveva non poco infastidito i suoi genitori con la scelta di impiegare la sudata benché mediocre laurea (comunque bilanciata dal suo prestigioso cognome) per entrare al corso di produzione del CSC nel tentativo di diventare un qualcosa che i Marnero non potevano che concepire come inferiore alle loro aspettative («Vittorio, i Marnero sono principi del foro da quasi centocinquant’anni!»), rifiutandosi di capire che è il denaro, solo il denaro, in definitiva, a determinare realmente i sommersi e i salvati del reame. Le diramazioni araldiche non sono che velleitari addobbi domestici se non poggiano su solide fondamenta di denaro. Ma dopo il fallimento in borsa delle azioni Telefunken il 22 aprile 1987 e la fuga a Mururoa del loro mediatore finanziario israelita, travolti dai debiti, avevano dovuto puntare tutto sui nobili natali e sulla rispettabilità sociale dello studio di famiglia (sulla via del pignoramento) quale àncora di salvezza.
Obiezione respinta.
Vittorio era cresciuto subendo le ramanzine di sua madre: «Tu non sei come il tuo amico Carlo, suo padre non ha gettato al vento una fortuna, suo padre non ha messo i suoi soldi nelle mani di un viscido verme solo perché quel disgustoso lombrico ebreo lo portava a fare weekend in barca con quelle mignotte minorenni che rimorchiava al Catscratchclub, tu devi studiare, non fare sciocchezze, studia Vittorio, studia...».
Quanti pianti casalinghi gli era toccato sopportare, povero Vittorio Marnero Rinaldi, «la nostra unica speranza di riscatto», e quanti orrendi paragoni con quel suo tracotante amico del cuore e con suo padre: «Quello ama l’oro e teme la morte, il tuo ama le troie e teme solo di essere scoperto».
I suoi genitori puntavano tutto su di lui. Era il figlio unico cui era affidato l’immane destino di riconquistare la villa dei nonni materni, battuta all’asta da un giudice fallimentare quando ancora frequentava il quarto anno del liceo per pagare i debiti e rimpianto quotidiano di sua madre, incapace di adattarsi a vivere in uno “squallido” appartamento in centro: «Non abbiamo nemmeno una stanza per la cameriera», «tanto non possiamo permettercela», «lo capisci come ci siamo ridotti? Lo capisci?».
Quindi Vittorio avrebbe dovuto trangugiare il boccone insipido della giurisprudenza per tenere alto il buon nome della famiglia e riscattare la magione avita.
Carlo invece.
Su Carlo nessuno della sua famiglia riponeva alcuna aspettativa. Al di là dell’illimitata e inspiegabile fiducia paterna, nessuno credeva che avrebbe combinato qualcosa di buono nella vita.
Ma fino a quando la florida condizione economica e politica dei Ballauri poteva ritenersi al sicuro, fintanto che ci pensava il figlio grande, q...