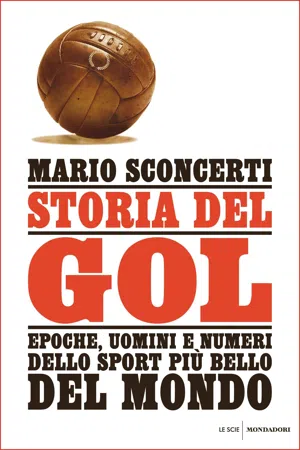La vittoria del Mondiale rese automatico un cambiamento che si stava preparando da anni. Forse era stato proprio l’inizio di quel cambiamento a portare l’Italia a vincere il Mondiale, di sicuro con quella vittoria si aprì l’ultima porta. Con un avvertimento da tenere sempre presente: il Mondiale non fu la causa, fu l’ultima conseguenza, l’ultima spinta per superare il piccolo muro che ancora ci divideva dalla differenza. Andiamo con ordine.
Il calcio era sempre stato un fenomeno popolare, ma spezzettato fra tante città. Non esisteva uno spettacolo unico. Esisteva la singola partita. Non c’era televisione, nessuno capiva cosa potesse essere la partita in diretta perché mancava un senso complessivo della potenza del calcio come spettacolo. Eppure la RAI aveva tutto per poter trasmettere le partite, ma si pensava che non sarebbe stato un vantaggio per il pubblico, che avrebbe tolto spettatori agli stadi. Tutto quello che veniva trasmesso era un tempo di una partita la domenica alle 18.45. La scelta della partita era tirata a sorte. Non una sola immagine in diretta, nemmeno quando le società cominciarono a vendere alla RAI i propri diritti. Per molti anni la RAI ha pagato miliardi di lire uno spettacolo semplicemente per toglierlo dal commercio. Perché non lo prendesse qualcuno dei piccoli concorrenti televisivi che cominciavano a nascere in tutta Italia. Questo continuava a produrre lo stesso risultato degli anni Venti: pochissimi vedevano calcio in Italia. Solo quelli che andavano allo stadio. E anche quelli non vedevano che la loro squadra. Una modesta visione d’insieme riuscivano ad averla materialmente solo quella decina di giornalisti che, per i quotidiani più importanti, vagavano ogni domenica sui campi principali. Pensiamoci un momento: è un caso eccezionale di schizofrenia comunicativa. Come se i Beatles potessero essere ascoltati solo a Liverpool e i Pooh solo a Bergamo. Come se Van Gogh non potesse uscire da Amsterdam o Cartesio da Tours. Come se non potesse esistere uno spettacolo nazionale che già esisteva. Un’autocensura che è stata la miglior dimostrazione della cecità della RAI di allora, ma ancor più dell’ottusità e della visione breve dei dirigenti del calcio. Si salvaguardava il campanile, mentre tutto diventava di tutti, si impediva alla gente di vedere altri interpreti, altre soluzioni, altri amici o avversari fuori da quelli che portava uno stadio. Il calcio era una specie di dovere municipale, non un gioco universale.
Tutto il movimento era finalizzato a una sola strada, quella che portava alle partite della Nazionale. Solo l’Italia era degli italiani, solo quel sentimento doveva essere di tutti e trovare un posto in televisione. Il campionato, le singole squadre, l’intera energia del calcio, non erano che affluenti che avevano il compito di portare acqua al vero sentimento, quello per la maglia azzurra, l’unico santificato dai dirigenti del paese. Oggi ci lamentiamo spesso perché il calcio è diventato solo un affare di soldi. Lo era anche allora, non può che esserlo sempre stato. Solo che in quegli anni era buono il presidente che perdeva soldi con il calcio, il mecenate. Oggi è cattivo quello che vorrebbe guadagnare qualcosa.
La Nazionale, dunque, unificava un intero movimento che nessuno, nel suo complesso, conosceva, anzi, nemmeno aveva mai visto. Generazioni e generazioni di italiani che hanno tifato Juventus senza averla mai vista. O Inter, o Milan, o qualunque altra squadra. Brera raccontava che Rivera era un abatino, ma la domanda vera era chi fosse Rivera. Chi lo aveva mai visto tranne quelli che andavano a San Siro? L’unica finestra su questo mondo era la Nazionale, una specie di coscienza, di anima globale. È anche per questo che il tifo era molto più ordinato. Non aveva riferimenti, poteva discutere solo di se stesso. Oggi si discute se introdurre la moviola in campo. Per decine di anni si sono evitati problemi d’interpretazione non facendo vedere niente.
La televisione a colori cambia il calcio
I Mondiali in Argentina del 1978 portarono la prima grande novità, la televisione a colori. Non fu chiaro solo che dovevamo tutti comprare un altro televisore, divenne chiaro che stavamo vedendo un altro gioco, un altro spettacolo. Il calcio era come noi, aveva i nostri occhi e noi i suoi. Qualcosa di travolgente avvenne come ogni volta che arriva la normalità. Capimmo che fino ad allora avevamo visto solo una grande finzione. Che la maglia era azzurra e non grigia, che Cabrini era biondo, che la maglia scura sfina e quella chiara ingrossa. Fu come se il calcio e i suoi protagonisti entrassero in «quattro dimensioni» nel salotto di casa nostra. L’Italia andò bene, questo fu molto utile. Nonostante all’inizio ci fossero molti problemi, vinse le prime tre partite, battendo anche l’Argentina nel girone di qualificazione, illuse, e alla fine ottenne un quarto posto che il bisogno di benedire l’immenso spettacolo appena goduto fece diventare un risultato «storico».
In realtà, storico quel risultato lo fu davvero, ma non per ragioni tecniche. Era successo che il calcio aveva finalmente trovato tutta la sua platea, il suo popolo. Era successo che il calciatore (Rossi, Cabrini, Tardelli, Antognoni, Bettega) era diventato l’eroe di una mitologia moderna e non ancora usata. I giornali popolari non parlarono più dei pettegolezzi sulle corti europee. Principi, re, attori, politici fecero tutti un passo indietro. Il nuovo argomento era il calciatore, i suoi amori, le sue ricchezze, le sue stranezze. Il calciatore era famoso, bello, giovane, sano, ricchissimo, era trasversale, aveva tutto per riempire l’immaginario della gente. Quale madre non avrebbe dato la propria figlia a Rossi o Cabrini? Quale padre non avrebbe dato del tabacco da pipa e un asso di picche a Bearzot? Rapidamente fu chiaro che il calcio, per la prima volta dopo la guerra, era diventato la lingua di tutti, non era più emarginabile. Bisognava cavalcarlo. Mussolini lo aveva capito, a essere sinceri, una cinquantina di anni prima, ma aveva altri programmi. Voleva dal calcio una mano ideologica. Alla fine degli anni Settanta fu chiaro, invece, che il calcio era petrolio puro.
L’improvvisa scoperta collettiva ebbe una conseguenza mai capita. Portò il calcio dal senso di movimento nazionale a quello del singolo individuo. Finché l’unica cosa vista era la Nazionale, i giocatori erano singoli pezzi del mosaico. E le città le uniche casse di risonanza. Si viveva in mondi separati che soltanto la Nazionale metteva insieme. Quando l’Italia si affermò come spettacolo televisivo e divenne realmente di tutto il paese, fu naturale spezzarla attraverso i personaggi. Si sentì il bisogno di capire chi fosse davvero questo Rossi che con i suoi gol conquistava più terre di qualunque esercito. Chi fosse davvero ogni singolo giocatore. Le immagini non portavano la squadra, ma la somma di singoli giocatori. La gente si abituò a volere la storia degli individui, non più solo della squadra. Fu questo a rendere i calciatori delle vere star e rovesciò il concetto. Non era la Nazionale che faceva il calcio, ma viceversa. Al centro del mondo arrivava il calciatore. Il resto erano conseguenze. È adesso che comincia il senso moderno del calcio, la realtà che conosciamo oggi.
L’Italia dell’82 vive già in quel mondo. Riesce a esasperarlo, a esaltarlo, a farne una bandiera, ma è anch’essa una conseguenza. Quell’Italia gioca già accanto a Maradona, esalta già l’individuo, è già pronta ad accogliere sponsor. Non ha bisogno di eroi. Per la prima volta è essa stessa il frutto degli eroi. Infatti, la prima cosa che accade è che, al rientro in Italia, i giocatori della Juve neocampioni del mondo si presentano davanti a Boniperti, il presidente dei contratti in bianco, delle non discussioni sugli ingaggi perché la vera ricompensa è giocare nella Juve, con alla loro destra i procuratori. Figure nuove che trattano per loro i compensi individuali. Finisce di esistere la Squadra, si parla uno per uno e sulla base di quanto ogni singolo calciatore ha fatto. Non a caso, poco dopo, finisce anche Boniperti, l’ultimo grande di un mondo concluso.
Il trionfo del singolo
Questo ribaltamento di valori, cioè la centralità improvvisa del singolo sul collettivo, ha molte altre cause non meno importanti. Il 23 marzo 1981 era stata approvata la legge che aboliva il vincolo sportivo per i calciatori professionisti. Fino a quel momento chi firmava un contratto era legato a vita con quella società. Poteva essere ceduto solo se la società lo voleva e dietro il compenso che la società decideva per sé. L’abolizione del vincolo porta a contratti a tempo. Il giocatore è patrimonio di una società, è iscrivibile a bilancio, ma solo per la durata del contratto. È in sostanza perennemente in affitto e padrone del suo destino. Il giocatore non è più solo uno stipendiato, ma diventa il capitale di se stesso. Può «vendersi» a chi lo paga di più. Questo porta gli ingaggi a cifre molto più alte. Ogni contratto è un’asta. Aumenta di conseguenza la forza politica del giocatore sulla società. È qui che finiscono le famose bandiere, ogni giocatore va dove può e dove gli offrono condizioni migliori.
Arrivano, sempre a inizio degli anni Ottanta, le sponsorizzazioni individuali. La nuova attenzione sul calcio fa sì che il giocatore sia un’azienda a parte rispetto alla società. Non indossa gli scarpini della squadra, ma quelli della marca che più lo convince. Fa pubblicità dovunque. Non solo, ma spesso gli sponsor sono determinanti nel fargli scegliere le destinazioni più convenienti. Il primo caso fu proprio Paolo Rossi, il calciatore che, dopo i tre gol ai Mondiali del 1978, per primo divenne il simbolo della commercializzazione moderna. Quando il Vicenza, la sua squadra, andò in B e i costi di Rossi diventarono troppo alti, intervenne uno sponsor, la Pasta Ponte, a coprire una parte importante del suo stipendio e a permettere il passaggio al Perugia. Oggi, tutti i grandi giocatori viaggiano per società diverse guidati e coperti da sponsorizzazioni che ne moltiplicano lo stipendio.
Nasce di conseguenza la figura del procuratore, l’uomo che ha l’incarico di trovare lavoro continuato e pagato il meglio possibile al suo assistito, ormai non più protetto da un contratto a vita. Tutto, in sostanza, si sposta dalla parte del calciatore. Questa novità presenta anche aspetti negativi, sono molti quelli che restano senza lavoro perché nessuno rinnova loro il contratto. Ma a questo porrà presto rimedio il «parametro zero», cioè i giocatori lasciati liberi dalle loro società oppure che non hanno più vincoli contrattuali. Sono un’infinità dovunque. Nel 2014, uno studio dell’UEFA condotto dal general manager dell’Inter Piero Ausilio rivela che i parametri zero rappresentano ben il 73 per cento dei trasferimenti da un club all’altro. Sette giocatori su dieci si trasferiscono ormai per libera decisione, trattando da singoli, fuori dalla vecchia società di appartenenza.
Nasce la violenza del tifo
Ma ci sono conseguenze più profonde. La scoperta dell’«individuo» rende più facile il tifo collettivo per una sola squadra. Il giocatore simbolo non è più di una città, diventa di chi lo vuole, un fattore potenzialmente universale. Questo moltiplica la capacità di attrazione delle grandi squadre, che possono avere questo tipo di giocatori. Non c’è più solo una Grande Juve, ora ci sono soprattutto la Juve di Platini o il Milan di Gullit, il Napoli di Maradona. È il campione che rende comune una causa. Il tifo non è più un fatto cittadino, si allarga al singolo calciatore, all’uomo simbolo. Si allarga così anche la differenza tra chi ha soldi e chi ne ha meno, tra la grande città e la provincia.
A sua volta questo causa una specie di difesa naturale dei meno forti. Nasce il tifo organizzato, nasce il tifo violento. Si porta sulle tribune e fuori dallo stadio quell’uguaglianza di forza che non si può più portare sul campo. Dagli sfottò si passa improvvisamente allo scontro fisico. Dall’avversario al nemico il passo è breve e viene compiuto in fretta. L’importanza del calcio è diventata un godimento di massa. Essere esclusi dal suo clamore significa risultare anonimi, una vita inaccettabile. La violenza del tifo risponde soprattutto al terrore di quell’anonimato.
Il gol degli anni Ottanta
Questo nuovo modo di interpretare il calcio cambia il modo di giocare. Subito dopo i Mondiali di Spagna si ha un forte ritorno al gol. Il primo incremento è del 6,54 per cento, l’anno dopo addirittura del 20,8 per cento. La media gol a partita passa da 1,97 a 2,39, in pratica cento gol in più. È successo qualcosa di forte di cui quasi nessuno si accorge. È timidamente iniziata la generazione che vuol considerare il calcio uno spettacolo, che esige dalla partita non solo un risultato emotivo ma anche tecnico, qualcosa che diverta fino in fondo.
Il primo cambiamento imposto dai tempi è strutturale: si aumenta il numero di squadre in gioco. Il campionato a sedici squadre diventa troppo piccolo, tiene fuori troppe città. È anche pericoloso, aumenta il rischio di retrocedere. Il nuovo elitarismo fa diventare appagante solo la serie A. Essere in B non dà nessuna visibilità.
Nel 1987 sono in serie A Pescara, Avellino, Como, Empoli, Pisa, Ascoli, Cesena, tutto in un campionato a sedici squadre. Sono fuori squadre (e città) come Genoa, Palermo, Lazio, Atalanta, Bologna, Udinese, Brescia, Bari. Si allarga il campionato a diciotto squadre, si comincia ad andare alla ricerca del pubblico delle grandi città. Resisterà sempre l’eccezione, ma sarà meno gradita e sempre più rara. Si prepara una prima vera selezione che dovrà portare al calcio televisivo, cioè al massimo del guadagno.
Tornano gli stranieri
Per portare spettacolo, per assecondare la flessibilità del calcio e quella improvvisa dell’economia nazionale (siamo nei profondi anni Ottanta, è finito il terrorismo, si decide di investire sul debito pubblico, arrivano soldi che poi dovremo pagare, ma non in quel momento), si fanno tornare anche gli stranieri. La decisione di una piccola apertura è del 1980. Si dice sì a uno straniero per squadra. Ne arrivano undici, di cui solo cinque attaccanti. Il più decisivo fu Paulo Roberto Falcão. Il più discusso, quasi un simbolo dell’impotenza, Luís Sílvio della Pistoiese. In generale furono buoni giocatori. La Fiorentina portò in Italia un campione del mondo, Daniel Bertoni. Il Bologna un buon brasiliano, Enéas. Il Torino un difensore olandese, Michel Van de Korput. La Juventus Liam Brady, l’Avellino Juary, l’Inter Herbert Prohaska, l’Udinese Herbert Neumann, il Perugia l’argentino Sergio Fortunato, il Napoli il grande libero olandese Ruud Krol.
Fu una prima ondata transitoria, in cui le società cercarono di investire con giudizio, senza scommettere troppo. A parte Luís Sílvio, tutti gli altri si confermarono buoni giocatori. Non decisivi, ma investimenti mirati. L’anno dopo arrivarono altri sette stranieri. Finché, nel leggendario 1982, si decise di passare a due stranieri per squadra. Due su undici giocatori era un numero sufficiente per influenzare i risultati. Chi poteva, cominciò a cercare il grande investimento. La Juve fu la più svelta, arrivarono insieme Platini e Boniek. Poi anche Inter e Milan si adeguarono in fretta con Rummenigge, Matthäus, Gullit, Van Basten, Rijkaard. La nuova dimensione del calcio aveva costretto chi voleva vincere a cercare il meglio, a non poter barare. Si era alzata la posta, stava finendo il calcio aperto a chiunque, compresi i piccoli avventurieri che erano finiti in carcere uno dietro l’altro. Nel calcio che andava costruendosi potevano concorrere solo i più ricchi.
L’ultima stagione di tutti fu quella del Verona, 1984-85, peraltro l’unica con sorteggio integrale degli arbitri. Negli ultimi trent’anni non c’è più stata una vittoria imprevista. Toccò alla Samp nel 1991, ma quella di Paolo Mantovani era allora la società più ricca d’Italia, non una sorpresa.
Dall’arrivo della TV a colori, nel 1978, dalla preparazione di quella che fu la vittoria al Mondiale di Spagna quattro anni dopo, tutto il calcio italiano prese a correre con grandissima fretta. Le cose che accadevano fuori dal campo, cioè una buona circolazione di soldi, il bisogno dei nuovi ricchi di mostrarsi attraverso l’investimento nel calcio, la coscienza comune di avere tra le mani uno spettacolo universale, cambiarono in fretta anche le cose che accadevano sul campo. Nacque un calcio che non avevamo mai visto. Né migliore né peggiore, però più vicino ai tempi e al bisogno di spettacolo.
Andiamo con ordine. Questi sono i primi tre marcatori nei diversi campionati degli anni Ottanta.
Anni Ottanta. Classifiche cannonieri
| Campionato | 1° posto | 2° posto | 3° posto |
| 1... |