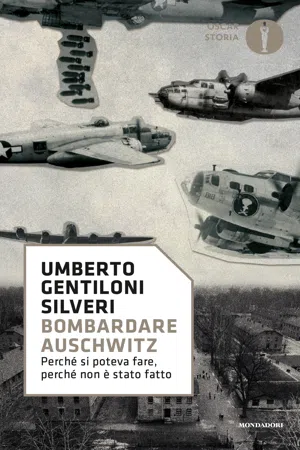«Poche cose rompevano la terribile monotonia della vita nel campo come il rumore di un aereo che si avvicinava fino a passare sulle nostre teste. Per la verità è successo raramente durante l’ultima estate della mia permanenza ad Auschwitz, nel 1944.» Piero Terracina racconta il passaggio dell’aviazione alleata sul perimetro del campo di concentramento, il suo ricordo è carico di interrogativi e rimpianti. Perché non hanno bombardato? Cosa aspettavano per colpire quella fabbrica di morte dove eravamo in attesa che venisse il nostro turno?
«Non potevamo e non volevamo credere che il mondo si fosse dimenticato di noi. Alla fine pensavamo che gli aerei fossero un segno di speranza, un contatto con ciò che avveniva fuori da quell’inferno e un sintomo di qualcosa che si muoveva lontano e che presto ci avrebbe raggiunto. Ci speravo dentro di me, anche se molti di noi avevano perso ogni desiderio, convinti che la fine fosse solo questione di tempo e che non ci fosse più nulla in cui sperare.»
La libertà poteva venire dal cielo, da quelle incursioni che sembravano inarrestabili. Ma anche la morte poteva arrivare da un ordigno sganciato sul campo. Anche questa, in un paradosso che solo la guerra riesce a proporre, era una speranza di molti prigionieri: colpire il sistema nazista per bloccare l’orrore, fermare la strage di innocenti che ogni giorno si allargava, spezzando nuove vite. Del resto, che senso aveva andare avanti con il riferimento a quell’orizzonte terribile? Meglio una bomba sulla testa, una fine rapida che avrebbe forse indebolito se non interrotto l’ingranaggio della morte di massa.
Speranze rimaste sospese in un tempo ormai lontano sono divenute argomenti di un atto di accusa che turba le coscienze del mondo intero, chiama in causa le modalità politiche e militari della vittoria alleata, si spinge fino agli interrogativi morali sulle priorità e sulle scelte della coalizione dei vincitori. La guerra è lontana ma le eredità di quella stagione abitano il nostro presente, nei passi avanti e nelle debolezze delle democrazie del dopoguerra e nelle inquietudini che hanno accompagnato lo svelamento dell’orrore nazista e dei suoi tanti corresponsabili.
Piero Terracina era stato arrestato perché ebreo, a Roma, a casa sua; il 7 aprile 1944 due SS accompagnate da spie italiane lo fanno salire su un’ambulanza e lo conducono al carcere di Regina Coeli. Viene rinchiuso nel terzo braccio, passato per il transito di Fossoli – il campo di prigionia e concentramento allestito dal regime fascista nel 1942 – e da lì inserito nel trasporto per Auschwitz, il 16 maggio. Giunge a destinazione sei giorni dopo e ci rimane fino alla liberazione del gennaio 1945. Oggi racconta la sua esperienza di sopravvissuto girando per scuole e università della penisola. La sua familiarità, se così si può dire, con gli aerei parte da lontano. Nei mesi di prigionia (viene tatuato con il numero di matricola A-5506) è assegnato a varie squadre di lavoro tra le quali il non meglio definito campo di aviazione dove vengono smontate e assemblate carcasse di aerei alleati e tedeschi colpiti in diversi teatri di guerra del vecchio continente e trasportati a pochi chilometri da Auschwitz-Birkenau. Un lavoro faticosissimo che prevede la capacità di spostare pesi enormi in una distesa di rottami che si perde per estensione fino all’orizzonte dello sguardo.
«Immerso tra aerei distrutti pensavo che prima o poi ne sarebbe arrivato uno che avrebbe colpito dove speravamo, sulle attrezzature di morte, sulla macchina dello sterminio. Un giorno sfinito dalla fatica mi sono nascosto e poi addormentato immerso nella montagna di lamiere delle carcasse di aereo che mi circondava.»
Terracina porta dentro di sé il peso di quegli interrogativi; con sofferenza racconta delle incursioni che ha seguito con lo sguardo rivolto al cielo, a un possibile segnale di speranza o, comunque, di discontinuità. Tra luglio e agosto 1944 gli allarmi aerei si intensificano fino a coinvolgere chi alloggiava nelle baracche del campo. «Era probabilmente il 3 di agosto quando suona l’allarme. Il campo era circondato da palloni frenati per limitare la visibilità e rendere difficile il sorvolo dei mezzi aerei. C’era quindi una barriera di grandi palloni a protezione delle terribili cose che accadevano all’interno del perimetro. I bombardieri più lenti si avvicinano in squadriglia mentre alcuni caccia più veloci e agili sfrecciano sopra di noi. Ricordo che uno passò tra i palloni volteggiando, inclinandosi di taglio per poi uscire fuori; non lontano da noi, almeno così mi apparve. Mi sembravano oggetti inanimati che si divertivano a ficcare il naso nelle nostre vite piegate dal dolore e dalla fatica. Mi facevo forza pensando che qualcuno aveva visto, poteva forse raccontare e magari intervenire senza far trascorrere altro tempo.» Aveva ragione il prigioniero, qualcuno aveva posato lo sguardo e, come avremo modo di notare più avanti, aveva fotografato, cominciando a documentare ciò che non si poteva più coprire o nascondere.
I raid dell’aviazione alleata si erano avvicinati al cuore della soluzione finale, anche il fumo delle camere a gas compare nelle fotografie di quel giorno. Ma affidiamoci ancora alle parole di Terracina, che azzarda un’ipotesi su quelle giornate di agosto di oltre settant’anni fa: «Non ho visto ma ho sentito molto bene ciò che avvenne in piena notte. Ho messo ordine nella mia memoria molti anni dopo, quando sono comparse le foto aeree riferite a quei giorni con tanto di didascalia “3 agosto 1944”. Le SS con i cani chiusero le baracche impedendo così di poter seguire almeno con lo sguardo ciò che avveniva al di là del filo spinato che divideva noi dal campo degli zingari. Loro erano in nuclei familiari, suonavano, erano allegri e convinti di farcela. Devo riconoscere che ero anche invidioso della dimensione collettiva che era sopravvissuta alla deportazione. Pieni di bambini che scorrazzavano davanti alle baracche. Sentimmo le urla, le bastonate, una grande confusione e poi da quella direzione solo un terribile e inconfondibile silenzio di morte». Erano stati annientati in poche ore, il fumo di agosto era l’ultimo segno di una terribile cancellazione; certo i piloti non potevano sapere. «E il giorno dopo gli aerei che portavano speranze. Era difficile credere ancora in qualcosa, ma mi aggrappavo a tutto. Quando sono uscito da lì ho pensato a quella notte e alla fine delle famiglie degli zingari, mi piace ancora immaginarli liberi per le vie del mondo a fare baccano con i loro strumenti.»
Da qui il peso di quell’interrogativo troppo pesante, insopportabile. Perché non bombardare gli impianti di messa a morte: le camere a gas, le fosse di cremazione o i forni crematori o almeno colpire le linee ferroviarie, i binari che da mezza Europa portavano vagoni colmi di vite umane verso destinazioni senza ritorno? A settant’anni dall’abbattimento dei cancelli di Auschwitz e dalla fine del secondo conflitto mondiale quella domanda rimane uno snodo cruciale, un crocevia per dare un senso a ciò che è seguito, per non commettere errori imperdonabili, per far sì che tutto non sia avvenuto invano. In fondo, la conoscenza del passato dovrebbe aiutarci ad acquisire coraggio e responsabilità anche nella ricerca più difficile attraverso le pagine dolorose, persino quelle più imbarazzanti. È a questo livello che la distinzione tra la storia e la memoria aiuta a definire un percorso, un quadro di riferimento utile perché complesso e articolato: il singolo racconto contribuisce a comporre un mosaico di itinerari e storie.
La guerra totale che coinvolge i cinque continenti, combattuta dall’aria, da terra, sui mari, non lascia soltanto una scia di morte e distruzioni ma porta con sé moniti e messaggi che si proiettano sui decenni e sulle generazioni successive. La guerra aerea è una componente decisiva della controffensiva alleata dopo i successi che le forze dell’Asse avevano collezionato nei primi anni del conflitto. Dalla lunga resistenza della battaglia d’Inghilterra tra l’estate e l’autunno del 1940, si va affermando una superiorità sui cieli d’Europa che diventa una carta in più, prima una garanzia e poi un’arma micidiale nelle strategie che conducono alla resa incondizionata. Perché allora non colpire anche quel luogo, quel simbolo di morte e distruzione? Perché non interrompere la catena dei comandi che aveva già ucciso milioni di ebrei nei territori passati sotto il controllo del Reich? Più ci allontaniamo dagli eventi e più sembra necessario guardarci dentro; la ricerca storica ha fatto passi da gigante consolidando dati, cifre, persino giudizi e interpretazioni. Non si può tacere né tantomeno girarsi dall’altra parte. L’atto d’accusa dei sopravvissuti è parte di una riflessione più ampia sulle responsabilità del dopo, sulla condotta della guerra e sulle scelte di fronte ai messaggi di morte che il nazismo coltiva fino all’ultimo istante.
Se il campo di osservazione si allarga uscendo dal perimetro del sistema Auschwitz (e dei tre campi che lo compongono) l’interrogativo diventa ancora più stringente, legato alle tracce dei percorsi dei treni sul territorio europeo. Come era possibile non accorgersi del passaggio di centinaia di migliaia di persone stipate nei vagoni? Quante stazioni hanno toccato? Quanti sguardi di passanti hanno incrociato gli occhi dei viaggiatori dalle feritoie o all’apertura degli sportelli?
La deportazione degli ebrei verso Auschwitz-Birkenau è gestita direttamente dall’ufficio di Adolf Eichmann, il IVB4 dell’Ufficio centrale di Sicurezza del Reich (RSHA). La procedura è precisa fino ai dettagli. In ogni paese occupato o alleato viene designato un consigliere, che ha il compito di spianare la strada dal punto di vista legislativo e burocratico per poi procedere all’individuazione, all’arresto, all’internamento e alla deportazione finale. Dopo le retate e la cattura di singoli o nuclei familiari, gli ebrei vengono confinati nella maggior parte dei casi in strutture di permanenza temporanea, luoghi di transito dove attendono di raggiungere un numero sufficiente per comporre un trasporto e quindi riempire un treno: Westerbork in Olanda, Malines/Mechelen in Belgio, Drancy in Francia, Fossoli in Italia. A partire dalla fase iniziale è prezioso l’aiuto di collaboratori in loco, soprattutto in Francia e in Italia, collaborazionisti o fascisti che ampliano e rafforzano il cono d’ombra della soluzione finale. Franz Novak, collaboratore di Eichmann, coordina i trasporti in accordo con le ferrovie tedesche (Reichsbahn): sono migliaia i ferrovieri e i poliziotti che scortano e vigilano sul buon esito degli spostamenti dei treni e sulla composizione dei convogli.
I numeri sono impressionanti. Circa 3 milioni di ebrei sono deportati verso i campi di sterminio dell’Est Europa con l’utilizzo di 1500 treni speciali, veri e propri convogli della morte composti da vagoni bestiame nei quali sono stipati i passeggeri con razioni di acqua e cibo a dir poco insufficienti. Il viaggio in condizioni spaventose è anche molto lungo, nel tragitto hanno precedenza i treni ordinari sui convogli speciali. Molti passeggeri muoiono prima dell’arrivo a destinazione. Chi si trova più vicino ai campi della morte viene trasportato su dei carri (dai ghetti dell’Alta Slesia); dalla Norvegia o dalle isole del Dodecaneso il viaggio ha inizio con una prima tratta su chiatte o imbarcazioni di vario genere. Le vittime, ignare, vengono ingannate con notizie false su fantomatici campi di lavoro e alloggi che li attendono. È l’inizio della fine, in una cronologia impietosa. Sono quasi 430mila gli ebrei ungheresi che da maggio 1944 vengono deportati verso la rampa di Birkenau; circa 300mila i polacchi (dal marzo 1942); 70mila dalla Francia, 60mila dall’Olanda (rispettivamente a partire da marzo e da luglio 1942); 53mila dalla Grecia (da marzo 1943); oltre 45mila da Boemia e Moravia (da ottobre 1942); 27mila dalla Slovacchia, 25mila dal Belgio, 23mila da Germania e Austria e 10mila dalla Iugoslavia (nell’ordine marzo, agosto, maggio, agosto 1942); 7000 dall’Italia (da ottobre 1943); 2000 dal Dodecaneso italiano (luglio 1944); 700 dalla Norvegia (da dicembre 1942) e 34mila da altri luoghi a partire dal maggio 1942.
Non è questione di numeri, si è detto e sostenuto per decenni. Purtroppo è vero solo in parte; la ricerca storica permette di ragionare di cifre e cronologie, di contesti e responsabilità. L’organizzazione pianificata dello sterminio prevede un apparato burocratico amministrativo che si muove all’interno del conflitto con modalità e procedure autonome. Per questo motivo numeri e date sono essenziali per definire un quadro di riferimento che dia conto dell’organizzazione messa in piedi dai carnefici e dell’estensione dell’universo delle vittime colpite. La Germania conquista territori annettendo o amministrando pezzi d’Europa e sul nuovo spazio vengono implementate le politiche legate alla costruzione dell’uomo nuovo, al dominio di una presunta razza sulle altre. Nei numeri dei trasporti per Auschwitz e nella cronologia che li contiene ci sono innanzitutto i destini individuali dei singoli, la distruzione di una parte significativa della popolazione europea ma anche il peso di ciò che non è stato fatto e forse si sarebbe potuto tentare. E tornano gli interrogativi del dopo e le aspettative di chi attende con trepidazione un intervento risolutivo o anche parziale. Fare qualcosa, dare un segno di speranza e possibilità: colpire le strutture dei campi dello sterminio o, almeno, tentare di interrompere il tracciato dei binari. Bloccare i viaggi, impedire che la grande fabbrica della morte di massa sviluppi tutte le sue potenzialità. Il bombardamento dal cielo si rivela una possibilità concreta solo nell’estate del 1944, quando i numeri sono già terribili, enormi, e quando l’andamento del conflitto lo avrebbe ancora consentito. Ma fino ad allora tutto sembra invece procedere come se i viaggi dei treni della morte fossero invisibili e inarrestabili.
Difficile trovare una simbologia più efficace del vagone e di ciò che racchiude (e nasconde) dentro uno spazio angusto, limitato, carico fino all’inverosimile di persone in moto verso la conclusione dei loro giorni. Basta uno sguardo alla mappa con cui si apre The Routledge Atlas of the Holocaust di Martin Gilbert (la prima edizione è del 1982): illustra le linee ferroviarie che conducono ad Auschwitz tra il marzo 1942 e il novembre 1944, una fitta trama di percorsi e di snodi ferroviari che convergono verso un unico punto, una ragnatela che copre buona parte del territorio del vecchio continente. Un lavoro fondamentale come quello di Raul Hilberg, vero e proprio spartiacque negli studi della Shoah (La distruzione degli ebrei d’Europa in prima edizione nel 1961, la traduzione italiana è del 1995), privilegia i trasporti come fonte basilare: il sistema di collegamento dei treni, gli orari, le liste dei passeggeri, le forme di registrazione e immatricolazione nelle stazioni di partenza, di transito, di arrivo. Una base scientifica fondamentale per poter definire la profondità, l’ampiezza e la dimensione del fenomeno delle deportazioni. La deposizione che lo stesso Eichmann propone al processo che lo vede come principale imputato nel procedimento apertosi a Gerusalemme nel 1961 quale organizzatore della macchina dello sterminio conferma la centralità dei trasporti, la loro dimensione e pianificazione, il peso che avevano nella soluzione finale.
Dietro numeri e nomi, nella burocrazia che registra liste di orari e spostamenti di convogli si consuma parte di una tragedia che è sembrata incredibile, indicibile e per un certo tempo non comprensibile. Non è più così. Oggi sappiamo molto, anche grazie allo studio delle minuziose fonti su spostamenti e trasporti verso il sistema concentrazionario nazista. Il treno ha un posto di rilievo nei principali musei o memoriali in giro per il mondo. Nella distesa del campo di Birkenau gli ultimi interventi di corredo alla visita hanno collocato due vagoni nelle zone di arrivo dei convogli: all’esterno nella Juden Rampe e all’interno nella grande rampa di arrivo modificata nel 1944 per accogliere i trasporti più numerosi. Il monumento alla deportazione nel museo Yad Vashem (inaugurato nel 2005) a Gerusalemme su progetto di Moshe Safdie è un’opera di grande impatto emotivo: un ponte ferroviario spezzato ha sopra di sé il vagone di un treno utilizzato per le deportazioni; a chi guarda sembra che il vagone lentamente stia scivolando verso il vuoto nel dirupo della collina, l’ultimo viaggio verso l’abisso. Di altro segno la ricostruzione delle biografie di un trasporto di ebrei francesi che caratterizza il percorso espositivo del museo di New York nei pressi di Battery Park alla punta meridionale di Manhattan o ancora il passaggio attraverso un vagone in uno spazio di rumori in movimento al museo dell’Olocausto di Washington. Anche il Binario 21 alla stazione di Milano è un luogo di memoria, l’ultima stazione prima del viaggio verso l’ignoto. E si potrebbe continuare con altri esempi. Il viaggio è la linea di confine tra la vita di prima e la tragedia del dopo, varcare quella linea significa entrare in un contesto di lacerazione, un punto di non ritorno che ha inizio con l’ingresso in un vagone pronto a muoversi dalla banchina.
La tempistica dell’itinerario è un altro segnale rilevante: gruppi consistenti, centinaia di persone – Terracina ricorda i 64 componenti del suo vagone – isolati dal contesto, ignorati da potenziali interlocutori: nessun contatto con i carretti o le biciclette che già da Fossoli passavano a pochi metri dal recinto del campo al di là della strada. Una realtà separata e incomunicante, che spesso nulla ha a che fare con gli sviluppi della guerra in corso. Mentre i raid dell’aviazione anglo-americana si spingono fino ai territori conquistati dai tedeschi sul fronte orientale del vecchio continente gli ingranaggi e gli uomini dello sterminio proseguono nella loro opera che mira a rendere l’Europa judenfrei, libera dagli ebrei e dalle loro tradizioni. È il caso dell’isola di Rodi, diventata italiana dalla guerra di Libia del 1911-1912 e passata sotto il controllo nazista dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Da quel porto ha inizio il viaggio più lungo nell’universo della deportazione, una storia che racchiude il paradigma più terribile della Shoah. Sami Modiano aveva quattordici anni, parla di quel viaggio con sofferenza, ha perso tutti, la sua famiglia e la comunità ebraica di Rodi: una storia secolare (le radici risalgono al XVI secolo) che s’interrompe bruscamente.
«Voglio fare un piccolo passo indietro. Ero tra i primi della classe, tra i più bravi, benvoluto dall’insegnante che non teneva conto della religione. Che fossi ebreo non importava a nessuno, almeno fino a quel giorno del 1938. Avevo otto anni e mezzo. L’anno scolastico era appena iniziato quando una mattina il maestro mi chiamò. Ero contento, mi ero preparato all’interrogazione, convinto che mi avessero chiamato per questo. Invece il maestro mi disse che ero stato espulso, cacciato dalla scuola. Non capii, rimasi senza parole. Mi mise una mano sulla testa dicendomi che mio padre mi avrebbe spiegato i motivi dell’espulsione. Ricordo come fosse oggi la mano sul capo, il tentativo di rassicurarmi e la successiva conversazione con mio padre che mi parlò di Mussolini e dell’esistenza di una razza ebraica di cui facevamo parte. Ero troppo piccolo per capire, provai a consolarmi così. Ma il dispiacere era enorme. Fino a quel momento ero contento, libero, sereno. Non mi sentivo diverso dagli altri bambini, dai miei amici. Ora era finita l’infanzia. Quel giorno ho perso la mia innocenza. Quella mattina mi ero svegliato come un bambino. La sera mi addormentai come un ebreo. Mio padre cercava di spiegarmi cosa significasse essere ebrei. Difficile per un bambino poter comprendere. È un mondo che se n’è andato in fretta, eravamo migliaia e l’isola era un luogo fantastico. Eravamo ospitali e solidali. In pochi metri vivevano ebrei, musulmani e cristiani. Si parlava ladino (la nostra lingua), turco, italiano e greco. Se penso al paradiso non riesco a trovare un’immagine migliore.»
Il 18 luglio 1944 i capifamiglia vengono arrestati dai tedeschi con il pretesto di un controllo documenti e rinchiusi nella Kommandantur, già caserma dell’aeronautica militare italiana; è la prima tappa del terribile percorso che li condurrà alla rampa di Birkenau. All’alba del 23 luglio 1944 ha inizio il lungo viaggio verso la fine. I numeri sono incerti, mancano riferimenti anagrafici e ricostruzioni attendibili. Dopo un breve tratto di strada fino al porto, circa duemila persone vengono stipate in quattro o cinque chiatte adibite al trasporto animali. Un viaggio per molti insopportabile. Una prima sosta all’isola di Kos per imbarcare altri nuclei familiari, poi rotta verso il Pireo.
«Tutto era finito in così poco tempo. Capimmo subito che il viaggio era una marcia d’avvicinamento verso l’inferno: il caldo, gli odori, i bisogni e i primi cadaveri che ho visto. Chi non ce la faceva finiva in mare.»
Ad Atene il trasferimento su un treno, per molti un mezzo ancora sconosciuto e misterioso, una scoperta imprevista. L’arrivo ad Auschwitz il 16 agosto. E il bilancio di quelle settimane è impressionante nel quadro degli avvenimenti del conflitto in corso. Un mese di tempo per attraversare l’Europa nel vivo della fase decisiva dell’offensiva alleata al cuore del Te...