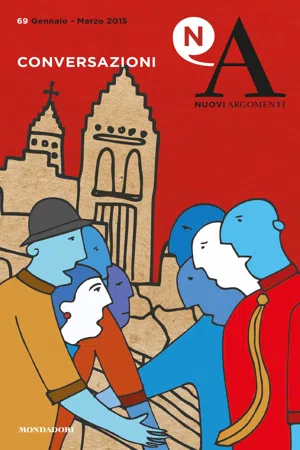
- 224 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Nuovi Argomenti (69)
Informazioni su questo libro
Hanno collaborato: Leonardo Colombati, Tommaso Giartosio, Benedetta Craveri, Chiara Valerio, Amedeo Quondam, Dacia Maraini, Björn Larsson, Flavio Santi, Peter Zilahy, Paolo Di Paolo, Mario Martone, Giorgio Zanchini, Shamus Rahman Khan, John Ashbery, Adam Fitzgerald, Daniele Giglioli, Davide Orecchio, Attilio Scarpellini, Giuliano Scabia, Lorenzo Pavolini, Petros Markaris, Mario Benedetti, Alice Oswald, Francesco Terzago, Paolo Pecere, Enrico Macioci, Giovanni Francesio, Andrea Nani, Matteo Gagliardi.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a Nuovi Argomenti (69) di AA.VV. in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788804654278eBook ISBN
9788852062704CONVERSAZIONI
UN’ARTE DIVENTATA NATURA
Tommaso Giartosio / Benedetta Craveri
Per questo viaggio attorno alla conversazione allestito da Nuovi Argomenti abbiamo pensato che fosse necessario riflettere prima di tutto sulle origini della forma-conversazione. Non potevamo farlo senza il tuo aiuto, visto che il tema attraversa tutto il tuo lavoro di francesista e storica della cultura, e in particolare si condensa in quel libro esemplare che è La civiltà della conversazione (Adelphi 2001). Per non parlare delle tantissime interviste a scrittori e intellettuali che hai condotto per Repubblica. Ma proprio oggi che ci incontriamo, poche ore fa, c’è stata la strage di Parigi. Perciò voglio chiederti per prima cosa: ha senso riflettere sulla funzione della conversazione civile proprio ora che la stagione del dialogo secondo alcuni (benché io non sia fra questi) è definitivamente finita? E per giunta proprio in Francia, con francesi che uccidono altri francesi…
Una volta mi è capitato di venire invitata in Colombia in occasione della traduzione del libro che hai citato. A Bogotà l’albergo era piantonato per proteggere i clienti dai narcotrafficanti. La mia lezione all’università era stata cancellata perché avevano messo una bomba. Così sono andata in televisione, e il giornalista colto e brillante che mi intervistava mi ha detto: «Guardi, per noi il suo libro è molto importante. Nella nostra situazione il semplice conversare, questo patto tra persone che resistono alla violenza, è una forma di pacificazione». Del resto la prima riflessione sistematica moderna sul tema nasce proprio in un’Italia quasi completamente alla mercé delle potenze straniere: alla fine del Quattrocento, a Napoli, dopo l’invasione di Carlo VIII. È il De Sermone di Giovanni Pontano. «In questa catastrofe» dice in sostanza Pontano «bisogna ritirarsi a vita privata e dedicarsi alla civil conversazione, che è una fonte di rigenerazione morale e psicologica». La civiltà è una cosa straordinariamente fragile, che può essere rimessa continuamente in discussione. Croce dice che è un fiore che cresce in un anfratto di roccia dove si è posato per caso un pochino di terra e un seme. Basta un colpo di vento per metterla in pericolo. È necessario difenderla ma, come si vede in questi giorni, non tutti sono d’accordo sul come.
Croce, tuo nonno: forse riusciremo a dire qualcosa anche della tua famiglia, i Craveri-Croce-Cecchi-D’Amico (e Carandini, Albertini, Giacosa…), così “conversante”, e così importante nella storia della cultura italiana. Ma torniamo appunto all’Italia. L’arte della conversazione viene teorizzata da noi, ma raggiunge la massima fioritura in Francia.
Il fatto è che nel Cortegiano la conversazione si svolge ancora all’interno di una corte, quella tardo-rinascimentale di Urbino, e ne rispetta la gerarchia e il cerimoniale. È in funzione del principe (anche se lui in realtà non c’è, e tutto si svolge negli appartamenti della duchessa). Il cortigiano emula il principe; si confronta con lui; colloquia con lui; forse lo ispira. La conversazione qui è l’ultimo fiore della civiltà di corte italiana, che a quell’epoca, in fondo, è già diventata un’utopia. Ma quando questo modello trasmigra in Francia, all’inizio del Seicento, la conversazione rinasce come presa di distanza dalla corte. La stessa alta nobiltà che a corte detiene le grandi cariche di cui va fiera, si ritaglia poi uno spazio privato nei propri palazzi per celebrare, conversando, non più il sovrano ma soltanto se stessa. Si coopta, si sceglie.
Quello che mi chiedo è se ciò fa del salotto un luogo di contropotere, di controinformazione, in cui prende forma l’idea stessa di opinione pubblica.
Nel Settecento certamente sì. Anzi, molti vedono nell’opinione pubblica che, orchestrata dai philosophes, prende forma nei salotti, nelle accademie, nei luoghi di ritrovo, la causa di fondo della rivoluzione francese. La parola scritta è allora ancora soggetta alla censura ma quella parlata è difficilmente controllabile. Nel Seicento siamo ancora all’inizio di questo processo; però si può chiamare “opinione pubblica” il consenso che si crea attorno al sentimento di resistenza alla monarchia assoluta. Per esempio le simpatie che sottendono alla Fronda, o le grandi polemiche come quella sul giansenismo: una questione squisitamente teologica, e nemmeno tanto appassionante, che in Francia, grazie alla forza persuasiva di “comunicatori” straordinari come Arnauld e Pascal, diventa una forma di opposizione all’autorità regia. C’è un giovane studioso che sta lavorando sull’orazione a Port-Royal: sostiene che i direttori di coscienza delle monache insegnavano loro una modalità di preghiera basata su un rapporto di obbedienza e sudditanza a Dio strutturalmente analogo a quello illustrato dai teorici dell’assolutismo regio... Nel Seicento, tuttavia, la conversazione è ancora essenzialmente ludica: un loisir. Solo con l’Illuminismo diventa una pratica che consente la libera circolazione delle idee, anche le più proibite.
Ma la conversazione già nel Seicento è collegata a un’esperienza di esclusione dal potere. Come tu spieghi nella Civiltà, se l’aristocrazia non fosse stata in qualche misura depotenziata dall’assolutismo non si sarebbe trovata costretta a reinventarsi una identità condivisa, centrata sui valori della conversazione: la politesse, l’esprit, la galanterie... E questa elaborazione fa sì che i salotti siano anche un luogo di mobilità sociale, per quanto limitata. Uno spazio dinamico, autre.
Calma, calma. Tieni presente prima di tutto che la civiltà della conversazione nasce grazie a alcune caratteristiche ben precise della società francese. C’è per esempio un’élite estremamente “centralizzata” tra Parigi e Versailles (mentre in Inghilterra la gentry continua risiedere in campagna, e in Italia e in Germania ci sono una pluralità di corti). E poi c’è la presenza dominante delle donne (aristocratiche), perfettamente integrate nel mondo maschile. Del resto questa è una caratteristica della nobiltà francese fin dal medioevo cortese: la donna, l’elemento più fragile della scala sociale, viene posta su un altare, diviene la piuma più bella da mettere sul cimiero di un cavaliere…
Questa non è parità.
Certo che non è parità. Risponde a un’esigenza maschile: distinguere la nobiltà dalla borghesia per cui la donna è madre e moglie. E comunque è una condizione di favore sancita dall’uso, non dalla legge. Sul piano giuridico, in Francia (come nel resto d’Europa) la donna è totalmente assoggettata all’autorità maschile: un’eterna “minore” da tenere sotto controllo.
E per quanto riguarda, appunto, l’”uso”?
Nei paesi della Controriforma – l’Italia, la Spagna – le donne sono strettamente vigilate. Nei paesi protestanti come l’Inghilterra vige la separazione dei sessi. Ma in Francia la donna detiene prestigio e autonomia in virtù del codice d’onore aristocratico: quindi ne diventa l’interprete più intransigente. È lei a fissare il protocollo delle buone maniere, a stabilire le regole della vita sociale, e soprattutto a decidere dei loisirs, del “tempo libero”. A differenza del Terzo stato, la nobiltà non lavora, non produce, si limita a fare la guerra. La donna trasforma l’ozio aristocratico in un’impresa artistica. “Fa” i gentiluomini, e per meglio educarli e divertirli coopta gli intellettuali. Ogni salotto ha al suo centro una donna e una vedette intellettuale e, come rito centrale, la conversazione. Ma perché questa possa funzionare bisogna – sia pure per un momento – dimenticare le disparità sociali (uomini e donne, nobili e non nobili), stabilire un rapporto di assoluta parità: non puoi giocare a tennis se un giocatore ha un braccio legato.
È una pura finzione.
Il salotto è un luogo utopico, perché quella libertà vale solo entro quei confini. Ma nel momento in cui questa società aristocratica femminile mette in rilievo qualità che non sono legate esclusivamente alla nascita, come l’intelligenza, il brio, la cultura, la galanteria, si ha una forma – se non di mobilità – di promozione sociale. E tieni presente che questa forma di socievolezza aristocratica diventa, a partire dalla fine del Seicento, un tratto distintivo del carattere nazionale francese e un modello per l’Europa intera.
La necessità di questa accoppiata donna-intellettuale (lo dico per capirci, perché è chiaro che queste dame sono anche loro degli intellettuali!) nasce dall’idea che la donna sia portatrice di un sapere intrinseco, spontaneo, naturel. Un po’ come in quella metafora delle api e dei ragni studiata da Marc Fumaroli: le api (gli intellettuali) che da una moltitudine di fiori ottengono miele e cera, i ragni (le donne) che producono il filo traendolo da se stessi…
Sai, tutta l’aristocrazia francese si vuole autodidatta. Rifiuta la scuola, lo studio, l’erudizione. La paideia umanistica viene assimilata per via indiretta, attraverso i “luoghi comuni” - nel senso originario del termine – trasmessi dalla poesia e da romanzi come L’Astrée. Se bisogna conoscere la storia nazionale, è perché in una società gerarchica è cruciale saper identificare gli interlocutori – la loro posizione, la loro storia famigliare e politica. Le donne però sono completamente tagliate fuori dall’istruzione. Sono in molte a denunciarlo, da Christine de Pizan in poi. Anche Madame d’Épinay in una lettera al nostro abate Galiani lamenta la propria ignoranza. Le era stato insegnato tutto ciò che poteva renderla gradevole da giovane – eleganza, garbo, portamento, danza – trascurando quanto l’avrebbe aiutata a bastare a se stessa, ad essere libera e indipendente, e a consolarsi delle ingiustizie della sorte.
Però la donna in Francia diventa forte delle sue debolezze.
L’esclusione dagli studi fa sì che il francese imparato negli appartamenti materni sia esente dalle volgarità dell’eloquio popolare ma anche dal tecnicismo dei dotti. Per registrare l’uso più puro della lingua, Vauvenargues e gli autori del Dizionario dell’Académie vanno a cercarlo nei salotti delle donne. E la conversazione è anche un luogo di formazione culturale e letteraria. Ma non bisogna dimenticare che il naturel, a cui tu accennavi, non è affatto sinonimo di spontaneità ma è l’equivalente della “sprezzatura” del Cortegiano: un’arte diventata seconda natura. Poi purtroppo la Rivoluzione – che è essenzialmente misogina, fedele all’insegnamento di Jean-Jacques Rousseau – spazza via tutto questo. Chiude i club femminili e si macchia di violenze e omicidi ai danni delle sue stesse eroine, da Madame Roland a Olympe de Gouges a Théroigne de Méricourt. La donna viene respinta nella sfera domestica, dove ottiene rispetto solo in quanto madre di un futuro cittadino.
Qual è stato il tuo rapporto con il femminismo? L’avrai incontrato spesso, affrontando questi temi.
Io ho un netto preconcetto a favore delle donne. Le trovo, in genere, assai più interessanti degli uomini. Però non sono mai stata una femminista militante e non ho una formazione di gender studies… ma i metodi valgono per l’intelligenza di chi li sa usare. Tra gli studi con un’impostazione ideologica femminista, ce ne sono di eccellenti, come di veramente imbecilli; ma anche nella scuola degli Annales ci sono Bloch e Braudel e c’è anche chi con altrettanto rigore metodologico conta quanti pidocchi avevano le parrucche di Luigi XIV. Certo la griglia femminista, centrata sulla reale e durissima subordinazione della donna nel corso dei secoli, non funziona tanto, almeno a mio giudizio, applicata alla civiltà aristocratica d’Antico Regime – che era basata sulla complicità tra uomini e donne.
Con l’Illuminismo si passa a una fase ulteriore.
Gli intellettuali smettono di essere degli intrattenitori subalterni come Voiture e diventano dei maîtres à penser come Voltaire. E nasce una straordinaria collaborazione tra i mondani e gli intellettuali: i primi si dimostrano disponibili all’ascolto e curiosi di tutto, e i letterati acquistano l’eleganza, la disinvoltura e il giusto tono per accattivare il pubblico. Così si assicurano una protezione a corte, più che mai necessaria nella lotta per le riforme.
Però mi sembra che la conversazione cambi in modo così radicale! C’è sempre la brillantezza, d’accordo, però ora c’è anche un enjeu, una posta in gioco di verità: una mina che alla lunga saboterà quei delicati equilibri. Per esempio se si segue Diderot dal Sogno di D’Alembert al Nipote di Rameau al Jacques, si nota che il dialogo esplode: alla fine si frantuma, diventa un pulviscolo di frasi che si ripetono e si agglomerano.
Ma già nel Sogno di D’Alembert la conversazione va oltre le regole prescritte dalle buone maniere, dalle bienséances! Uno dei personaggi, Julie de L’Espinasse – nota perché sveniva al solo sentire un’espressione vagamente triviale come “un altro paio di maniche” – inorridisce quando incomincia a sentire parlare di temi come l’onanismo, ma poi si lascia coinvolgere. E alla fine osa, osa fare delle domande che sarebbero state inconcepibili in qualsiasi conversazione mondana. Del resto quella di Diderot, secondo Marmontel, era un vero spettacolo…
In una lettera dichiara: «Non voglio mai più starmene a leggere da solo, preferisco conversare…»
Sì, e spiega che la conversazione lo aiuta a pensare, ad avere delle idee. È per sua natura una maieutica. Ma questo aspetto c’era già nel cavaliere di Méré, cent’anni prima. In un bellissimo dialogo, l’interlocutore di Méré gli confessa che parlando con lui si sente più intelligente: pensa e dice cose che non aveva mai pensato prima! Non a caso Méré teorizza la necessità di studiare il proprio interlocutore, penetrarne la psicologia e i pensieri più reconditi. È un modo per mettersi in sintonia con l’altro, ma anche per conquistarlo. La conversazione è anche una strategia egemonica. L’analisi più feroce di questa società mondana la fa quell’anti-aristocratico, anti-assolutista, e vero castigamatti di Rousseau nella Nouvelle Héloïse. Saint-Preux descrive a Julie i salotti parigini in cui tutti parlano e conversano, gentilissimi, amabili, squisiti – e dice: «Ma tutto questo a cosa serve, mia Julie?» È solo una forma mascherata di volontà di dominio… Come ha scritto Starobinski, la società aristocratica usa le buone maniere come una scherma, per conquistare e sedurre con la grazia e con l’abilità della parola anziché con la forza delle armi; è una società profondamente narcisistica.
Che verrà travolta dalla rivoluzione. Secondo Fumaroli la retorica politica giacobina è una corruzione della conversazione classica. Ma non potrebbe esserci – non dico nei giacobini, ma in generale nella dialettica politica post-rivoluzionaria, parlamentare, civile – una declinazione democratica della civil conversazione?
La Rivoluzione rompe completamente con il codice aristocratico delle bienséances: un esempio minimo è che, sotto il Terrore, il “tu” è d’obbligo. Madame de Staël, come Hume prima di lei, avevano visto nella cortesia e nel rispetto dell’amor proprio altrui, così praticati in seno all’élite, un modo di smussare ed addolcire le differenze sociali – e farle durare. Così dopo la Rivoluzione la conversazione diventa il simbolo di una civiltà conclusa per sempre, un “luogo di memoria”, un rito con cui si afferma la fedeltà al proprio passato.
Un esempio di questa nostalgia è appunto la de Staël, quando dice che per i francesi la conversazione è più musica che comunicazione?
È vero, Madame de Staël sostiene che per loro è come per altri popoli l’uso dei liquori forti: una necessità. E lo è anche per lei, che la orchestra in maniera eccelsa. Però la sua è già una conversazione filosofica, politica, impegnata, mentre una delle caratteristiche della conversazione aristocratica d’An...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- DIARIO - Leonardo Colombati
- CONVERSAZIONI
- POESIE
- SCRITTURE
- REPORTAGE
- Copyright