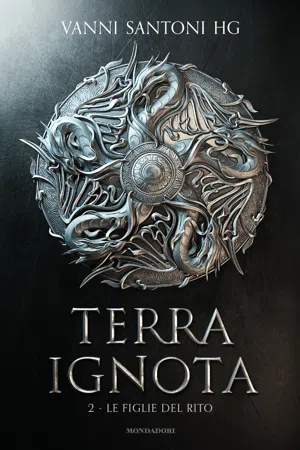![]()
![]()
E venne il giorno in cui giunse a palazzo sir Puil della dozzina di Tristram, e con lui la notizia della fine del cavaliere del Giglio. Negli ultimi tempi H.H. aveva ripreso a visitare le stanze particolari di Vevisa ogni notte, ma quella volta non lo fece: pur non dispiacendole il fatto in sé, ciò la preoccupava, dato che dall’affezione del Gran Maestro dipendeva comunque la sua vita. Poteva scommettere che, trovandosi rinnegata, a palazzo avrebbero continuato a darle rispetto e considerazione? Di certo non avrebbe mantenuto la sua posizione di prominenza, ma visto il modo che aveva il Cerchio d’Acciaio di gestire anche i problemi minori, la cosa più probabile era che l’avrebbero passata a fil di spada e gettata in una fossa comune.
La mancata visita di H.H. era certamente un mero segno della tensione per la perdita di un membro del Cerchio Interno, di nuovo per mano delle Figlie del Rito, e tuttavia vederlo ricomparire il giorno successivo la rallegrò al punto che gli si concesse riuscendo quasi a fingere trasporto.
— Siete preoccupato, mio signore? — azzardò Vevisa quella notte, riuscendo addirittura a guardare con dolcezza quel volto cereo.
— Preoccupato? Il Gran Maestro del Cerchio d’Acciaio non può essere preoccupato. Il Gran Maestro agisce. Il Gran Maestro reagisce — disse H.H., e per un attimo si intravide il suo vero, scarnificato aspetto.
— E come intendete reagire?
— Con la repressione.
— Se mai andrà in porto...
— Cosa vorresti dire?
— Vorrei dire, mio signore, che la caccia alle nostre nemiche potrebbe essere lunga e laboriosa. Mentre la notizia della morte di Tristram del Giglio si starà già spargendo tra il popolo. Sappiamo bene con quale abilità e solerzia la Strega dell’Ovest riesce a far circolare notizie che ci danneggiano.
— E a ottenere notizie su di noi. Non importa quante esecuzioni io ordini, sembra avere sempre ancora una spia in serbo.
— Una spia, od occhi.
— Cosa intendi dire?
— Avete notato che spesso i prigionieri hanno al collo un ninnolo, un piccolo ciondolo azzurro...
— Sì, li abbiamo interrogati anche su quello, rappresenta la protezione della Strega...
— ... dell’Ovest, sì. E tuttavia è fatto di pietravetro di Despina.
— Despina delle Cinquantaquattro Città? È sotto il nostro pieno controllo, non arriva niente da lì nelle Terre Franche.
— Non adesso magari, ma sarebbe sufficiente avere un blocco per produrre chissà quanti di quei ninnoli...
— Dunque?
— Dunque ho avuto modo di leggere in certi testi giunti proprio da quelle lande che tramite quel materiale cristallino venivano messi in atto potenti incantesimi di visione remota.
H.H. ristette, lì disteso; considerò il soffitto.
— Non sei sciocca.
— Grazie, mio signore.
— Per fortuna avevamo già dato ordine di distruggere sempre e in ogni caso qualunque cosa rimandasse all’Alleanza Ribelle o alla sua strega. Ma questa tua intuizione impone ulteriore prudenza.
— A volte prudenza è azione.
— Cosa intendi dire?
— Intendo dire che serve un segno di fermezza. Al funerale di Åydric Reinhare, che l’Imperatrice lo abbia in gloria...
— Risparmiami questa pantomima. Non dimentico certo che lo odiavi.
— Mi attenevo unicamente all’etichetta. Se ben ricordate anche Tristram del Giglio faceva parte della truppa che uccise mio padre. Ma adesso le uniche cose che mi preoccupano sono gli effetti della notizia della sua morte, e le informazioni che la Strega dell’Ovest potrebbe avergli estorto prima di ucciderlo.
— Uhm. Vai avanti.
— Al funerale di Åydric Reinhare, che l’Imperatrice lo abbia in gloria, avete giustamente mostrato l’integrità del Cerchio Interno con sei nuove investiture. Allo stesso modo dovete agire adesso. Si mostri prontamente al popolo, e ai nostri nemici, che il Cerchio è come una fiamma che non si estingue, un ciclo che non conosce sosta, e che per ogni uomo o donna che gli si toglie, un altro, un’altra, sorge in armi per colpire come fulmine gli infami e i traditori.
— Sì... In effetti sì, nuovamente non hai torto, ma chi alzare? Un tempo le investiture erano processo lento, lentissimo... Già con quanto fatto tre anni fa in occasione dei funerali di Åydric Reinhare abbiamo rotto qualunque tradizione, e va detto anche che Gérier e Bérengier non erano del tutto, a mio avviso, meritevoli...
— Be’...
— Hai un nome? Se intendi dire che hai un nome di cui io non mi sarei accorto, fallo.
Vevisa guardò negli occhi H.H. e sorrise appena.
— Tu? — Il Gran Maestro piegò indietro il capo in una risata, facendo vibrare il suo collo, che si manifestò per com’era, piagato e martoriato al punto che vi si potevano intravedere, tese e biancastre, le corde vocali.
— Parlo seriamente. Le mie arti magiche...
— Vevisa. Per diventare membri del Cerchio Interno è necessario anzitutto essere cavalieri del Cerchio d’Acciaio. E per diventare cavalieri del Cerchio d’Acciaio occorre avere requisiti anzitutto marziali.
— Mio signore — si alzò seduta sul letto Vevisa — converrete che oggi i membri del Cerchio Interno svolgono un ruolo per lo più politico.
— Non solo politico. I Maestri sono anzitutto condottieri. E non c’è dozzina di cavalieri che seguirebbe una ragazzina che non sa tenere in mano una spada.
— Potrei...
— Non scherziamo. Adesso dormi. Devo recarmi nuovamente alla Sala dello Scacchiere, presto rientrerà Yvain dalla campagna di Mlå.
![]()
La misura è colma, pensava Vevisa mentre il Gran Maestro sbatteva la porta dietro di sé, e lei chiamava le serve per farsi lavare. La misura è colma e il tempo rimasto, poco.
Quella notte non dormì: si recò nel Luogo Più Sacro, il fiato sospeso per il timore di potervi trovare H.H., prese la Coppa e se la mise al collo. Poi girò per il Palazzo-Cattedrale, come in preda a un delirio febbrile, cercando la voce, cercando la voce, chiamando piano, e anche forte, girando come allucinata per i corridoi, il nome di Nin.
La trovò che albeggiava, in una stanza d’angolo della biblioteca dove la prima luce entrava da una feritoia coperta da un vetro opaco, facendo ballare lo spesso pulviscolo e formando un rombo soffuso sulla pietra consumata da mille e mille passaggi.
— Ciao ciao Vevi Vevisa — disse la voce.
— Ciao, Nin — disse piano, con affetto, Vevisa. Ormai avevano imparato a dialogare.
— Presto.
— Sì è presto. Hai visto, sta uscendo il sole.
— Sole. Ciao Vevisa.
— Ciao...
— Io sono Nin.
— Sì, tu sei Nin.
Ogni giorno ricominciavano il dialogo, e ogni giorno, ripassando prima quasi tutte le frasi, riusciva a insegnarle una parola, un concetto e a volte un’intera frase in più. Aveva anche imparato a localizzarla: per quanto eterea, dal volume e dalla posizione della voce poteva capire dove stava, avvicinarsi a lei o invitarla ad avvicinarsi volgendosi nella direzione giusta.
— Nin e Vevisa.
— Sì, Nin e Vevisa. Noi siamo amiche, sai? — disse Vevisa, e tirò fuori dal corsetto un gessetto rosso, che aveva preparato lei stessa con gesso di Dunvic, cenere di biancospino e sangue mestruale. Non le piaceva quanto stava per fare. Ma che scelte aveva?
— Amiche.
— Sì, amiche. — Vevisa continuava a parlare, a far parlare Nin, e intanto completava, lì sull’antica pietra di quell’esagono di biblioteca, un cerchio magico contornato di rune e contenente un pentagramma. Un sigillo completo.
— Vieni qui Nin.
— Qui — disse Nin, e la sentiva vicina. Percepiva addirittura una lievissima sensazione al volto. Erano davvero carezze? Carezze eteree.
— Brava Nin, hai imparato tante cose, sai?
— Tante cose...
— Sei davvero brava — disse ancora Vevisa. Tirò fuori la giara di Soma e bevve in un gotto tutto quello che c’era rimasto in fondo. Controllò a malapena il ritorno di fiamma della shakti che si diffondeva nel suo corpo e fece un passo appena indietro, fino a entrare nel sigillo a pentagramma. Nin, come ormai si era abituata a fare, la seguì, standole vicina. Vevisa si tolse la Coppa dal collo, la appoggiò a terra e pronunciò la formula
con la voce mezza distorta dal brivido travolgente della shakti, e prima ancora che Nin potesse provare a ripetere quelle strane parole che la sua amica le proponeva adesso, l’incantesimo si innescò. Una luce intensa partì dalla Coppa e innervò il sigillo; dal suo limite esterno, dal cerchio che inscriveva il pentagramma, cominciarono a uscire luce e rune: un cilindro di luce pallida intessuta di rune che prima le circondò entrambe – adesso, avvolte da quella luce, Vevisa poteva intravedere la sagoma, una silhouette lattea, appena tratteggiata, della Figlia dell’Etere, la curva della sua fronte, la forma del suo naso, delle sue guance, del suo mento, il corpo esile, ancora da adolescente – e poi, diventando via via sempre più intensa, si curvò su di loro formando una bolla.
— Male — disse Nin.
Contavano la rapidità e la sorpresa. E le aveva. Contavano le condizioni fisiche e mentali delle due parti, e Nin era per certi versi ancora una mezza coscienza. Contava l’ammontare di shakti, ma se Nin le era superiore, non lo era così tanto in quel breve momento in cui era pervasa dal potere del Soma; contavano infine l’aggressività e la volontà, così Vevisa si concentrò sulla spaesata Nin e riversò addosso a quella creatura che ancora non aveva sviluppato piena consapevolezza del mondo e solo ora, presa in un inganno d’affetto, cominciava ad aprirsi a esso, tutta la propria volontà di potenza.
Non osò neanche azzardare un “mi spiace”: non osò farlo neanche nel pensiero, perché ogni sua energia psichica doveva piegarsi a reggere l’impatto con una coscienza divina, per quanto monca e in embrione. La bolla aderì sempre più a entrambe, spingendole una sull’altra, tanto che la silhouette lattea di Nin andò penetrando, sovrapponendosi, a Vevisa. Vevisa gridò. Nin pure lanciava un grido sottile, quasi impercettibile alle orecchie umane ma continuo, acuto e straziante, che faceva vibrare il vetro della feritoia.
Vevisa sanguinò da tutto il corpo ed ebbe una serie di piccoli spasmi, che potevano apparire contenuti, ma erano sotto ogni punto di vista laceranti, tanto sul corpo quanto sulla mente e sull’anima, al punto che a ognuno le sembrava che il suo ego si frantumasse e disperdesse. Si aggrappò disperatamente alla coda, all’eco, di coscienza che le rimaneva, mentre una vasta e diversa percezione di ogni cosa la riempiva con tale forza da minacciarne per sempre la sanità mentale.
Gli spasmi si intensificarono in frequenza fino a diventare uno solo, lancinante. Per un attimo si sentì perduta, mille voci di Nin echeggiavano ovunque e la sua coscienza era sparsa, diffusa, come un lago luccicante e però fuori controllo che poteva abbracciare forse il mondo, ma di certo aveva perduto ogni radicola rispetto al suo corpo e al suo sé. Nella luce, come sparse, eteree formelle, scene della sua vita e di quelle di chiunque altro, bolle di coscienza che apparivano e scomparivano e si ibridavano l’una nell’altra.
Io sono, cercò di pensare. Io sono Vevisa, cercò di ripetere. Io sono io. Io sono Vevisa. Si aggrappava alla memoria, Vevisa, alla percezione, al concetto di sé. Provò a ripetersi almeno il titolo, almeno il titolo della summa filosofica di Sung, ma era impossibile. Io sono Vevisa, ricominciò. Io penso questo e quindi sono io. Strinse la conchiglia. Io sono io, ripeté ancora.
Sentì un puzzo acido. Sentì bagnato. Si toccò, lenta, il petto, e capì che si era vomitata addosso. Capì di essere stesa a terra. Sentì caldo. Epistassi. Vide il sangue sulle punte delle dita (erano le sue dita)? Io sono Vevisa. Percezione e incoscienza, sogno e Sogno, memoria e desiderio pian piano si dirimevano. La luce si fece più tenue. Il soffitto era una vertigine di libri. Lontano, un ronzio.
Lente e scintillanti, minuscole stille di coscienza le ricomparivano dentro, si coagulavano in grani.
— Io sono Vevisa — disse, senza capire se le parole uscivano effettivamente dalla sua bocca.
— Io. Sono. Vevisa — ripeté. Si tirò su a sedere ma la nausea era troppo forte.
— Io sono Vevisa — disse ancora da stesa. Respirò profondamente, una, due, tre volte. Il ronzio andò disperdendosi, come scomparendo alla distanza. Nel suo piano visuale le cose iniziarono a riprendere la loro corretta prospettiva. Si mise a sedere. Trattenne il vomito.
— Io sono Vevisa — disse, e aiutandosi con gli scaffali della biblioteca si tirò su in piedi. Ansimò.
— Io sono Vevisa.
— Io sono Nin... — disse una voce dentro di lei. Vevisa sgranò gli occhi. Raccolse la Coppa da terra.
— Io sono Nin — disse ancora la voce. Vevisa si mise la Coppa al collo. Inspirò.
— SILENZIO! — gridò Vevisa. — TU ADESSO, TU ADESSO SEI MIA. TU SEI ME, E IO SONO IO. NON ESISTE NIN. ESISTE SOLO VEVISA PADRONA-DEGLI-INTERSTIZI, FIGLIA DEL RITO, INCARNAZIONE E SIGNORA DELL’ETERE.
La voce dentro di lei tacque.
![]()
Il giorno successivo, la principale preoccupazione di Vevisa fu di non rivelare il potere che aveva acquisito. Si diede malata, e del resto le sue condizioni fisiche dopo l’incanalamento non erano delle migliori. Era esausta, anche più pallida del solito, e l’impegno richiesto dallo stare costantemente concentrata nell’obliterare dentro di sé ogni residuo della coscienza di Nin era altresì soverchiante. Tutto questo era tuttavia in controtendenza con il nuovo aspetto, emaciato certo, ma...