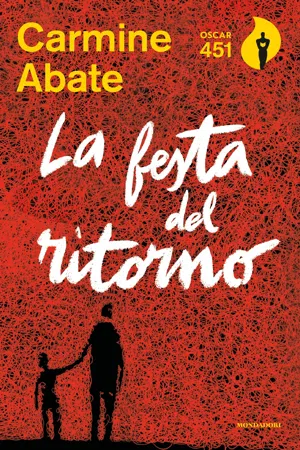![]()
![]()
Confesso che non mi ero accorto di nulla – disse mio padre piano e diede le spalle al fuoco perché lo ascoltassi solo io. – Lavoravo nove, dieci mesi come un mulo, a testa abbassata. Non guardavo né avanti né indietro, ma giù la terra, e ne ingoiavo la polvere. Ammetto pure che si guadagnava bene, però la schiena, di sera, la sentivi scatrejàta e io mi buttavo sulla branda stanco morto: il tempo di pensare a voi che crescevate senza di me, il tempo di un rimpianto a faccia in giù sul mio cuscino, per non farmi vedere dagli altri, e con la bocca amara di fumo mi addormentavo.
Il giorno dopo, al cantiere stradale. Chilometri e chilometri di asfalto. Che a srotolarli in direzione sud, fantasticavo io, sarei arrivato in paese, avrei riabbracciato la mia famiglia, compresa Spertina, e non sarei più partito. Per anni, dico, anni e anni...
Nel frattempo mi contentavo di tornare da voi per le ferie e mi sembrava che tutto era a posto come l’avevo lasciato l’anno prima. Ero convinto di conoscervi bene, invece non conoscevo nessuno, nemmanco me stesso, se ci penso.
La tua malattia è stata una scossa elettrica. Superata, sì, però poi mi aveva lasciato una moscerìa dentro il cuore.
Tua madre, per lettera, mi ripeteva che eri diventato una bestia fricàta, che a scuola non andavi più bene e che liticavi con tutti. E io ero partito in anticipo per te, per darti una dritta, una mano sicura, da padre.
Che Elisa era molto più inguaiata di te, non mi passava nemmanco per l’anticamera. Tua madre non sapeva se dirmelo, che parole usare. Aveva paura della mia reazione ma, se poi lo venivo a sapere da un’altra persona, ha ragionato che era peggio. E così le spunta in bocca un inizio di coraggio, quattro spine in croce, terribili.
«Elisa c’ha un amante. Dicono.»
Mi scoppia una risata tiepida, improvvisa e fastidiosa, come un filo di sangue dal naso.
Dice lei: «È una voce, niente più. Te lo dico per precauzione. Comunque che è un poco stramba lo hai visto con gli occhi tuoi».
Tua madre non aveva usato la parola fidanzato o zito o gàjar o ’namurato, che m’avrebbe reso felice, lo sapeva. Cosa c’è di più bello di un amore pulito e giovane? Aveva usato la parola amante con disgusto, come tirata fuori dalla zimba puzzolente di un maiale.
Mi passo una mano sulla faccia per dare a vedere che scorticavo solo un’ombra di stanchezza. Invece volevo scancellare quella parola imbrattata, quel dubbio volgare, non volevo più averlo nel cervello.
E lei ancora: «Un forestiero sposato, forse poco più giovane di te. Dicono».
Chiudo: «E tu credi a queste cioterìe?».
Non aspetto nemmanco la risposta. Basta. Vado al bar a giocare a carte. Ed è stato un errore, si sa sempre dopo. Forse, se mi muovevo prima, risparmiavo tanti dispiaceri a tutti noi. Come ho fatto con te, che ti stavo dietro come un’ombra...
Mio padre s’interruppe quando i suoi amici gli offrirono un’altra birra.
«A votre santé» gli sfuggì in francese. E uno di loro, sorridendo: «Parla come ti ha fatto màmmata, compar Tullio, se vuoi che ti capisciamo».
Gli altri si misero a ridere e ridendo dissero «Prost», in tedesco. Poi ripresero a parlare, seri. Erano quasi tutti germanesi, raccontavano dei sacrifici che facevano in Germania, «soprattutto all’inizio è brutto. Vero, compar Tullio? Il guaio dell’emigrazione è che quando parti non puoi più tornare indietro. Non ci riesci. Ti abitui a un lavoro con tutti i sacramenti che qua da noi nemmanco te lo sogni. Vero, compar Tullio?». Anche loro stavano bruciando i ricordi nel fuoco. E forse altre persone disseminate sulla scalinata. Si sentiva un bisbiglìo incessante, un canto di cicale sofferenti nell’aria cocente del sagrato. Una resa dei conti collettiva, davanti al nostro fuoco di Natale.
Mio padre raccontò che al ritorno dalla Francia le aveva provate tutte, pur di restare a Hora. Come famiglia si era sistemato bene: Francesca non si era mai pentita di aver sposato lui, un vedovo con una figlia piccola. Elisa si era ritrovata con due mamme, Francesca e la nonna, lei che in realtà non ne aveva nemmanco una, ed era cresciuta come tutte le altre bambine, anzi con un affetto doppio. Per non contare quello dell’intero vicinato. Lui, mio padre, per anni aveva cercato un lavoro da cristiano, con le carte a posto, e aveva trovato solo da buscarsi la giornata, dai muratori locali. Lavori in nero, sempre. Comunque non si era dato per vinto: coltivava la sua piccola quota di terra del Pigàdo, faceva un po’ di semina, un po’ di legna, la raccolta delle olive tra autunno e inizio inverno, e poi domande al Collocamento, telefonate, giri per i cantieri, viaggi a Crotone per chiedere di entrare alla Montecatini. Tornava a casa ogni volta deluso.
Finalmente, proprio quando stava per arrendersi e partire di nuovo, fu assunto a Hora da un’impresa edile forestiera che doveva costruire una strada comunale. Era un lavoro di picco e pala, a pochi minuti da casa, l’ideale per lui. Solo che l’impresa aveva l’abitudine di pagare con mesi e mesi di ritardo, e spesso e volentieri le ore di straordinario non le conteggiava o trovava mille scuse, ogni volta bisognava litigare per ottenere ciò che ti spettava di diritto. Così un giorno, dopo l’ennesimo litigio, mio padre non aveva aspettato neanche di scapolare: aveva buttato il piccone ai piedi del geometra ed era andato all’Ufficio di Collocamento per rifare la domanda di espatrio senza pentimenti.
Dissi a mio padre, quasi interrompendolo: «Le birre sono finite».
Lui guardò verso di me e Spertina, poi verso la cassa vuota, con occhi lontani che forse non ci videro: stava dicendo che Francesca aveva cercato di fermarlo con il cuore, non con la testa: «Abbiamo il pane e il companatico, abbiamo la salute e dei figli belli, lascia perdere la Fróncia, qua stai meglio che in Fróncia, qua ci sono io e i figli nostri», ma lui sentiva una pistola puntata alla tempia e la voce prepotente del bagasciaro nato che gli intimava: «O parti o premo il grilletto!».
Così era partito di nuovo per la Francia del Nord, sette mesi dopo la nascita del suo bir, il figlio maschio, io.
![]()
La notte dell’Epifania nevicò. La mattina le donne del vicinato uscivano di casa gridando allegre: «Çë borë e bukur na ka prunë Befana, che bella neve ci ha portato la Befana», e giocavano a palle di neve con noi bambini, pure Elisa, la mamma, la Piccola, tutte fuori nei vicoli imbiancati, e ripetevano: «Çë borë e bukur na ka prunë Befana», e scivolavano per finta, lasciandosi cadere sulla neve soffice a braccia aperte.
Poi arrivò la nonna e disse che avrebbe preparato shiribèkun per la gjitonia, il nostro vicinato: andò nell’orto con Elisa e insieme riempirono due casseruole di neve in granuli, pulita; rientrate in cucina, ci versarono sopra del mosto cotto.
Più tardi offrirono a ognuno di noi un bicchiere di shiribèk, una specie di granita invernale, dolcissima, che fu apprezzata soprattutto dai bambini.
Era l’ultimo giorno delle vacanze natalizie, l’indomani sarei ritornato a scuola, e dentro di me provavo un’allegrezza fredda come la neve che avevo pure nella pancia.
A pranzo mio padre mi disse: «Sbrigati e vèstiti caldo, ché andiamo alla quota di Pigàdo».
Mi sbrigai, è ovvio, anzi non finii nemmeno di mangiare, e corsi nella mia stanza a cambiarmi.
Quando uscii, seppi da mio padre che veniva pure la Piccola con noi. «Ah» feci io, un po’ dispiaciuto.
La Piccola era imbacuccata come un’esquimese, pareva dovessimo andare al Polo Nord. Le si vedevano solo gli occhi e un pezzetto di naso, ma da quel poco si capiva che non stava più nella pelle per l’eccitazione.
Mio padre si mise la sua doppietta a tracolla e, attorno alla vita, la cartucciera piena. Aveva in testa un vecchio cappellaccio da brigante e ai piedi degli scarponi pesanti che aveva usato in miniera.
Fuori ci aspettava Spertina e, accanto a lei, una piccola slitta di legno, tutta storta e tarlata.
«L’ho costruita alla tua età con le mie mani» mi disse mio padre. «A quei tempi nevicava ogni inverno, tre o quattro volte. Noi bambini facevamo delle scivolate dalla piazza fino alle zimbe del Palacco: era bellissimo.»
Senza chiedere permesso, la Piccola si mise a cavallo della slitta e mi ordinò: «Tira».
Che dovevo fare? Lei era la Piccola, e mio padre si mostrava d’accordo. Infatti disse: «Se non la tiriamo, fra dieci minuti ci toccherà ritornare a casa perché la Piccola si stanca subito e si mette a strillare, tu lo sai com’è fatta».
La Piccola sorrise spavalda.
Dal Palacco alla piazza fu una faticaccia perché la strada è tutta in salita e la Piccola era pesante. Mio padre camminava avanti, con Spertina al fianco. Neanche mi chiedeva se volevo una mano. Poi, dalla piazza, infilammo un tratto in leggera discesa e un altro pianeggiante; allora respirai.
Finalmente, arrivati fuori paese, un po’ dopo il bivio del Padreterno, c’era solo discesa fino al Pigàdo.
Montai sulla slitta, alle spalle della Piccola, e filammo più veloci del vento, inseguiti da Spertina che aveva voglia di sgranchirsi le gambe, mentre mio padre arrancava nella neve e gridava: «Aspettatemi, aspettatemi, così non si fa».
Mi sembrava di guidare una macchina da corsa, frenavo solo nelle curve, premendo più che potevo gli stivali di gomma sulla neve. La Piccola urlava: «Più forte, dài, più ventoloso». E ormai mio padre era un cappellaccio da brigante senza voce, un puntino nero e poi niente più.
Arrivammo alla nostra quota e ci fermammo folgorati.
La campagna era una nuvola immensa di un bianco abbagliante. Non c’erano cespugli né rovi né piante. C’era solo quel bianco ondulato che saliva verso il bosco.
«È vero, Marco, che gli alberi sembrano di zucchero filato?» mi chiese la Piccola a voce bassa.
Feci segno di sì con la testa. Non parlai. Non mi andava di disturbare quel silenzio bianco da favola.
Fu Spertina che s’accorse delle tracce e cominciò ad annusarle bagnandosi il naso nella neve. Poi arrivò mio padre col fiatone. «Mi avete fatto sudare, malgrado il freddo. Erano anni che non correvo così, e per giunta sulla neve!» Non era arrabbiato, però.
Notò anche lui le tracce e capì al volo. «’Sti figli di bagascia! Sono arrivati fin quaggiù stamattina presto a mettere tagliole e trappole nella nostra quota. Con questo freddo chissà quanti uccelli in cerca di cibo, poverini, ci avranno lasciato le penne.»
La Piccola e io non capivamo.
«Ora vedrete. Venite con me.» E, mentre avanzavamo a fatica nella neve, gli balenò un’idea: «Stasera verranno a raccogliere le tagliole e gli uccellini morti. Troveranno capocchie!».
Spertina stava percorrendo lo stesso tragitto a naso in giù, molto più avanti di noi. Se non avesse avuto i suoi cuoricini marroni sul dorso, bianca com’era, sarebbe stata invisibile.
Sotto un ulivo scoprimmo la prima tagliola; dietro a un cespuglio vicino, la seconda. E poi un’altra ai piedi di un pero e un’altra dentro la vigna. Più si girava, più c’erano tagliole di ferro. «Criminali» diceva mio padre. «Cattivi» diceva la Piccola. Nelle morse scattate trovammo una ventina tra pettirossi, passeri, merli e persino qualche ghiandaia. Tutti rigidi, col becco spalancato.
Sul fermo delle tagliole aperte erano legati vermi ancora vivi e infreddoliti, che si agitavano invano come minuscoli cobra dagli occhiali. Bastava urtare il fermo col becco e zac!, la morsa si chiudeva di scatto sul collo degli uccelli malcapitati.
Qua e là c’erano trappole rudimentali, preparate con palette pesanti di fichindiani: stavano in bilico su un legnetto centrale alla cui base era attaccata un’oliva nera.
Mio padre calciò la neve contro le tagliole e le trappole ancora attive e disse che lui gli uccelli li rispettava, lui andava solo a caccia grossa di maiali selvatici, o al massimo di lepri e di volpi. Agli uccellini che gusto c’è di sparare? Al «pam» della fucilata ti cadono dentro i rovi dalla paura o colpiti da un pallino a caso.
Però raccolse gli uccelli morti liberandoli dalle tagliole: avevano gli occhietti aperti, terrorizzati. Siccome nessuno di noi sopportava quella vista, li prendeva dalle zampe e li ficcava nella bisaccia. «La mamma ci prepara un bel brodo saporito, con questi. Tanto sono già morti; se li lasciamo qui, se li mangiano quei farabutti.»
Spertina abbaiava quando fiutava un uccello in trappola, però non lo toccava, rispettosa come il suo padrone.
Trovammo un passero e un merlo ancora vivi, sotto una paletta di ficoindiano, e una ghiandaia ferita alla zampa da una tagliola. Mio padre ce li lasciò accarezzare e riscaldare con il fiato; poi li scagliò nel cielo, verso casa loro. E ogni volta prendeva il fucile, mirava all’uccello che lui stesso aveva liberato e faceva «pam» con la bocca, come un bambino.
All’inizio non capivo perché avesse portato il fucile. Poi prese una paletta di ficoindiano da una trappola e andò a infilarla nella neve a una ventina di metri da noi. Si levò il fucile dalla spalla e mi mostrò come si apriva, come si infilavano le cartucce.
Alla fine, quando fu sicuro che avessi imparato, me lo fece imbracciare.
«Spara a quella paletta» mi disse.
La Piccola si mise a frignare: «Papà, io ho paura».
«Mettiti le mani sulle orecchie» le ordinò un po’ seccato, «e sta’ quèta dietro a noi!»
Anch’io avevo paura di sparare, però non potevo rifiutarmi. Non potevo.
Mio padre mi spiegò come si prende la mira.
Mirai, premetti il grilletto. Sentii sulla spalla il rinculo violento del fucile, due volte.
La paletta esplose in cento pezzi che volarono bassi assieme a una ghir...