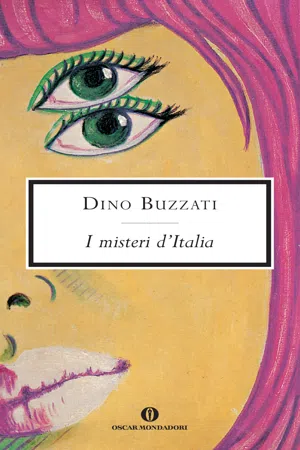![]()
![]()
Belluno, luglio 1965
Sono seduto sul pianerottolo della scala, di fianco a me, per terra, un candeliere di latta con una candela accesa. Di fronte, una porta a due battenti, appena appena socchiusa.
È la porta del vecchio granaio che sorge di fianco alla casa dove sono nato. Intorno, la notte della campagna, e i ricordi.
Tra poco, di là dalla porta, si farà vivo lo spirito che frequenta questo granaio da tempo immemorabile.
Forse.
Un curioso e bel libro intitolato Guide de la France mystérieuse, editore Claude Tchou – con dentro le leggende di Francia, i monumenti enigmatici, i mostri, i maghi, i demoni, i fantasmi, i tesori nascosti, – mi ha fatto venire la voglia di raccontare qualcuno dei misteri grandi o piccoli che esistono anche da noi, tanti e tanti in un Paese antico e profondo come l’Italia.
E mi è parso giusto cominciare dal posto dove sono nato. Qui infatti per me comincia l’Italia, anche se si tratta di un mistero piccolino, di cui non hanno mai parlato i giornali e le cronache.
La Val Belluna non è tipica terra da stregonerie e da fantasmi. La gente qui non ha molti umori fantastici, la campagna e i declivi sembrano bonari.
Però incombono le montagne. Tranne lo Schiara e il Pizzocco, sono cime senza storia alpinistica, tuttavia dirupate, selvagge, di forme insolite e ne viene un sentimento dell’ignoto, ne vengono romantiche figurazioni, decrepite querce, casolari abbandonati, echi di schioppettate lontane, straducole su e giù per le forre che a un tratto si perdono nel nulla, ponti fradici, fumi solitari, viandanti zoppi, cornacchie, valloni deserti, frane, macigni troppo immobili, cimiteri derelitti, imboscate al lume di luna.
Al pianterreno, seminterrata, c’è una lunga e vasta cantina, con i tini tenebrosi, le botti, gli arnesi vinari. Sopra, altrettanto grande, il granaio. Sopra ancora, la soffitta immensa. Lui sta nel granaio.
Poi, alle mie spalle, esistono due stanzette dove vive la custode della nostra casa, di nome Maria Pia Orzetti, sugli anni quaranta, chissà perché chiamata Amabile. A quest’ora dorme.
Non è lo spirito di un antenato ma semplicemente di un antico fattore, altrimenti detto castaldo, del principio dell’Ottocento. Ma la differenza conta poco. Anche l’ultimo dei bifolchi, una volta disincarnato, diventa più importante di un arciduca corporeo.
È leggenda si chiamasse Fontana, è leggenda che defraudasse i padroni e gli altri contadini nel conteggiare le misure di granturco; e perciò fu condannato a rimanere quaggiù nel preciso luogo delle sue malefatte. Fino a quando?
Da bambino sentivo dire che lo udivano spesso rimestare tra i mucchi di grano e di mais e far rotolare sul pavimento il cilindro di legno con cui si livellano le staia. Poi lo si è udito sempre meno, progressivamente, come se si apprestasse a lasciarci. (Stupidaggini, vero? Ridicole superstizioni da analfabeti, si intende.)
Dicono infatti che gli spiriti dei personaggi trapassati perdano di anno in anno vitalità e consistenza, dimagrino, si attenuino, si facciano sempre più fievoli e sottili, fino a dissolversi del tutto. Quasi che non si trattasse di anime trattenute quaggiù dal carico dei peccati, bensì di una impronta, un’orma, una traccia, uno stampo, lasciato da alcuni esseri umani; che, appunto come tale, con l’andare del tempo si smussa, si logora, si annulla.
Ore 23.10. Sono solo. Le luci delle due stanzette sono spente. Avevo detto all’Amabile che sarei venuto, mi ha preparato una sedia e una candela, non ha riso né sorriso del mio sopraluogo, anche lei ci crede a queste storie e dice che certe notti “quello lì” si dà un gran daffare soprattutto nella soffitta.
Però adesso l’Amabile dorme. E la vicina nostra casa, dove sono nato, stanotte è chiusa, deserta e nera. E di fuori un ticchettìo di pioggia morente sulle foglie della vite selvatica arrampicata sul muro. Un’automobile che si avvicina e dilegua, uno svogliato ronzio di mosca.
Emanuele De Bona, marito dell’Amabile, ha trovato la morte un mese e mezzo fa in un incidente di motocicletta. Due sue giacche pendono al mio fianco da un rustico attaccapanni, una di tela blu, l’altra di lana grigia. E nel granaio, appena di là dalla porta, sta sull’apposito sostegno la motocicletta fatale, semicoperta da un pietoso telo.
L’ho vista poco fa quando sono entrato a ispezionare il nudo stanzone: per terra, giusto nel mezzo del granaio, una coltre quadrangolare di granturco dello spessore medio di 15 centimetri. Poi due ceste vuote, una scopa di ramoscelli, lo staio col suo cilindro di legno, nient’altro. Dall’ombra proiettata sul muro dalle due giacche esce in silenzio un millepiedi che si incammina orizzontalmente sul muro.
Ore 23.25. Sì, sono stato abbastanza coraggioso, forse una volta non ce l’avrei fatta a venire qui solo di notte, sullo spirito del granaio c’è poco da ridere. Undici anni fa, come adesso, in una notte di settembre, appostati su questo medesimo pianerottolo, al lume di una candela anche allora, mio cognato e io col batticuore lo udimmo camminare.1
Inconfondibilmente, dal fondo dello stanzone, un essere umano avanzò senza fretta in direzione della porta dietro la quale stavamo noi due. Era un passo scandito e pesante, come di scarponi chiodati.
Tramp, tramp, ormai doveva essere a non più di quattro metri.
«Apriamo?» domandò mio cognato.
«Apriamo» dissi e lui si alzò con la candela in mano, si avvicinò alla porta e d’impeto spinse il battente socchiuso.
E il passo di colpo è cessato, e là dentro non si è vista anima viva, i mucchi e i sacchi di grano giacevano immobili al posto di prima, apparentemente addormentati.
Ore 23.31. Il millepiedi si è spostato a sinistra della porta, ora è appeso sullo sghembo soffitto della sottostante rampa di scala.
L’intelaiatura della porta è fatta di pietra intonacata di bianco ma sugli spigoli, a forza di passare, di strusciare, di urtare per tanti anni, l’intonaco è andato via e traspare il lucido del sasso. Rumore di pioggia, ticchettìo sulle foglie. Ma è proprio rumore di pioggia? O altro? Questo ticchettìo è fuori, o dentro la casa, oppure dentro di me?
La fiammella della candela, senza apparenti ragioni, dava ogni tanto improvvisi piccoli guizzi.
E il sentimento della notte, così forte e struggente nella casa mia natale, popolata di volti, di voci, di momenti perduti per sempre, quella soggezione solenne e antica che viene su dal sangue a rintocchi.
Suonò da una chiesa lontana mezzanotte. Mi sono fatto forza, ho spento la candela, per invogliare colui. Ma stringo nella destra la torcia elettrica pronto a scattare. L’udito è una caverna dove un moscerino farebbe frastuono. Che si sta facendo a quest’ora nel Vietnam? Stanno rientrando alla base le pattuglie della notte con due tre uomini in meno? E come sarà tra poco il tramonto sulle torri arroventate di Nuova York?
Ore 0.07. Un colpetto, sì un minimo colpetto di là dalla porta, laggiù in fondo, ma forse è un banale scricchiolio, forse è niente, sì, non è niente. Un’auto, un’altra auto, dove corrono a quest’ora, dove vanno?
Dalla finestrella con inferriata a filo del pianerottolo inferiore traspare, fra una foglia e l’altra della vite selvatica, il buio del giardino, meno nero di questo nero-inchiostro dal quale mi trovo avvolto.
Sembrò di udire un ritmico rantolo sommesso, forse è l’Amabile che dorme. Spirito, se ci sei, fatti sentire, pensai intensamente. Sarebbe dovuto bastare. Mi è mancato il coraggio di pronunciarlo ad alta voce.
Ore 0.17. Un tenue breve trapestio di sopra, soffice. Topi. Non piove più. Un cane lontano chiama. La finestrella, di sotto, come due occhi fosforescenti.
Sì, sì, non ci può essere errore, un passo. Un passo umano che si avvicina, un po’ strascicato, pesante. Il tonfo del cuore all’urto dello spavento.
Poi capisco. E la paura svanisce. Il passo non viene dal granaio bensì risuona alle mie spalle, dalle due stanzette dell’Amabile. È chiaro: l’Amabile, che avevo preavvertita, si è alzata e viene a vedere.
Ecco infatti il cigolìo dell’uscio dietro di me. Accendo la torcia elettrica, dirigo il raggio alla porta. Un battente si schiude un poco, muovendosi con lentezza. Vedo di là una fetta di buio, lei Amabile non la vedo, ma so che è lei, venuta a controllare.
«Sì, sono io. Buonanotte» dico. Il battente adagio si richiude senza parole. Ancora il passo strascicato che si allontana e si perde nel silenzio.
Così si è rotto l’incantesimo, banalmente. Sono le 0.46, tardi oramai. Un aereo altissimo che passa; da dove? Verso dove? Un clic clic che si ripete tre quattro volte giù all’ingresso, forse una goccia. Addio, spirito antico, anche tu consumato dal tempo a poco a poco, simbolo di una età felice e defunta, della remota fanciullezza, delle favole, delle parole che dissi e che udii, dei lari benigni, dei vecchi che non conobbi, del padre, della mamma, addio.
Prima di ripartire, la mattina dopo, sono passato a salutare l’Amabile. La porta del granaio era chiusa. «Amabile! Amabile!» chiamo.
Risplendeva il sole bianco e bellissimo sull’erba ancora imperlata di tempesta, le montagne così nitide si erano fatte vicine. Il coccodè idiota delle galline, un contadino che batte col martello la falce, il rumore metallico si spandeva lontano.
La Amabile si è affacciata alla finestra. «Ah, buongiorno, signor Dino. Ieri sera non è venuto, poi? Io l’ho aspettato fino alle 11. Poi mi scuserà ma sono andata a dormire.»
«Dopo però si è alzata per vedere se c’ero, no?»
«Io? Quando? Mi deve scusare, sa, ero così stanca...»
«Ma se ho sentito i suoi passi, se ho visto la sua porta che si apriva!»
Scuote la testa: «Oh, signor Dino, a lei piace scherzare».
Un gallo ritardatario cantò.
![]()
Vicenza, luglio 1965
Il Veneto della pianura è un posto abbastanza misterioso, se non uno dei posti più misteriosi d’Italia. Non è che ci siano molti fantasmi, castelli in rovina, oggetti e creature sinistre, ruderi stregati, paesaggi che danno inquietudine, personaggi enigmatici. Anzi.
Il basso Veneto è così misterioso proprio perché il mistero non si vede. La luce del mattino qui esprime pace e buoni raccolti, la luce del pomeriggio raccomanda di non esagerare nel lavoro, la luce del tramonto dice amore, felice notte, dormirete tranquilli. Le case del Veneto non sono accigliate o severe, non hanno l’aria di nascondere qualcosa. I vicoli, i cortili, i quadrivi non sono mai ambigui o minacciosi. Il male si direbbe debba sentirsi spaesato. Però ascoltate:
La storia della signora Vittoria Manzan. «A Conegliano, durante l’ultima guerra, mia sorella Ermenegilda si è ammalata. Febbre, dolori, le ghiandole gonfie, i dottori non ci capivano niente. Un bel giorno, sa come ci dico, è capitata una donna di Arcade con due occhi che pareva una strega. Guarda mia sorella e dice: Vedrà che stasera sentirà una persona che farà pipì nella sua stanza. Tutte robe fantastiche. E alla sera nella stanza si sente come una fontana che buttava. Da principio si credeva che piovesse. Abbiamo aperto la finestra, ma niente... Quella donna è tornata dopo due giorni e noi le abbiamo raccontato tutto. Allora lei: Domani notte lei sentirà dei sassi che busseranno alla porta. Viene la notte e si sentono quattro cinque sassi che vengono giù per la scala... Se li abbiamo trovati? No, non c’era niente... E dopo altri due giorni quella là torna e dice: Provate a vuotare il piumino del letto. E noi l’abbiamo vuotato e c’erano dentro due pezzi di legno legati in croce e poi una cosa tonda di filo grosso con tante piume intorno e poi degli stecchetti anche questi con le piume legate con filo bianco. Allora noi abbiamo bruciato il piumino con tutto quanto. E dopo altri due giorni la donna è tornata e ha detto a mio cognato di andare a Sant’Urbano di Godega da una chiromante a farsi fare le carte, che gli avrebbe detto chi aveva fatto il maleficio. Mio cognato va e la chiromante gli dice di accendere il fuoco e di buttarci sopra una manciata di sale, che la donna che ha fatto il maleficio verrà. Infatti, buttato il sale, è piombata in casa una donna del paese e mio cognato l’ha tenuta chiusa a chiave per un’ora. Poi lei è scappata e non si è più vista, così mia sorella è guarita.»
Benché non esista più la repubblica, il riflesso di Venezia si propaga ancora su tutti i territori che le appartenevano. Non si tratta di un’immagine letteraria bensì di un fenomeno fisico che tutti possono constatare. Sue caratteristiche sono la saggezza, la signorilità, l’eleganza e la luce. Si ha quasi la sensazione che in quei paesi la gente una volta fosse abbastanza felice; e ancora oggi un po’ del benefico influsso sopravvive. Nel complesso, una terra rassicurante, dove gli incubi non possono attecchire. Però ascoltate:
La storia di don Chiotto. Il popolarissimo consolatore dei carcerati, che fino all’ultimo fu accanto ai condannati del processo di Verona – già venerato da molti come santo – raccontava a un amico: «Questo pomeriggio ho preso il tram da Porta Nuova a piazza delle Erbe. Salgo. Mi siedo. Una voce: buongiorno, don Chiotto. Mi volto. Di fianco mi sta seduto uno che conoscevo benissimo, l’avevo incontrato in carcere, un brav’uomo, sai, tante volte aveva fatto la confessione con me. Morto tre anni fa, mi ricordo... Sì, sì, morto tre anni fa... Così chiacchieriamo un poco, lui mi dice che se la passa abbastanza bene ma mi raccomanda di pregare per lui... Intanto io sono arrivato. Mi alzo. Scendi anche tu?, gli domando. Lui ride: Eh, don Chiotto. Lo so come andrebbe. Lei dopo mi offre un caffè e io, lei mi capisce, io non posso...».
Il Veneto è una plaga molto cattolica, le suore del Veneto sono un po’ più sorridenti delle altre suore d’Italia, fanno dolci e pasticcini un po’ più buoni. Però si commettono molti peccati nell’incavo delle famiglie, alcuni sostengono che i peccati del Veneto sono spesso più strani e perversi che nelle altre regioni. Il Veneto è pieno di storie familiari strane, spiritate e cattive di cui non si parla ma si sussurra (e affiorano ogni tanto nelle pagine di Guido Piovene). Ascoltate dunque:
La storia delle confessioni. «Il 26 maggio a Fanzolo c’è la festa della Madonna di Caravaggio e viene steso un grande telone davanti alla chiesa e su un piedestallo mettono la statua della Madonna. Intorno, una quantità di gente, soprattutto donne inginocchiate che si battono il petto, e tra la folla gira un tipo dall’aria cattiva che raccoglie gli oboli. Poi la folla spinge avanti le indemoniate sotto la statua della Madonna. Vedesse che spettacolo. Donne che sputano chiodi, donne che sputano aghi, una abbaia, una miagola, una si rotola per terra. Poi se ne vanno via pacifiche come tante pecorelle. L’ultima volta mi ricordo che proprio vicino a me c’era un marcantonio d’uno che sembrava un Ercole, l’avesse visto. E quando le indemoniate si sono messe a sputare fuori i diavoli, lui ha cominciato a tremare. Tremava, tremava, e si è messo a piangere come un bambino.»
Di persone strambe che facevano cose strambe, il Veneto una volta era pieno. Può esistere del resto una città eccentrica, inusitata, illogica, pazzesca più di Venezia? In ogni famiglia del Veneto si raccontano curiosi episodi dello zio o della zia, del bisnonno o della bisnonna. Adesso, col progressivo livellamento delle creature umane, questi casi si fanno sempre più rari. Però ascoltate:
La storia del Mazzariol. «Mi raccontava mia nonna» dice la signora Casteller, di Nervesa della Battaglia, una signora posata e sempre di buonumore «che quando lei andava al pascolo col cavallo, dai cespugli saltava fuori il Mazzariol, era un omino tutto rosso coi cornetti neri e la coda, che teneva in mano un secchiello; e fischiava sempre... Anche mio papà l’ha incontrato una volta, il Mazzariol, di notte, erano passate le dieci, lui andava attraverso i campi a incontrare la mamma. Ma...