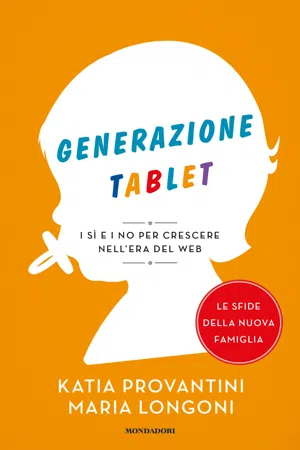![]()
Nel nostro lavoro di psicologhe che si occupano di difficoltà scolastiche e di apprendimento in età evolutiva capita spesso di occuparci di questioni educative che coinvolgono il mondo digitale. Frequentemente, nell’imminenza di una decisione da prendere («Stacco il computer?», «È il caso di regalargli il nuovo gioco che chiede con tanta insistenza?»), ci ritroviamo a interrogarci, insieme ai genitori, non solo sul significato evolutivo che certe difficoltà sembrano contenere, ma soprattutto sul valore che quel determinato strumento sembra garantire in vista del superamento della crisi. Le storie di giovanissimi alle prese con le proposte e le SUGGESTIONI DELLA RETE sono molte, come moltissime sono le perplessità degli adulti chiamati a gestire un mondo in rapido e continuo mutamento. Abbiamo deciso di raccontarne alcune, quelle che ci sembrano più rappresentative delle problematiche tra genitori e figli nei primi dieci anni di vita.
L’ineludibile incontro con la tecnologia
Daniele è un bambino di 3 anni, per nulla esperto di tablet e touch screen, perché i genitori non gli hanno proposto questo genere di esperienza, non avendo ancora chiaro quanto sia davvero necessaria e, a maggior ragione, quanto possa davvero essere utile a un bambino così piccolo. Tutti i mercoledì pomeriggio Daniele, insieme alla nonna o alla tata, accompagna la sorella maggiore a ginnastica e aspetta che finisca la lezione. Per ingannare il tempo, solitamente viene portato ai giardini, dove può distrarsi, divertirsi a correre, arrampicarsi e scendere dallo scivolo. Capita però, soprattutto nella stagione invernale, che i giardini siano difficilmente praticabili per il freddo o la pioggia, e così la nonna e la tata, per aiutarlo a passare l’ora, lo fanno disegnare o gli leggono un libro, cosa che al bimbo piace molto.
Un giorno Daniele rimane molto colpito da un oggetto particolare, con cui una bambina sta armeggiando, e le si avvicina: per un po’ la osserva mentre disegna forme e le cancella su uno schermo piatto utilizzando soltanto le dita e resta impressionato quando la vede colorare gli spazi e cambiare i colori a suo piacimento. Dopo qualche minuto di osservazione, Daniele prova ad allungare il braccio per toccare lo schermo con un dito e si stupisce che anche al suo tocco lo schermo si riempia di colore. La bambina gli concede di condividere il TABLET e di sperimentare il gioco, e così Daniele si trova a interagire in modo spontaneo e immediato con il nuovo strumento, apprendendo intuitivamente dall’esperienza come utilizzarlo.
Questo episodio evidenzia come l’accesso agli strumenti tecnologici sia davvero semplice, anche là dove non sia deliberatamente proposto: il loro utilizzo è del resto molto intuitivo e immediato, non richiede particolari insegnamenti, tanto da configurarsi come una nuova frontiera di OFFERTA FORMATIVA.
Oggi il bambino in età prescolare ha un’altissima probabilità di venire precocemente a contatto con tablet, computer, console per videogiochi, ed è quanto mai importante aprire il dibattito sulle potenzialità e sui rischi di questi dispositivi e su come l’adulto possa favorirne un buon utilizzo. Se, come dicevamo poc’anzi, il bambino possiede nuove CAPACITÀ DI COMPRENSIONE e di interazione con la realtà e gli stimoli che incontra, è anche vero che, per via della sua personalità in formazione, tende a osservare molto gli altri e a far propri i loro comportamenti.
L’attuale grande disponibilità di strumenti tecnologici rende il bambino di oggi curioso di quel che si può fare con essi: i piccoli in età prescolare apprendono emulando gli adulti, ove possibile, perciò spesso accade che siano proprio loro a chiedere di guardare prima quel che il genitore, il parente o l’educatore sta facendo e poi di interagire con lui nella sua attività, come se fosse un vero e proprio gioco. Succede anche che, qualora il bambino viva in un ambiente familiare poco stimolante dal punto di vista tecnologico, per scelta o per caso, egli possa accedere alla tecnologia in momenti diversi e non strettamente legati al contesto familiare, come quelli dello svago con altri bambini o nelle pause tra un’attività e l’altra.
Questo fenomeno, che potrebbe costituire un aspetto non previsto dalla famiglia, ci pare ineludibile nel momento in cui sosteniamo i nostri bambini nell’interazione con gli altri, inducendoli così a entrare in contatto con conoscenze e abitudini diverse, che sono l’effetto di modalità educative e di pensiero talvolta differenti dalle proprie.
Il rischio, in questi casi, è di lasciare i più piccoli alle prese con la scoperta di un mondo affascinante (e all’apparenza del tutto innocuo) senza il supporto dell’adulto e senza quindi la possibilità di essere guidati, nella conoscenza di questi strumenti, in modo attento e graduale. In molti casi i bambini si convincono che i propri genitori non sono aggiornati e competenti in materia di tecnologie e questo li spinge a considerarli degli interlocutori inadeguati, quando bisogna discutere di rischi e di potenziali pericoli via web. Noi pensiamo che tale DISTANZA EDUCATIVA E RELAZIONALE favorisca, nei più giovani, un approccio superficiale e ingenuo alla rete.
«Mamma, fammi giocare sul tuo telefonino»
Lisa è una bambina di 4 anni, molto attenta, vispa e desiderosa di scoprire cose nuove. È una grande osservatrice e sa che gli adulti usano il telefono, oltre che per telefonare, anche per «vedere» qualcosa: video, foto, scritte che per lei sono ancora indecifrabili. Ultimamente alla mamma è venuta la curiosità di proporle un gioco per bambini che ha trovato tra le centinaia di applicazioni per smartphone. È stato proprio interessante e divertente osservare la bambina mentre cercava di seguire le consegne del gioco e si destreggiava sempre più abilmente nei vari livelli di complessità, tra colori, suoni e immagini accattivanti. Poi, però, qualcosa è andato storto, perché Lisa ha iniziato a chiedere insistentemente di quel gioco, fino a diventare eccessiva e stancante: sembrava che ne avesse un estremo bisogno, pretendendo di poterlo fare in ogni momento della giornata. Com’era possibile che un’azione piacevolmente condivisa e di cui la mamma era stata promotrice fosse diventata tanto disturbante?
Lisa e la mamma hanno provato entrambe soddisfazione nell’utilizzare lo smartphone per giocare ed è probabile che si sia verificato un INCONTRO DI DESIDERI: quello della madre, che voleva mostrare alla sua bambina cose nuove, divertenti, perfino istruttive, e quello della figlia, che voleva finalmente possedere e conoscere un oggetto che fino a quel momento non le era stato possibile vedere da vicino. È in questo connubio di desideri che spesso prende forma il primo contatto con i nuovi strumenti tecnologici, di cui gli adulti sono detentori, ma di cui i bambini diventano immediatamente abili fruitori. Tuttavia, come per ogni fruizione infantile, anche questa va regolata dallo sguardo e dal buonsenso degli adulti: molte mamme non avrebbero difficoltà ad ammettere che se permettessero al proprio bimbo di mangiare un barattolo di marmellata o un intero sacchetto di caramelle, sarebbe assai difficile che lui riuscisse a non farlo. Analogamente, se accompagnassero il figlio alle giostre e lui le trovasse entusiasmanti, difficilmente non chiederebbe di tornarci ancora, magari il giorno dopo.
Sono esempi di un comportamento che si attiva per il semplice fatto di vivere un’ESPERIENZA PIACEVOLE e quindi di volerla ripetere: una bella attività, stimolante in quanto nuova e in cui i bambini possono sperimentare le loro competenze, è sicuramente apprezzata e richiesta. Nel caso di Lisa, il videogioco svolge oltretutto la funzione di fare incontrare due desideri: quello della mamma di mettere alla prova la sua bambina e di osservarla compiaciuta mentre affronta cose sempre più difficili, e quello della bambina di divertirsi, mettendosi alla prova, in compagnia della mamma.
Tuttavia, come ogni gioco che si rispetti, ha un tempo definito per essere svolto, perché successivamente ci saranno altre occupazioni, altri tipi di svago, la lettura di un libro, una corsa all’aria aperta, le attività quotidiane legate alla cura di sé e così via. La mamma di Lisa si spaventa per le richieste pressanti della bambina ma forse la conforterebbe il pensiero che tali richieste fanno parte della normale attrazione dei bambini verso le cose belle e divertenti; spesso è la TECNICA DELL’INSISTENZA, in grado di sfiancare il più paziente dei genitori.
A sostegno dell’impresa, aiuta forse ricordare che certamente fa parte dei compiti preziosi di un genitore riuscire a orientare le richieste e frenare quelli che potrebbero diventare capricci (e questo vale per qualsiasi attività, comprese quelle che hanno finalità importantissime per l’affinamento di certe competenze). La tecnologia offre ai bambini di oggi molti strumenti in più per divertirsi e forgiare il loro pensiero, e il fatto che imparino a usarli in età precoce non crea di per sé il rischio che sviluppino una dipendenza, soprattutto se tale processo avviene con la mediazione e la REGOLAZIONE DEI TEMPI da parte di un adulto. La mamma di Lisa è preoccupata di non riuscire a indirizzare meglio i desideri di sua figlia e di avere fatto una scelta azzardata proponendole un gioco che si è rivelato capace di creare una dipendenza eccessiva. Il suo errore è di concentrare l’attenzione esclusivamente sullo strumento tecnologico, perdendo di vista le modalità educative che adotterebbe con la propria figlia in altre situazioni. Con ogni probabilità, il problema si «smonterebbe» e Lisa diventerebbe più equilibrata nelle sue richieste.
«No, devo finire la partita!»
Lorenzo è un bambino di 10 anni che adora il calcio ed è un tifoso sfegatato della sua squadra del cuore, di cui conosce sempre non solo la posizione in classifica, ma anche la formazione schierata nell’ultima partita, quali saranno i prossimi avversari, le possibilità di successo in campionato e così via. Ovviamente, Lorenzo guarda in tv quasi tutte le partite e, condividendo la passione con suo padre, ha avuto la fortuna di andare qualche volta allo stadio, dove ha imparato inni, canzoni e cori di incitamento per la sua squadra. Da quando gli zii hanno voluto regalargli la PLAYSTATION, il bambino trova molto divertente giocare a calcio con il computer, utilizzando un gioco in cui si possono scegliere la formazione, i colori delle magliette, le strategie di attacco e difesa, proprio come se ci si trovasse a gestire una squadra reale. Attraverso la simulazione, Lorenzo fa l’esperienza di essere al tempo stesso allenatore, giocatore e tifoso della sua squadra.
Capita spesso che, soprattutto nei pomeriggi in cui non deve andare a giocare a pallone nella società sportiva a cui è iscritto, Lorenzo trascorra gran parte del suo tempo libero prima di cena disputando avvincenti partite al computer con la sua squadra. Quando il papà torna a casa dal lavoro, non di rado trova Lorenzo davanti allo schermo e nota che lui non solo non interrompe la partita per raccontargli le novità del giorno e chiedergli come sta, ma stenta perfino a salutarlo dopo una giornata intera che non si vedono. Il papà, pur essendo un appassionato di calcio, che guarda le partite in tv e va allo stadio, non trova invece così attraente questo gioco fatto «a tavolino», anche se gli ricorda vagamente le partite della sua infanzia al biliardino. Soprattutto, a infastidirlo è il fatto che Lorenzo, da quando ha scoperto il videogioco, sembra essersi dimenticato delle buone maniere e di come ci si comporta in famiglia, arrivando a essere scortese anche con la mamma, quando lei lo chiama per andare a cena proprio mentre lui «deve finire la partita». Teme, inoltre, che questo gioco possa catturare un po’ troppo le attenzioni del figlio, il quale sarebbe portato a praticarlo anche insieme agli amici che invita a casa, e che possa indurre in lui comportamenti un po’ «sopra le righe», aumentandone l’IRRITABILITÀ e l’IRREQUIETEZZA.
È una storia molto comune, perché i bambini del nuovo millennio utilizzano quotidianamente il videogioco per divertirsi e sarebbe improduttivo vietarglielo in quanto fa parte del loro mondo. Esiste allora un modo per far accedere i propri figli alle innovazioni tecnologiche, senza che queste monopolizzino la loro vita e stravolgano i rapporti tra le persone? Acquisire una saggezza digitale è un obiettivo ambizioso ma decisivo nell’odierno rapporto con la tecnologia. Se ciò vale per gli adulti, che trascorrono sempre più tempo davanti al monitor di computer e tablet per lavoro o per svago, deve valere anche, e a maggior ragione, per i bambini, che vanno aiutati ad assumere un atteggiamento equilibrato nei confronti della tecnologia. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, i bambini hanno bisogno che gli adulti si facciano carico di una parte della fatica, stando loro vicino, proponendo ALTERNATIVE DI GIOCO e limitando l’utilizzo di PlayStation e dispositivi analoghi a tempi e a orari ben precisi. Se il bambino sa di poter fare una certa cosa soltanto in un determinato orario, magari brontolerà con i genitori per i limiti che gli sono stati imposti, ma alla fine obbedirà. (Con i bambini si può – e si deve – ancora fare: di lì a poco arriverà l’adolescenza a soffiar tempesta… ma questa è un’altra storia.)
Uno dei fraintendimenti più frequenti in cui incorrono i genitori dei «nativi digitali» è pensare che i computer producano di per sé cose cattive e pericolose, senza tenere sufficientemente in considerazione che, per evitare rischi, è piuttosto il modo in cui vengono utilizzati che va perfezionato. Perciò, se da un lato ricerche recenti mettono in relazione un elevato utilizzo di videogiochi «sparatutto» con una maggiore attivazione neurofisiologica, altre ricerche correlano positivamente l’UTILIZZO MISURATO e finalizzato del computer con migliori risultati scolastici rispetto a quei pochi bambini che ancora non lo usano. In fondo, anche giocare al pallone per ore, come facevano i bambini di un tempo, produce cambiamenti neurofisiologici, quali la spossatezza e il conseguente calo della capacità di attenzione e concentrazione.
Come detto, la demonizzazione della tecnologia, accusata di creare dipendenze e far correre alle nuove generazioni pericoli gravissimi, rischia di farci assumere una posizione ideologica che rompe la relazione genitori-figli; sottolineare esclusivamente le insidie e le problematicità del web può inoltre coprire o sminuire altri fattori che più direttamente spiegano certi comportamenti dei bambini che crescono.
Nel caso di Lorenzo, per esempio, il papà si rende conto che qualcosa non va nel momento in cui suo figlio gli presta scarsa attenzione, preferendo concentrarsi su un videogioco che lo coinvolge maggiormente. Questa attività potrebbe, tuttavia, non essere la vera causa dell’allontanamento di Lorenzo, ammesso che di allontanamento realmente si tratti; si potrebbe pensare che con queste sfide un ragazzino di 10 anni stia costruendosi l’immagine di «esperto» in materia di calcio e che gli interlocutori privilegiati siano i suoi compagni di classe, i quali altrimenti potrebbero considerarlo un secchione o un imbranato. Il padre di Lorenzo, nel difendere a oltranza il calcio giocato al parchetto o allo stadio, finisce con il sottovalutare il bisogno del figlio di sperimentarsi in prove che prevedono livelli di abilità sempre maggiori; inoltre, si tratta di prestazioni che possono essere raccontate con orgoglio ai propri amici e che valgono, nella costruzione di UNA BUONA IMMAGINE DI SÉ, molto più di un’uscita allo stadio.
Infine, la chiusura del padre, eccessivamente offeso e preoccupato, sembra renderlo poco ricettivo circa i bisogni e le fragilità che il passaggio dall’infanzia all’adolescenza fa sperimentare; troppo impegnati nella discussione «a favore o contro» i videogiochi, lo spazio per una reale comunicazione sulle difficoltà si riduce e la possibilità di fornire un sostegno alla crescita diminuisce.
«Fai la brava, divertiti con l’iPad»
In aereo, sulla tratta Milano-Bari, una mamma sta accompagnando sua figlia Livia, 3 anni, a trascorrere una vacanza estiva dai nonni, che abitano in Puglia. Livia è una bambina vivace e questo sarà il primo anno in cui rimarrà da sola con i nonni, senza mamma e papà. Madre e figlia sono sedute a fianco di un paio di signori di una certa età; davanti a loro è sistemata una famiglia con ragazzi adolescenti, mentre dietro ci sono adulti che viaggiano da soli, forse per lavoro. La mamma di Livia è un po’ preoccupata che la bambina possa innervosirsi durante il viaggio in cui è costretta a stare seduta e cominci a lamentarsi.
In un primo momento Livia ha mostrato interesse per tutte le novità dell’aereo: ha voluto sfogliare i dépliant e i giornali infilati nel sedile davanti, provare più volte ad aprire e chiudere il tavolino, verificare che cosa ci fosse sotto i sedili, guardare fuori dal finestrino e così via. Poi, durante la fase di decollo, quando non è stato più possibile muoversi, Livia ha cominciato a chiedere un po’ d’acqua e qualcosa da mangiare, e ha tentato di sganciarsi dal sedile. Finalmente, quando è stato possibile slacciare le cinture, Livia si è liberata ma ha cominciato a provare insofferenza per la posizione seduta: ha chiesto di essere accompagnata in bagno, il che ha comportato dover svegliare il signore a fianco, il quale si era appena appisolato; voleva rimanere nel corridoio ma le hostess le hanno detto che non si poteva correre né stare troppo a lungo in piedi; al suo posto voleva continuamente controllare che cosa facevano i ragazzi seduti davanti o le persone dietro: interloquiva, faceva scherzetti, linguacce, ideava le più disparate strategie per evadere dalla fissità e dalla noia dello stare semplicemente seduta e in silenzio.
Dopo averle provate tutte («Non si fa così», «Vieni qui», «Dai, smettila», «Non disturbare», «Guarda che la hostess ti sgrida», «Poi che cosa diciamo ai nonni?», «Ma io ho una brava bambina?», «Se stai buona, ti do una caramella»), alla mamma di Livia viene in mente di proporle di leggerle una storia, ma non ha portato con sé dei libri e così accende il suo IPAD. Immediatamente la bambina smette di agitarsi per concentrarsi sulla nuova proposta, recuperando la posizione seduta e l’atteggiamento tranquillo. Ascolta e osserva con piacere la storia narrata e presentata con coloratissimi disegni sull’iPad della mamma, con una placidità che fa tirare il fiato a tutti quanti. Quando la storia finisce, Livia chiede: «Ancora!». La storia ricomincia e, nel frattempo, l’aereo inizia l’atterraggio…
A qua...